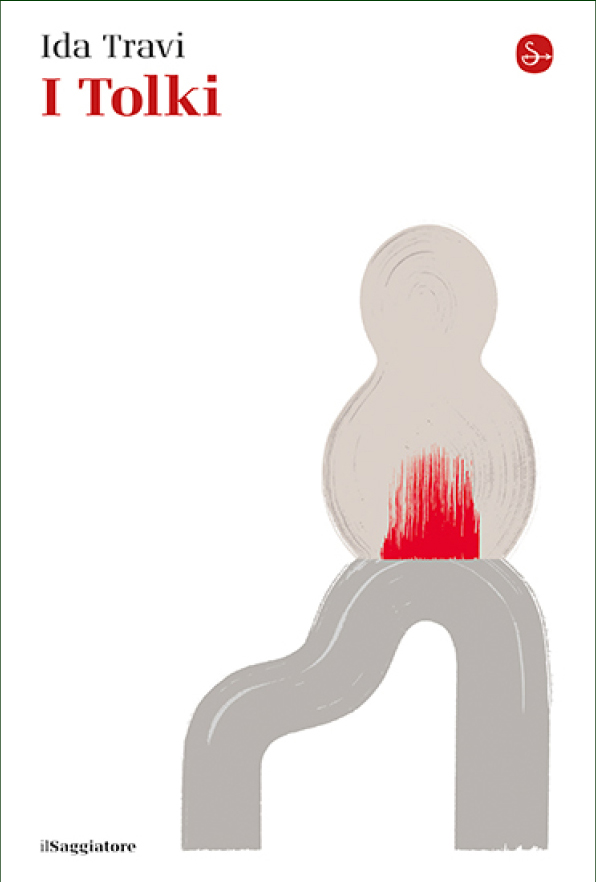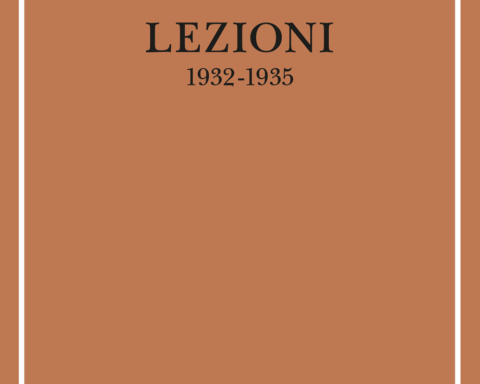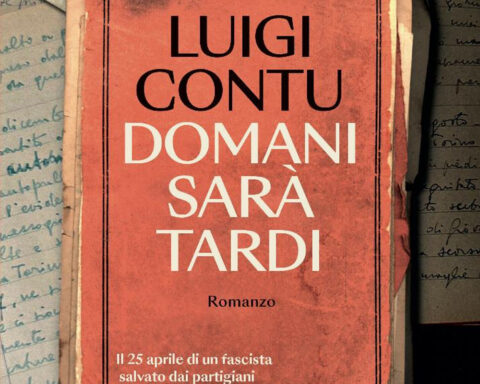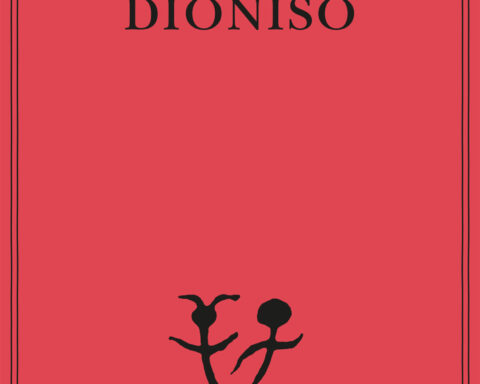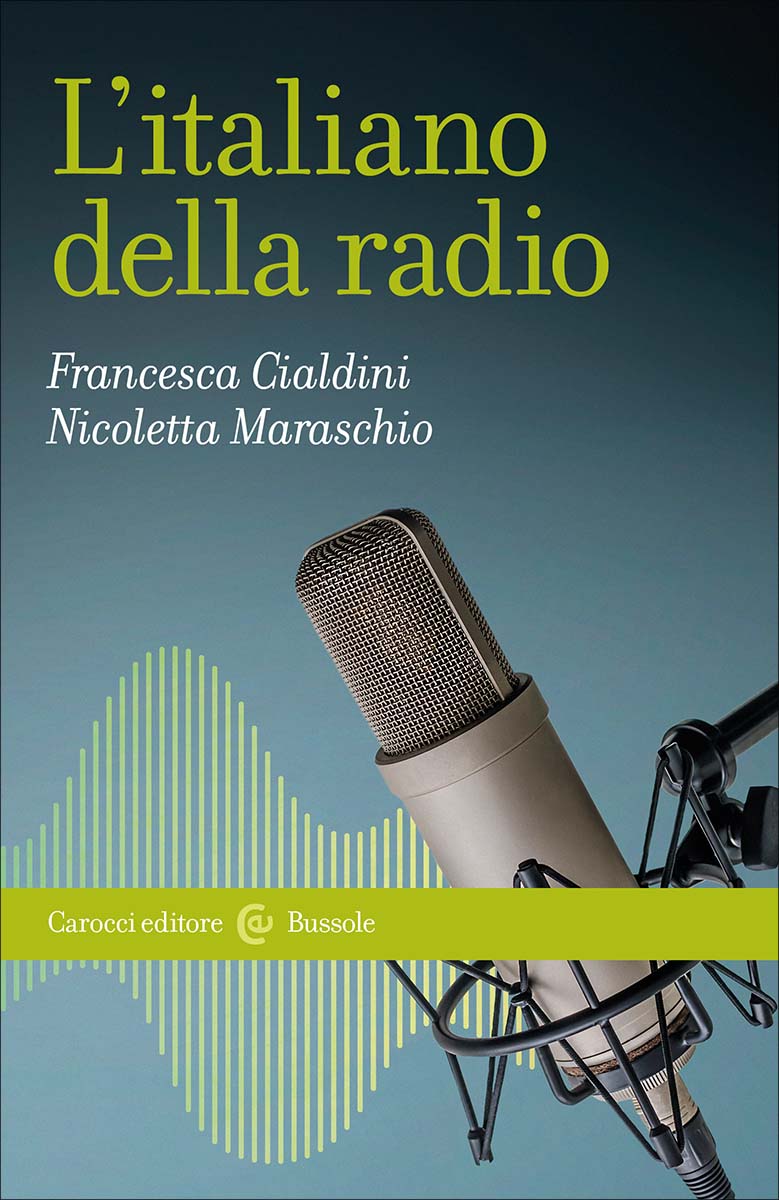Cerca le parole e troverai le immagini.
Nelle squame dei pesci, nei fossi, nelle ali degli uccelli. Dietro le porte dell’ex-ufficio, in laboratorio. Nel sacchetto, nel secchio. Nel libro, nel fiore. E qui. Nell’androne. Qui. Sotto l’albero della decadenza… La terra ritroverà il suo tremore, crescerà l’erba matta. […] Prenderemo le pietre e costruirete la chiesa. Quale chiesa? Una piccola chiesa di sassi, con sei panche di legno, e un piccolo libro dentro… Ma, Dora… la piccola chiesa di sassi fermerà la decadenza?/Noi saremo nuovi, noi vivremo liberi in mezzo alle folate di farina. Ma attenti, attenti… se il libro si sfarina tutt’intorno in un attimo, crescerà la cattiveria… Quale cattiveria? Ida Travi, I Tolki, Il saggiatore, pag. 473.
Ida Travi (Cologne 1948) è una poetessa italiana, autrice di numerose raccolte poetiche, di saggi e testi per la musica e il teatro. Chandra Livia Candiani ha definito “magica” l’opera poetica della Travi. Mariangela Gualtieri l’ha portata in teatro e al cinema. E Il saggiatore la raccoglie in un unico volume per la gioia dei lettori e della poesia. I Tolki sono un libro di autentica e originalissima poesia. Per la prima volta è raccolto in un unico volume il lavoro decennale di Ida Travi. La saga dei Tolki. Come ci informa la stessa autrice nella nota introduttiva, i Tolki iniziano a prendere forma nel lontano anno duemila dieci con la pubblicazione del primo libro: Tà. Poesia dello spirito e della neve. Ne seguiranno altri, qui ricongiunti e fusi in un unico sacro, miserabile, misterioso, semplice, puro, millenario linguaggio dell’essere. Sì, i Tolki sono lingua, idioma dell’essere nel suo dispiegarsi e incrostarsi. Chi è il parlante, se non l’essere che tenta la parola per riportarla alla sua origine di vicino e lontano, di naturale e innaturale, di silenzio e fragore? E ancora, dove si rivelano i parlanti, se non in quel linguaggio povero, scarno, inalterabile e, forse, inaccessibile della poesia? Pensare l’essere è riflettere immediatamente la poesia. Un’entità che dall’essere riceve e alla materia dà. L’essere che si marchia del linguaggio in un idioma, una parlata che segna, che distingue, che insemina la croce dove persistono la colpa e il piede sicuro. “Quel celeste tra noi” e nient’altro. Non basta nominare. Zet, Attè, Olin, Inna, Katrin, Usov, Antòn. I Tolki hanno un nome, ma non per svelare, piuttosto essi occultano, dove c’è chiarezza. – “Da un lato ci sono loro e dall’altro ci siamo noi… Loro chi? Noi chi?”. – E non svelano mai. Perché farlo? L’essere non è una dimensione, ma una bassa cattiveria. È una rondine morta, un insetto tra il pettine, un pesce dagli occhi rossi, una febbre, un tugurio. Una dimora dove l’angelo può arrivare e non portare nulla. O l’annuncio? Una dimora, dove si può trovare dio, o l’oscurità. O si auspica di trovarle entrambe queste parvenze. L’avveduto lo sa. Chi inganna non è il linguaggio, ma il movimento, il tempo, l’ospite. Dalla filosofia, la Travi ha appreso bene queste cose. A un certo punto le incontra inesorabilmente come riflessione costante e linguaggio. “Chiusi i libri di filosofia ho compreso a modo mio in che rapporto stava, per me, la parola con il tempo. E anche con lo spazio. Il rapporto con il tempo ingloba i Tolki in una dimensione perennemente out in uno spazio separato dal tempo. Contro ogni logica, contro ogni relatività. Avevo imparato con Henry Bergson che c’è un’unica posizione della lancetta, delle sue precedenti non resta traccia, mentre dentro di me si attiva quel processo di rielaborazione dei dati che costituisce la vera durata: la coscienza”. Una coscienza che si condensa nel passato. Non esiste, forse, solo il passato? “Il futuro tace, arriva come una nevicata”.
Leggendo questo libro e questi testi da vocabolario minimo, non ho potuto fare a meno di confrontarli con una grande scrittrice francese da poco tradotta da Adelphi e che mi è capitato di recensire. Si tratta di Ines Cagnati. Ricordo giusto qualche titolo in ordine di uscita in Italia. Génie la matta, Giorno di vacanza, e il recentissimo, I pipistrelli. È sorprendente e del tutto misterioso come queste due autrici si somigliano come due gocce d’acqua. Prosa, quella di Cagnati, poesia quella di Travi. Entrambe con un’infanzia contadina. E dovevo trovarlo questo collegamento, perché lo sentivo. Ed eccolo in un’intervista di Anna Toscano a Ida Travi, da dove per altro è tratto anche il brano prima citato: “La mia infanzia si divideva tra la città di Milano e la vita di cascina in un piccolo paese agricolo vicino a Brescia. La scuola era a Milano, ma l’estate la passavo nella laboriosa campagna lombarda, dove vivevo notte e giorno con i maestri contadini. Nel bene e nel male, i miei veri maestri erano loro, contadini e contadine, in quegli anni erano ancora semianalfabeti. Era gente che aveva un rapporto quasi brutale con la natura e gli animali”. Il racconto della Travi, come del resto quello della Cagnati, sembra avere, allora, come sfondo non solo un passato, ma una terra acerba, brusca, implacabile. In loro s’intrecciano brutalità e tenerezza, tormento e astio, angoscia e incanto, e ciò tradotto in una lingua di un’essenzialità sbalordita, stupita ma anche indifferente, distaccata che sembra disperdere la tragicità degli eventi o marcarli ancora di più nella loro nefandezza e bestialità. Una lingua che di là da una semplicità impressionante è una lingua colta e primordiale. Gli antichi greci, scrive Travi nell’introduzione al primo libro riportato in questo volume, con Tà annunciavano la natura plurale delle cose e gli esseri del mondo. E continua: “Ma ora a guardare bene, qui c’è solo neve… c’è solo tanta neve. Per amore della verità abbiamo rinunciato a ogni abbellimento. Mi senti ancora Olin? Tutto è così familiare, tutto è così silenzioso”. Un silenzio che accompagna il libro insieme a un frastuono, a un’eco eccelsa, come se ad arrivare fosse una divinità ellenica (Dioniso?) accordata con un’unica lingua di visione e d’incanto. Di tremore e meraviglia. Di angoscia. “Non date retta a quel che dico/cambiate strada// Sono nata in una stalla/sulla paglia/sotto l’occhio incantato del bue//La luce del mattino/l’alito del mulo sulla faccia/e tenaglie, tenaglie//Il mondo non è meraviglioso/non viene a salutare, niente culla”. Il libro è quest’insieme di pronuncianti e balbettanti. Se ne incontrano di ogni tipo. Tuttavia, sono imprendibili, inaccessibili, minimi. Non è così il linguaggio trasparente? Non è così la casa dove ogni giorno risuona la luce insieme al buio? “No, la casa non sarà demolita, nessuno dovrà più andarsene”. Non è così il libro? Non è così la poesia? Questa inconcludenza che parla, che dice, che inevitabilmente sbaglia? “La pagina è bianca/la pagina è nera/nel libro la nave/è chiamata cavallo”. Nel corso del tempo s’impara a non fidarsi, si apprende perciò il linguaggio. I Tolki sono tante cose che s’incontrano e non si sa da dove vengono. Sono figure senza contorno, come tutte le figure essenziali. Sono il tempo che ha scritto, oltre a Tà Poesia dello spiraglio, anche questi capitoli-libro che formano questo libro eccelso. Un libro che si apre da solo: Il mio nome è Inna – Scene dal casolare rosso, Katrin – Saluti dalla casa di nessuno, Dora Pal – La terra, Tasàr – Anima sotto la neve, Marìe – Canta la famiglia del secolo, MUSCET PARLA COL CANE, Janì – L’ora della cancellatura. Un lavoro, quello della Travi, che s’intuisce come una meditazione lunga e senza scampo, senza protezione. Forse, i Tolki sono un’invenzione retorica. Forse, sono suoni pulsanti o cose realmente accadute. Forse, sono la pagina dell’essere. O forse sono tante cose insieme che sarebbe impossibile elencarle tutte. Ecco, bisogna guardare lontano. “Vedi lontano, Jàn? Vedi lontano? […] La chiave è caduta lì dentro, Jàn/in fondo, in fondo.
Ida Travi, I Tolki, Il saggiatore, pag. 473