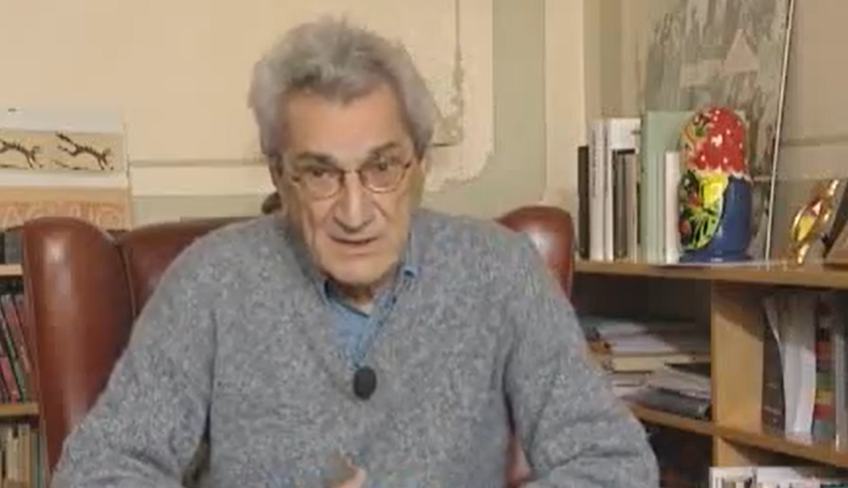A molti sono apparsi gravi e ingiusti gli attacchi che dalla rete continuano a piovere su Gino Cecchettin, il papà della giovane laureanda uccisa dal fidanzato e il cui corpo è stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis, a Pordenone, dopo 7 giorni di angoscianti ricerche. Attacchi gravi per le pesanti accuse formulate (protagonismo, primattorialità, durezza di cuore, calcolo mediatico o socio-politico) e ingiusti per mancanza di concrete motivazioni. Le aggressioni crescono in misura proporzionale alle apparizioni di questo genitore mediatizzato e verboso, che ha scelto l’impegno e la sfida anti-violenza prim’ancora, forse, di comprendere l’enormità del suo dolore. E credo che sia proprio qui, nel passaggio fulmineo, quasi automatico, dalla scoperta del crimine, con il cadavere ancora caldo e non sepolto della figlia, alla scelta della singolar tenzone (contro un mondo violento e una cultura arcaica, individuati come cause di crudeli destini), che si annidi lo smarrimento reattivo di quanti hanno espresso in forme rabbiose il loro plateale dissenso.
Tutta l’umanità ha sempre vissuto il lutto non soltanto come una perdita, ma come percorso di elaborazione del dolore più lancinante che si possa vivere, soprattutto se con la persona scomparsa si era sviluppato in vita un legame intenso. Tant’è che psicologi e psicoanalisti ritengono che più il rapporto è stato profondo con la persona deceduta (i genitori per i figli, in particolare) più appare alto, e non sempre arginabile, lo stress derivante dalla irreparabile e definitiva separazione. C’è qualcosa che precede il lutto – sosteneva il medico e psicologo britannico John Bowlby – e quel qualcosa è la “relazione di attaccamento”. Il lutto si innesta, cioè, laddove si è costituito un rapporto originario con la persona andata via per sempre. Il dolore diventa così specchio di un’intesa radicata ma poi svanita nel nulla: più essa è stata intensa, maggiore sarà la sofferenza per la perdita e più lunga e incerta la durata dell’elaborazione del lutto.
Ritengo che sul volto di Gino Cecchettin non sia stato riconosciuto il segno tragico del lutto, perché da lui cancellato con un mascheramento preventivo rispetto ai tempi della sua comparsa. L’alienazione, lo struggimento che, di fronte a tali tragedie, provocano transiti dolorosi nel tunnel della negazione di sé e della propria storia, prima di poter tentare di riorganizzarsi un’esistenza, in tempi che in genere gli psicoterapeutici misurano in 15/18 mesi, non hanno nemmeno sfiorato Gino Cecchettin. Egli si è rappresentato come colui che si sottrae all’alienazione che in genere consegue a questi traumi, scegliendo la strada dell’omologazione massmediale. È apparso come un padre che si è rifugiato in un attivismo compulsivo e sospetto, impersonando e gestendo l’illusorio potere che da tale scelta deriva. Un’azione, potremmo dire, funzionale al processo di de-identificazione. Dov’è più il padre, avranno pensato in molti? Se c’è, è coperto dalla maschera di opinion leader, si saranno risposti smarriti. È diventato, quel padre scudato da un ruolo, un puro simbolo mediatico, peraltro col corpo di Giulia ancora riposto nei frigoriferi della Medicina legale.
Agli occhi dei suoi denigratori, è come se Gino Cecchettin avesse lasciato il mondo per viverne la descrizione, svuotando il dolore privato e la morte della loro realtà e allontanando artificialmente il limite esistenziale che inquieta l’umanità fin dalla notte dei tempi. Il professor Galimberti, nel suo celebre libro “Psiche e techne”, sostiene che ci si lega alla televisione e alla rete non per disporre di informazioni o per fornirne alcune, ma “per essere al mondo”: «Religione, politica, mercato, guerra, gioia, dolore, morte sono descritti lì – osserva il filosofo – e da lì ognuno apprende come si prega, come si lotta, come si soffre, come si muore…». La telecomunicazione diventa la nostra (falsa) vita, l’ambiente parallelo, il teatro di un mondo che resta inaccessibile nella sua tragica realtà.
Credo, perciò, che quest’uomo sia stato colpito da offese e attacchi perché ritenuto in fuga dal suo ruolo di padre, in fuga da quel dolore che tutti saremmo stati costretti a vivere in condizioni tragiche come le sue. Cecchettin si sarebbe, cioè, declassato a spettatore della propria immagine, riconoscendosi titolare di una terzietà apparsa a dir poco paradossale.
Nell’Antigone, Creonte nega a Polinice la sepoltura, per infliggergli una seconda morte dopo quella biologica, proprio per impedire al lavoro di elaborazione del lutto dei suoi cari di dispiegare la propria portata simbolica e, probabilmente, terapeutica. Gli uomini, infatti, sin dai tempi del mito, hanno tentato di riempire con simbolismi rassicuranti (cos’è, altrimenti, il rito funebre?) il buco nero che si crea nel Reale della loro vita quando la morte rapisce un congiunto.
La rabbia social (e non solo) che ha investito Gino Cecchettin potrebbe alla fine avere come motivazione proprio una forma di punizione. A questo padre confuso, che ha inteso probabilmente ricollocarsi fuori dal mondo doloroso del lutto, non sarà stata perdonata proprio la innaturale “diserzione”, con la conseguenza che le sue ostentate finalità etiche, esposte con lucida rigidità programmatica, sono state anch’esse lette come artificiose. Scelta considerata sbagliata perché soltanto la sofferta esperienza del dolore consente alla persona di arricchirsi e, in qualche caso, di abilitarsi a lavorare per gli altri. Per tali evoluzioni personali occorrono, però, passi lenti, tempi lunghi e ascolti interiori profondi. Le scorciatoie non producono risultati e, se percorse, lasciano tracce labili, orme evanescenti e ambivalenze dialettiche che la gente deplora e respinge come ingiuste provocazioni. Ed è quanto è accaduto all’ingegnoso e ingenuo padre di Giulia.
Tra l’altro, se si decidono sfide in nome di persone care scomparse, occorre dotarsi di una forte responsabilità che va registrata e agita nel tempo: ogni sillaba pronunciata in nome di chi non ha più il corpo dal quale fuoriescono le parole, esige equilibrio e sconsiglia prospettive autoriferite. Diceva Sartre: «È vero che non sei responsabile di quello che sei, ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei.»