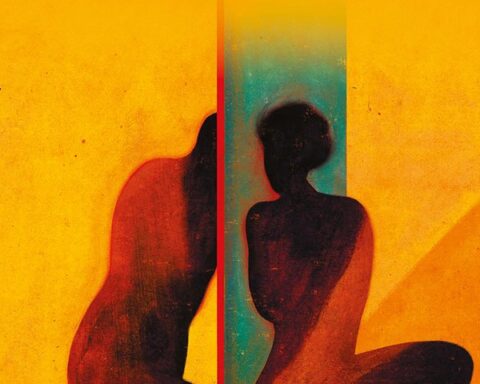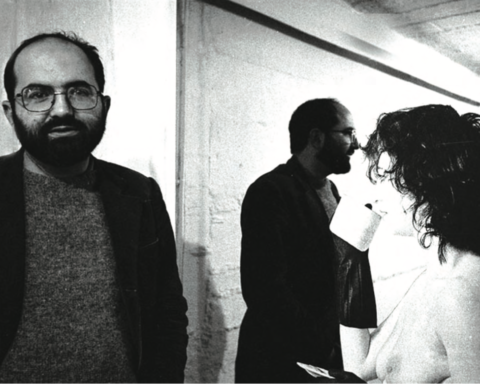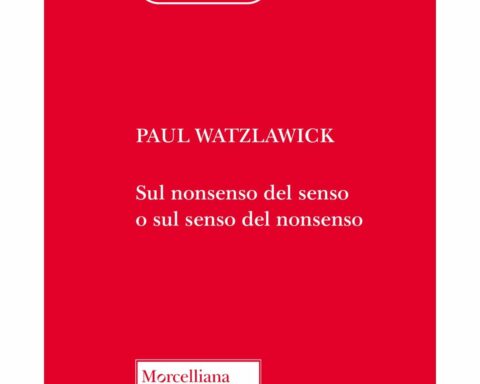Il desiderio umano non è semplicemente una questione di volontà, né si riduce al decidere, al deliberare, all’agire, non coincide neanche e necessariamente con l’atto puro della scelta, né si riduce a mera spinta pulsionale, anche se dalle pulsioni prende forza e carattere di ineludibilità.
E non è neanche, il desiderio, ciò che, pur cercandolo, trovi il suo oggetto da qualche parte.
Come l’Isterica insegna, il desiderio non trova il suo oggetto nella domanda che rivolge all’altro: l’oggetto del desiderio non è mai l’oggetto della domanda, in quanto è proprio il desiderio ciò che dalla domanda viene escluso.
Né il desiderio – come illusoriamente si crede – sembra destinato a ritrovare il proprio oggetto nell’amore, nell’altro dell’amore, che anzi – paradossalmente – oggetto amato e oggetto del desiderio – ed è questo lo scandalo del desiderio – non coincidono mai, tanto che – come gli amanti sanno – l’amore “manca” proprio di ciò che il desiderio cerca, il suo oggetto, essendone l’amore piuttosto la causa: l’amore mette in causa l’oggetto del desiderio facendolo mancare.
Il desiderio allora, è piuttosto una “struttura” soggettiva di “mancanza” radicale, anzi è il soggetto stesso, preso dalla “mancanza” che lo costituisce e lo sostiene, ma che in quanto “mancanza” (“il desiderio è la metonimia della mancanza”, dirà Lacan), in quanto “mancanza ad essere”, lo destabilizza, lo rende incerto, vacillante, e soprattutto non lo garantisce affatto sul soddisfacimento di un ritrovamento, perché quello che il soggetto ritrova non sarà mai quello che avrà cercato e neanche quello che vuole. Sappiamo come, nel nevrotico, per esempio, il desiderio si presenta esattamente come quello che non vuole.
Possiamo tranquillamente dire che il desiderio è quella condizione che cerca soltanto quello che non c’è, vale a dire niente. L’analista questo lo sa bene (o almeno si spera): sa che la domanda dell’analizzante – apparentemente ora di cura, o di aiuto, o di guarigione, o di ascolto, o di crescita, o di questo, o di quello – non è domanda di questo o quello, ma è la domanda stessa, la domanda in sé: “vengo qui perché ho da domandare, ma non so cosa, la mia domanda è di domandare e basta. Non cerco niente e niente lei può darmi, se non ascoltarmi senza darmi niente, perché tanto quello che mi risponderebbe o mi darebbe, non sarebbe mai quello che cerco.”
L’analista è dunque impegnato su un niente da dare: proprio per questo è necessario che si faccia pagare, altrimenti il niente non troverebbe argine, e l’analista, attraverso la frustrazione di quel niente da dare, non sarebbe in grado di arrivare ad essere “colui che fa da supporto alla domanda, non, come si dice, per frustrare il soggetto, ma perché riappaiano i significanti in cui è trattenuta la sua frustrazione” (Lacan, “La direzione della cura e i principi del suo potere”, in Scritti, Einaudi, pag. 164).
A differenza di quello che avviene in tutte le altre situazioni di psicoterapia, l’analista supporta la domanda, ma non vi risponde, perché alla domanda dell’analizzante non vi è nulla da rispondere. Come Freud capì dall’Isterica. Alla domanda del paziente l’analista non risponde perché sa che il desiderio non vuole una risposta: il desiderio, piuttosto, domanda di essere interpretato. Per questo l’analista non risponde alla domanda, la interpreta.
In altre parole, il desiderio è il modo attraverso cui ci poniamo nei confronti della castrazione. È dunque il desiderio una questione etica, che proprio per questo è anche ciò che ci rende singolari, unici e soli, perché rimanda il soggetto all’origine del suo dire soggettivo: “Chi sono?”, “Cosa voglio?”, ma ancor di più, giacché il desiderio cerca il suo oggetto nell’altro, è dall’altro che il soggetto vuole la risposta, e dunque è all’altro che rivolge la domanda: “Cosa vuoi che io sia?”, che è domanda di riconoscimento dell’essere, dell’essere il desiderio dell’altro. Per questo la domanda del desiderio non vuole risposta, vuole essere solo “interpretata”.
Il desiderio è qui ciò da cui origina la domanda che si perde nell’enunciato, facendo del soggetto dell’enunciato un soggetto attraversato dall’enigma, dall’equivoco, dal perturbante.
Il desiderio è ciò che nel dire non può rientrare, ciò che al detto non arriva se non come “mancanza a dire”, ciò che fa “resto” al dire nel soggetto. Un dire che, non trovando le parole per il desiderio di cui pure vorrebbe dire, resta un dire girovago, errabondo e che trova nel suo continuo spostamento su altro la sua struttura. Per questo possiamo dire che se il desiderio è la metonimia della mancanza, la struttura del desiderio è per se stessa struttura metonimica.
Per questo, il nostro desiderio, oltre che essere il desiderio dell’Altro – nelle due formule dell’Altro oggettivo e genitivo – è quella struttura metonimica che – traumaticamente – pone il soggetto sempre nella posizione di desiderare continuamente altro.
E se il desiderio serve all’amore, in quanto trova nell’amore la domanda del desiderio dell’Altro, la domanda di fare, come dice Lacan, esperienza del desiderio dell’Altro, dal canto suo l’amore lascia però continuamente insoddisfatto il desiderio stesso, in quanto l’amore si serve delle parole, e nelle parole il desiderio non può trovare mai il suo luogo.
Se infatti la struttura dell’amore è essenzialmente discorsiva, metaforica, di continuo accrescimento di senso, quella del desiderio è essenzialmente struttura a-discorsiva, di spostamento sempre su altro, è struttura metonimica, di continua sottrazione di senso.
Se l’amore è unitivo, discorsivo, e pretende la certezza e la stabilità dell’ancora, il desiderio è erratico, inquieto, fuori senso e fuori discorso.
L’amore è dell’ordine del dicibile, laddove il desiderio è dell’ordine dell’indicibile. Per questo, come abbiamo visto, non è l’amore il luogo della soddisfazione del desiderio, ma quello della sua continua causazione.
Il desiderio è invece il luogo della insoddisfazione radicale del soggetto, e l’amore il discorso che si intreccia per accoglierla e permettere agli amanti di arrivare ad amarsi pur scambiandosi quello che non hanno, mancanza, niente e a patto di tollerare il continuo errare del desiderio da un altro all’altro.