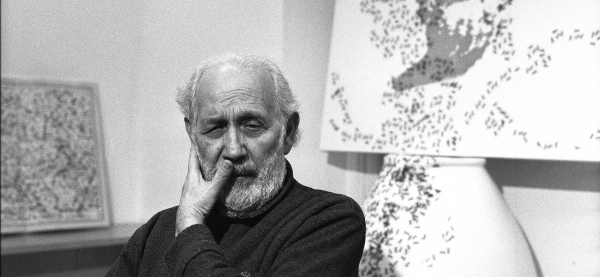Rino Mele nasce il 4 febbraio 1938. Tra i suoi libri di poesia, Separazione di sera, Sottotraccia,1994; L’incendio immaginato, edizioni 10/17, 2000: ed è la storia di Giordano Bruno, la sua lucente visione; Il sonno e le vigilie, Sottotraccia, 2000 (il genocidio e l’oltraggio tra Hutu e Tutsi nello Zaire); Il corpo di Moro, edizioni 10/17, 2001 (ripubblicato in seconda edizione nel 2018, con testo critico di Niva Lorenzini), edizioni Oèdipus; I dolorosi discorsi, ed. Sottotraccia, 2003; La lepre del tempo e l’imperatore Federico II, Sottotraccia, 2004. Costruzione della rima, Plecticá, 2010; La dolce apocalisse, Plecticá, 2011; Il silenzio nudo, edizioni La luna, 2012; Un grano di morfina per Freud, con l’introduzione di Gillo Dorfles, edizioni Manni, 2015, in cui – partendo dalle radici della Seconda Guerra Mondiale, “Vienna diventa tedesca, si sveglia diversa / quella mattina del 13 marzo 1938 che non è ancora / primavera” – la poesia e la storia mostrano di riconoscere la comune appartenenza a un ineludibile strazio (Premio Viareggio Poesia 2016, terna finale).
Poi, un libro di poesia sulla poesia e le sue lucenti radici, Futuro anteriore del verbo precipitare, Manni, 2021.
Insieme a Dacia Maraini ha scritto Montagne pensose, dialogo sulla poesia, ed. D’Amato 2023.
Infine, dal 2009 dirige Exmachina, Fondazione di poesia e storia.
Poesia per archi e pianto
Sono infissi sul banco i pennini,
tremano
sotto le dita, è il suono
dell’organo ferito, il muggito
lieve dell’animale fuggito alla torma
di ignudi che con forche
e spade vuole straziarne la vita.
Sulla neve la traccia
è nera come quella della matita.
Mi piace pensare a Carlo
Villa bambino, il suo raccontare
la poesia,
la foresta che l’incendio trasforma
e il piede s’arresta
in quella stravagante striscia
stretta come un canale,
la cintura di una dea tra la neve
e il lontano bruciare.
La fiamma precipita e s’apre,
sono le campane, le navate
larghe, gli angeli
alti sulla testa dei santi,
le ali del colore delle rose
murate, il labirinto dei petali,
lo sperdersi in quell’odore,
vedere il sole notturno e l’alba
che danza nel sonno della grazia.
Chiudeva nei quaderni
le linee curve
di un aggressivo amore,
quelle diritte della ragione,
disegnava grandi alberi
senza foglie, e lontano il mare.
Quanto dolore scordarsi
l’infanzia e farla tornare, il gioco
alterno della fatica,
spostare l’onda che si gonfia
nuova sul remo, infinita.
I gatti feroci miagolano, li senti
di notte e straziare
aspri come in un film
della Resurrezione, si contendono
i topi nella scatola di cartone.
[Rino Mele, I dolorosi discorsi, Sottotraccia, 2003]
La bicicletta di Moro
Sul letto un lenzuolo, una coperta
militare,
vorrebbe camminare, piano,
ad Ostia, sentirsi i piedi scalzi
bagnare
dall’onda che stordisce, e risale
il suo petto scavato,
il ventre intristito, le mani
lunghe come sciogliesse un nodo
che non si lascia slargare. Quale
tortura
dormire le notti di maggio di quel
suo ultimo
anno. Si distendeva piano,
chiudeva gli occhi e come un ciclista
pensava la sua vita, una salita
impervia,
la bicicletta ferma, l’ansimo di uno
stentato
respirare, quell’asma
pungente che travaglia il respiro,
quasi il mare
dall’alto stesse per precipitare.
Sognava
un muro di pietra, la pagina
di un abecedario sporca d’inchiostro,
i colori
sbiancati, “b” è la bandiera,
“r” la rivoluzione, “c” la canzone,
ma non riesce a ricordare
i versi di nessun canto, sente solo
un lamento,
i poliziotti uccisi, la madre, il vento
che urla le scale. Ricordava i volti e
li vedeva
morti, i potenti sembravano risorti
alla rovescia, la testa in giù,
le braccia
aperte, le lunghe radici dei piedi,
il guizzare
stanco. Dormiva in una folla
vestita di nero, gli uomini calvi, le
donne
dai capelli rossi, i bambini
di plastica sepolti. Sentiva il suo
corpo
diviso, distratto in più parti,
il capo
posto sul cuscino, le braccia
per terra, il cuore stretto tra le mani,
che spremono il sangue in un
bicchiere.
Poi, svanendo
si ricompone, le gambe sono la figlia
Anna
a destra, e la sinistra è Agnese
(quella del cuore), le braccia
tornano leggere al loro posto, il collo
regge
la testa distrutta dalla sabbia,
la voce
è un sibilo lieve di uccelli. Ora
è fermo. Dal sonno
in un più duro sonno, di margine
in margine annega
come pioggia che in altra si perde.
[Rino Mele, Il corpo di Moro, edizioni 10/17, 2001; seconda edizione Oèdipus, 2018]
Lo scuro silenzio della poesia
Dall’inesprimibile ci stacchiamo
nascendo.
Resta, per sempre, l’urgenza
di scambiare il nostro volto con la
terrificante
bellezza di quel feroce richiamo.
Coi suoi piedi leggeri
sul ritmo delle parole – le povere
rime – la poesia cerca la pena
di quel suono,
fa un passo, si ferma, tace,
riprende a danzare
come tra i morti,
quando possono ricordare.
Un faticoso tornare è la poesia,
il doloroso
cercare gli stagni notturni, il mare
di nebbia
della violenza da cui immemori
siamo nati.
Risalire fino alla sorgente sigillata
dal nero silenzio.
Poesia è sfuggire alla parola consumata,
non il complice ascoltarsi, ma dire
lo strazio
di pensare, farsi male
nell’avvicinarsi alla più interna voce
di quel buio
che vorremmo dimenticare.
Poesia è questo tornare
dove non c’è riparo dalla colpa, in
una pianura di neve,
andare, pensando
d’essere morti, incontro a chi ti assale
e continuare
a dissigillare il silenzio in altre
tenebre
dentro cui aspramente qualcuno
ti guida: sei tu,
con la voce di tuo padre ancora in vita
(come l’acqua si dirupa,
secondo la forza che la stringe
e disperde,
la vuota maschera quotidiana dice
l’incerto pensiero
che sembra nascere dalla voce, come
quando l’ombra
precede il corpo che la produce).
Legato alla nascita, il poeta trattiene
le ferite
di quelle scale,
le ripercorre al contrario, stretto
alla bocca materna
che l’azzanna.
Scrive
secondo un ritmo penitenziale, perché
non c’è scampo
al male.
Il fischio ossessivo del merlo
che il cacciatore uccide sul burrone.
[Rino Mele da “Poesì”, rubrica settimanale di poesia su Agenzia Radicale, 24 marzo 2020]
Il sogno, il gioco e la poesia
Quando ricordiamo un sogno – a differenza di quanto credeva Freud con la sua geniale e rivoluzionaria ricerca del 1899 – le immagini bianche che abbiamo sognato sono forse solo la traduzione delle parole originarie che siamo riusciti a trattenere col nostro desiderio: quella traduzione – svegliandoci – diventa racconto, lo spasmo ripetuto di quella voce che non potremo mai avere di fronte a noi, perché continua a generarci: a lasciarci nell’abisso: i sentieri della notte sono così stretti da diventare muri, la scala di pietra impedisce a chi scende di risalire. Il sogno che maschera la voce originaria non si oppone al reale, del reale ripete la dolorosa banalità.
Sogniamo quello che già sappiamo, muovendoci tra girevoli porte (parlai, per la prima volta della parola che nel sogno precede l’immagine nel mio “Scena oscena”, Officina edizioni 1983).
Solo la poesia tenta di fare, di un urlo disperato, la linea astratta disegnata da una matita, il sentiero che sta sempre alle tue spalle e hai percorso già per intero, nascendo.
Il bambino gioca come sognasse,
supera un dirupo volando,
pensa a un cavallo,
ora è lui a nitrire
correndo.
La madre è una nube,
piange
nel cercarlo: la voce
che lo chiama è vestita
come una sposa o una notturna
rosa. Il gioco riproduce
il rovescio del sogno, e l’uguale,
ma è più crudele:
non ti puoi svegliare.
Anche il gioco è un sognare
ma in due, e non sai mai
chi sia l’ombra
che si sottrae. La poesia
ha memoria del sogno
e del gioco,
ne sorride,
sa che deve svelare
l’assurdo girare tra gli astri,
la caduta improvvisa,
l’incendio
che torna e somiglia alla neve.
[Rino Mele, “Cronache” 28 luglio 2024, rubrica a giorni alterni, a pagina 1 e 11]
Lo stupore e la morte
Siamo l’insetto senz’ali che
un ragazzo tortura,
l’ali
che strappa e taglia
col familiare trincetto, il
taglierino dalla scorrevole
lama per appuntire
la matita.
Siamo noi il piccolo uomo
di quell’inconsapevole
infanzia:
ora ha pulito col braccio
la superficie del tavolo,
spostato
la gomma, lo stick
della colla
e, infine – scostando i libri
importuni
di algebra e di poesia –
inizia
l’opera che l’appassiona:
straziare,
staccare l’esili zampe, l’ali
trasparenti,
lievemente innervate, vedere
il non più riconoscibile insetto,
l’azzurra mosca
aspettare
il finale disconnettersi
di tutto,
che è la morte,
l’afono stupore delle tenebre.
[Rino Mele, versi inediti scritti il 4 settembre 2024]