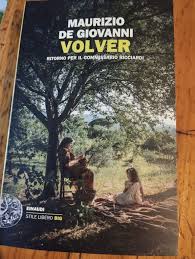Siamo assuefatti al dolore, alla morte, alla sofferenza. Non tutti, certo. Minoranze attive sono ancora in movimento, ma non riescono – almeno per ora – a incidere. La resa è etica ed emotiva, prima ancora che politica.
Mettiamo in fila qualche dato di cronaca.
Una bambina di undici anni viene ritrovata, sola, tra le onde, nel Mediterraneo. Viene salvata. Diventa per un giorno notizia di cronaca. Segue qualche dubbio sul suo racconto. Fine. Nessuna reazione pubblica.
Israele bombarda scuole, ospedali, file di persone in attesa di cibo. Lo fa da oltre un anno. Tutto questo diventa un insieme di notizie di cronaca. E, poi, una lista di commenti, spesso sul tema – del tutto, inopportuno – sull’antisemitismo. Fine. Poche reazioni pubbliche, alcune manifestazioni locali e nazionali. E quando queste ci sono – come nella primavera scorsa – vengono ricoperte di ingiurie sui loro caratteri antiebraici, spostando il fuoco dalla realtà, cioè dalle decine di migliaia di morti e feriti lasciati sul campo dall’esercito israeliano.
Militari della Nato e alti dirigenti politici europei esprimono quasi ogni giorno un parere sulla necessità di prepararsi alla guerra. Lo fanno con interviste e dichiarazioni, spesso in maniera velata, altre volte in maniera del tutto esplicita. In Svezia è stata data la notizia il 15 dicembre scorso secondo cui il paese sarebbe alla ricerca di un luogo per ospitare 33.000 tombe destinate ad altrettanti soldati. Anche in questo caso, le notizie arrivano e passano inosservate. In assenza di una reazione pubblica.
La lista potrebbe continuare, andando anche a ritroso nel tempo degli ultimi anni, scanditi da migliaia di morti nel Mediterraneo, dalle notizie sulle torture nei centri di detenzione libici e i relativi accordi per trattenere le persone in fuga tra Libia e Italia, dalle sofferenze patite dalla popolazione ucraina. E anche qui, fatta eccezione per minoranze attive e combattive, le reazioni pubbliche o sono state assenti o, addirittura, come i risultati elettorali mostrano, premiando l’estrema destra anti-immigrazione in più stati europei (Italia compresa), sono state a sostegno delle politiche di chiusura, da un lato, e di riarmo, dall’altro.
Il riarmo è la risposta alla crisi etica – oltre che politica, economica ed ecologica – in corso. È la via più breve: vince chi è più forte. E per chi soccombe restano il terrore o la sofferenza. Di fronte a questo bivio senza speranze chi può scegliere cosa fa, cosa può fare se non allearsi con il più forte, con chi garantisce la salvezza. Ovviamente, a discapito di chi annega.
Dentro questo schema non può che esserci assuefazione alla sofferenza e alla morte degli altri, semplicemente perché quegli altri sono, appunto, altri, con un tasso di umanità inferiore, sacrificabili e, se è necessario, da sacrificare. L’assuefazione, in questo contesto, diventa una scelta, un atto politico: è la decisione di stare con chi vince, anche se questo vuol dire lasciare gli altri che perdono all’inferno. È, per usare un concetto del filosofo Achille Mbembe, la definizione di un ordine necropolitico: quello che l’antropologa Rita Segato ha chiamato la fase apocalittica del capitalismo.
C’è, dunque, spazio solo per la disperazione dei rapporti di forza in vigore? Il realismo ideologico farebbe rispondere in modo affermativo: non ci sono alternative. La storia ci insegna che non è necessariamente così. La richiesta di giustizia può sempre irrompere nella vita di ognuno così come nella società più ampia. Certo, questa richiesta va alimentata. Va nutrita anche con delle prospettive a cui dare un nome. La giustizia ambientale è una di queste, ma va rafforzata. Così come lo è quella che rivendica la libertà di movimento per le persone: unica via davvero concreta per evitare che le persone continuino a morire nel Mediterranei o lungo le altre cosiddette rotte migratorie. Si tratta di prospettive da approfondire, ma sono sempre più necessarie per ritornare a dare senso alla vita di tutti e combattere l’ipotesi di un mondo fondato sul principio dell’apartheid.