Tre processi, otto gradi di giudizio e una raffica di giudicati che hanno disegnato il quadro di una joint venture tra Cosa Nostra e neofascismo, con un ruolo complementare della camorra. Tuttavia, alla storia giudiziaria della strage del Rapido 904 Napoli-Milano – 16 morti e 267 feriti l’antivigilia di Natale di quarant’anni fa per lo scoppio, in una delle carrozze del convoglio, di diverse cariche di esplosivo sotto la grande galleria dell’Appennino, a poca distanza dalla stazione di Vernio – mancherebbero sia il movente vero, o per lo meno completo, sia il reale regista dell’attentato.
Il mandante numero uno. Totò Riina, capo della cupola di Cosa Nostra. Già assolto in primo grado, e successivamente “graziato” da un cavillo di legge che, allungando i tempi del processo d’appello, probabilmente gli risparmiò l’ennesimo ergastolo prima che passasse a miglior vita.
Partiamo dalla coda, perché rappresenta il tratto più controverso di una vicenda che ha conosciuto diverse riscritture giudiziarie. Ai due procedimenti celebrati tra il 1987 e il 1994, che nei diversi gradi di giudizio (quattro per il primo, tre per il secondo), si erano conclusi con verdetti che avevano delimitato il perimetro di una perfetta convergenza di interessi criminali tra Cosa Nostra e esponenti della estrema destra eversiva con la partecipazione di un clan della camorra napoletana, se ne affiancò un terzo nel 2014 che, senza mettere in discussione le certezze fin lì acquisite, si sforzava di allargare il campo dei possibili moventi. Unico imputato, il padrino di Corleone.
Opera di sviamento
con un’attenta regia
L’inchiesta, tendente a risalire al vertice della catena di comando che aveva ordinato il massacro sul treno di Natale, era stata avviata tra l’autunno e l’inverno del 2010 dalla Procura distrettuale antimafia di Napoli. Gli inquirenti partenopei erano partiti dalla considerazione che il vero mandante e il movente autentico della strage non fossero emersi in sede giudiziaria per una sapiente opera di “sviamento”, secondo la definizione del procuratore aggiunto Sandro Pennasilico, costruita attraverso una regia attenta e meticolosa. Quella del capo dei capi di Cosa Nostra, che alla fine di aprile del 2011 fu raggiunto dietro le sbarre da un’ordinanza di custodia cautelare come mandante dell’attentato.
La nuova tesi investigativa si fondava sulle rivelazioni di Giovanni Brusca, secondo il quale era stato Riina a ordinare la strage per distogliere l’impegno dello Stato dalla lotta alla mafia verso il terrorismo eversivo, ma anche per esercitare “una sostanziale forma di ricatto, al fine di indurre i referenti politici dei corleonesi ad intervenire efficacemente per condizionare l’andamento del maxi processo”. “L’organizzazione – riferì Brusca – seguiva una precisa strategia che si muoveva su più piani. Vi era quello giudiziario, ovvero il sistematico tentativo di aggiustamento dei processi, e poi vi era il piano puramente militare”. “Un’ulteriore strategia tipica di Cosa Nostra – aggiunse il boia di Capaci nel frattempo diventato collaboratore di giustizia – [era] sempre stata inoltre quella dell’inquinamento probatorio, nel senso che Riina in tutte tali vicende ha sempre cercato di coinvolgere in qualche maniera entità estranee per depistare le indagini”.
Un tentativo di bloccare
la forte offensiva antimafia
I pubblici ministeri partenopei Sergio Amato e Paolo Itri furono costretti da una decisione della Suprema Corte a rimettere, per incompetenza territoriale, il fascicolo ai loro colleghi di Firenze. I quali, al termine delle indagini preliminari, chiesero, e ottennero nel maggio del 2014, il rinvio a giudizio di Riina come unico mandante della strage. In questo terzo procedimento la causale dell’attentato non divergeva ma semmai completava quella individuata nei processi precedenti. Se la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello di Firenze, per ben due volte e con l’avallo della Cassazione, avevano circoscritto la strage alla sinergia criminale venutasi a creare tra mafiosi, camorristi e neofascisti per prolungare, ben oltre il suo declino, la stagione della cosiddetta “strategia della tensione” nell’ambito di un più generale e generico progetto di destabilizzazione dell’ordine democratico, quasi una coda degli anni Settanta, il nuovo processo incardinato nel mese di novembre del 2013 aggiungeva altri elementi, basati sulle diverse cognizioni maturate dopo la stagione stragista di Cosa Nostra della prima metà degli anni Novanta. In primis, la determinazione della cupola mafiosa a fermare l’offensiva dello Stato in Sicilia, che proprio in quel 1984 si era intensificata con la raffica di arresti scaturiti dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta, che avrebbero costituito poi la base del primo, storico, maxiprocesso di Palermo istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
La strage del treno di Natale, in questo quadro, sarebbe stata l’anello di congiunzione tra due stagioni del terrore temporalmente contigue ma diverse, con un punto di convergenza nell’attacco alle istituzioni repubblicane. E con il braccio politico, la destra estrema, che trovava nella conversione in senso terroristico di Cosa Nostra un canale per ribadire la propria ostilità verso lo Stato democratico nato dalla Resistenza.
Si muoverebbe su questa traccia anche una nuova, recentissima, indagine aperta dai sostituti procuratori di Firenze Luca Tescaroli e Luca Turchi, a proposito della quale si sono registrate alcune indiscrezioni giornalistiche lo scorso mese di febbraio ma della quale si sa ancora molto poco, se non che l’esplosivo utilizzato per far saltare il treno di Natale fu lo stesso poi rivenuto in due arsenali mafiosi, in contrada Giambascio e a San Giuseppe Iato, scoperti dopo gli attentati degli anni ’90. Gli inquirenti avrebbero rilevato anche una similitudine tra i telecomandi utilizzati per l’attentato al Rapido 904 e la strage di via D’Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta, avvenuta otto anni dopo. Infine, seguendo il filo dell’esplosivo, i due pubblici ministeri avrebbero acceso un faro anche su altri misteri fiorentini non chiariti: l’esplosione che distrusse una palazzina – senza vittime – in via Toscanini, il 5 novembre del 1987, e un attentato a un ufficio postale in via Carlo D’Angiò, il 13 agosto 1985. In entrambi gli episodi la stessa miscela usata sul treno e dalla mafia.
Altre losche impronte
oltre quelle mafiose
Le nuove acquisizioni investigative promettono di ribaltare il verdetto di primo grado con cui il 13 aprile 2015 la Corte d’Assise di Firenze assolse Totò Riina dall’accusa di aver ordinato l’attentato sul treno, nonostante al termine della propria requisitoria il Pm Angela Pietroiusti avesse chiesto la pena dell’ergastolo. “Non può escludersi”, scrissero i giudici in quella circostanza, che nella decisione, organizzazione ed esecuzione della strage del Rapido 904, oltre a quelli della mafia “abbia trovato coagulo un coacervo di interessi convergenti di diversa natura”. Ma dei pentiti ascoltati in aula, sottolineò la Corte, “nessuno ha avuto conoscenza” che la strage fosse riconducibile “a un mandato, istigazione o consenso di Riina”. L’attentato del Rapido 904, fu la spiegazione, “indubbiamente giovava alla mafia, ma non ne recava la tipica impronta” perché la strage colpì in maniera “feroce e del tutto indiscriminata inermi cittadini” secondo “una logica squisitamente terroristica”. “L’evoluzione storica – si trova ancora scritto nelle motivazioni dell’assoluzione – pare smentire qualsiasi linea di continuità strategica” fra la strage di Natale e quelle mafiose del biennio 1992-1994, rivolte contro nemici di Cosa Nostra, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, o contro i beni artistici, per dimostrare “la vulnerabilità” dello Stato” e “costringerlo a scendere a patti”.

Quel verdetto si sarebbe trasformato di fatto in un giudicato per l’intervenuta morte del reo, che impedì due anni dopo la definizione del giudizio di secondo grado nato dall’impugnazione da parte della Procura antimafia fiorentina. Ad allungare i tempi del processo d’Appello, alle cui udienze Riina, ormai 87enne e in pessime condizioni di salute, partecipò in videoconferenza dall’infermeria del carcere di Parma in cui era rinchiuso, concorse la richiesta della difesa della riapertura dell’istruttoria dibattimentale, per l’escussione di sei tra collaboratori di giustizia e boss di Cosa Nostra, tra cui lo stesso Brusca. L’istanza fu presentata quando ormai i giudici della Corte d’Assise d’Appello dovevano solo emettere la sentenza, nel giugno 2017. Ma, alla ripresa del dibattimento il 4 settembre successivo, ci fu il colpo di scena che avrebbe calato la pietra tombale sul processo. La decisione, cioè, di ricominciare tutto da capo e il rinvio a data da destinarsi per l’imminente pensionamento del presidente della Corte, Salvatore Giardina. Nei fatti non ci fu più tempo per risentire tutti i testimoni ascoltati in primo grado, oltre alle nuove testimonianze dei sei boss, perché Riina morì due mesi e mezzo dopo, il 17 novembre.
La scomparsa del boss dei boss da innocente, sebbene riconosciuto dopo un solo grado di giudizio, consegnava alla storia i verdetti degli altri due processi.
Altri due processi
E compare la camorra
Il primo scaturì dall’indagine condotta dal procuratore di Firenze all’epoca dell’attentato, Piero Luigi Vigna, successivamente, tra il 1997 e il 2005, Procuratore nazionale antimafia. L’inchiesta del magistrato toscano partì dai legami esistenti tra il neofascismo napoletano e un esponente di vertice della camorra del centro storico partenopeo, il boss del rione Sanità, Giuseppe Misso, all’anagrafe erroneamente registrato come Missi, fin da giovane militante nelle organizzazioni extraparlamentari dell’estrema destra, all’interno delle quali aveva stretto rapporti con Massimo Abbatangelo, esponente di spicco del Msi-Dn napoletano, deputato di quel partito per quattro legislature consecutive, dal 1979 al 1994. Quando scoppiò la bomba Abbatangelo era alla sua seconda legislatura da deputato, membro della XIII Commissione permanente, Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione: era stato eletto alle Politiche di un anno e mezzo prima con 46.445 voti, terzo della lista della fiamma tricolore nella circoscrizione Napoli-Caserta.

Al clan Misso faceva riferimento Carmine Esposito, ex poliziotto neofascista, fin dagli anni Sessanta iscritto all’organizzazione di estrema destra “Avanguardia nazionale”, anello di congiunzione tra quegli ambienti e la camorra del centro storico di Napoli in quanto intimo di Umberto Misso, fratello di “Peppe ‘o nasone”. Qualche giorno prima del 23 dicembre del 1984, Esposito aveva anticipato la strage ai suoi colleghi della Questura di Napoli: “Ce fanno ‘ntussecà Natale” avrebbe detto ad altri agenti. Uno dei quali, Fabrizio D’Aponte della Digos napoletana, anni dopo in sede dibattimentale raccontò di aver appreso dal suo collega militante della destra estrema che l’attentato doveva servire a “deviare l’attenzione delle forze dell’ordine” per permettere il rapimento di un uomo politico, presumibilmente Antonio Gava o Vincenzo Scotti.
In sede d’indagine, la “confidenza” di Esposito costituì la chiave di volta che aprì scenari inaspettati, anche se non del tutto inediti nella storia dei rapporti tra il crimine organizzato napoletano e il terrorismo di matrice politica, sia nero che rosso.
L’eversione di destra
al centro del racconto
L’indagine s’inoltrò nei vicoli della Sanità, dove furono fermati due luogotenenti di Misso: Carmine Lombardi, l’uomo che avrebbe materialmente portato l’esplosivo alla stazione di Napoli, e Lucio Luongo. Nel frattempo, un altro affiliato all’organizzazione criminale ristretto nel carcere di Poggioreale, Mario Ferraiuolo, nell’intraprendere il proprio percorso da collaboratore di giustizia, consegnava agli inquirenti una rivelazione che dava un senso preciso alle prime intuizioni investigative.
Il neo pentito riferì di diverse riunioni del clan a cui aveva partecipato anche Abbatangelo, aggiungendo che, ai primi di dicembre del 1984, una ventina di giorni prima della strage, il deputato missino aveva consegnato a Misso un pacco contenente esplosivo e un discreto numero di detonatori. Lombardi non ebbe il tempo di essere ascoltato sul punto, perché fu ammazzato dai sicari di un clan rivale, ma Luongo, più volte interrogato dai magistrati fiorentini, confermò in pieno il racconto di Ferraiuolo.
Sin dall’inizio sia i neofascisti che i camorristi napoletani furono ritenuti decisivi nella preparazione e nell’organizzazione dell’attentato, ma non all’altezza di averlo ideato, soprattutto i secondi. La svolta arrivò dall’arresto, a Roma, di un quarantenne “quadro intermedio” di Cosa Nostra, un “colletto bianco”: Guido Cercola, considerato il braccio destro di Pippo Calò, il cassiere della cupola mafiosa che aveva eletto stabile domicilio nella Capitale per i suoi rapporti con la Banda della Magliana. A incastrarlo, il ritrovamento in alcune sue pertinenze di un autentico arsenale: radiocomandi compatibili con quelli usati per la strage, detonatori, cariche di tritolo, panetti di esplosivo Semtex H. Lo stesso utilizzato sul treno di Natale.
L’indagine di Vigna sfociò, nel mese di ottobre del 1985, nell’incriminazione di Calò come mandante della strage e in 22 ordini di arresto per altrettanti esponenti del clan Misso, ma solo per reati di camorra; il capoclan, tuttavia, ricevette una comunicazione giudiziaria anche in riferimento alla strage del treno. A distanza di qualche mese, analogo provvedimento venne notificato a Massimo Abbatangelo. A gennaio del 1986 il procuratore fiorentino spiccò sette mandati di cattura per la strage: i provvedimenti raggiunsero Pippo Calò, Guido Cercola e Franco di Agostino per il gruppo romano, Giuseppe Misso, il suo braccio destro Giulio Pirozzi, Alfonso Galeota e Antonio Rotolo per quello napoletano. Dall’indagine era emerso che entrambi i gruppi mantenevano rapporti costanti con l’eversione di destra, nel caso del gruppo Calò mediati dalla Banda della Magliana. Strage, attentato con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale, fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo i reati contestati ai sette.
Parlando con i giornalisti dopo l’emissione dei mandati di cattura, il braccio destro di Vigna, il sostituto procuratore fiorentino Raffaele Cantagalli, affermò: “La mia impressione è che abbiamo messo le mani su un groviglio di vipere, e che ne abbiamo tirata una per la coda”. Una frase che forniva il senso della complessità del quadro di responsabilità s’intravedeva dietro la strage. A quel punto, per ammissione dello stesso Cantagalli, l’inchiesta sulla strage del Rapido 904 constava di 74 faldoni, con decine di migliaia di pagine: interrogatori, intercettazioni, rapporti investigativi.
Vigna: vollero annullare
la democrazia del Paese
Per Vigna, la strage sarebbe stata il frutto di un intreccio di interessi, di mafia, camorra e destra eversiva, e finalizzata a “distogliere l’impegno della società civile dalla lotta contro la mafia”, producendo un “blocco del paese sulla via della democrazia”. Il procuratore fiorentino ipotizzava “una pluralità di valenze” dell’attentato di Natale, frutto del legame tra settori di Cosa Nostra, clan napoletani, neofascismo, a cui si aggiungeva anche la Banda della Magliana. Ma sulla strada dei giudici impegnati a ricostruire le responsabilità della strage, si materializzava per la prima volta Corrado Carnevale, presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione, che su ricorso dei legali degli arrestati, fece cadere l’accusa di associazione sovversiva. Non sarebbe rimasto l’unico intervento sull’iter processuale della toga palermitana, definito dai giornali dell’epoca “il giudice ammazzasentenze”.

Il primo processo davanti ai giudici della Corte d’Assise di Firenze traeva origine dalla sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio emessa il 3 novembre del 1987 dal Giudice istruttore Emilio Gironi; qualche mese prima, il 7 luglio, lo stesso giudice aveva stralciato la posizione di Abbatangelo, che intanto non era stato rieletto alla Camera alle Politiche di un mese prima. Arrestato nell’autunno del 1988 perché non più protetto dalle guarentigie previste per i parlamentari, sarebbe uscito un anno dopo dal carcere di massima sicurezza di Bellizzi Irpino perché proclamato eletto dalla Camera il 24 ottobre di quell’anno in sostituzione del deputato missino napoletano Antonio Mazzone, che si era dimesso per tirarlo fuori dalla cella. Quando rimise piede a Montecitorio dopo la scarcerazione, Abbatangelo inaugurò una lunga serie di primati molto poco onorevoli, essendo stato rinviato a giudizio quando era ancora detenuto, a maggio del 1989, per l’attentato al Rapido 904: era la prima volta, nella storia della Repubblica, che nei banchi del Parlamento sedeva un imputato per strage.
La maxi ordinanza del giudice Gironi del 1987 aveva disposto il rinvio a giudizio di 11 imputati. Per strage, associazione sovversiva, fabbricazione e detenzione di esplosivo, si mandavano a processo Pippo Calò, Luigi Cardone, Guido Cercola, Franco D’Agostino, Alfonso Galeota, Giuseppe Misso, Giulio Pirozzi, Antonino Rotolo, Friedrich Schaudinn, cittadino tedesco ritenuto il vero artificiere dell’attentato, che si sarebbe sottratto al giudizio scappando, con la complicità di personale dell’ambasciata tedesca occidentale a Roma, poco prima che iniziasse il dibattimento. Per i reati di contorno, che andavano dal trasporto di materiale esplosivo al favoreggiamento, finivano invece alla sbarra Lucio Luongo e Carmine Esposito.
In circa 450 pagine di sentenza ordinanza, il giudice istruttore fiorentino promuoveva, pur con qualche distinguo, l’impalcatura accusatoria costruita dalla Procura di Firenze, giudicando concreta la possibilità che l’attentato del 23 dicembre 1984 fosse stato organizzato “per distogliere l’attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta contro le centrali emergenti della criminalità organizzata”. Tuttavia, aggiungeva il giudice nell’ordinanza, “le marcate connotazioni politiche di molti degli imputati, i collegamenti con precisi ambienti della destra eversiva […] possono rendere ipotizzabili anche altri più ambiziosi moventi”. Era insomma da ritenersi plausibile che la strage avesse anche “obiettivi politici” e rientrasse in un piano comprendente una serie di gravi attentati.
Inediti legami eversivi
“per distrarre la società”
Il primo dibattimento di primo grado durò 13 mesi e si definì con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Firenze il 25 febbraio del 1989: ergastolo a Calò e Cercola del gruppo romano, e Misso, Galeota e Pirozzi tra i napoletani per i reati di strage, attentato per finalità terroristica ed eversiva, banda armata, fabbricazione e detenzione di esplosivi. Per gli stessi reati, ma con le attenuanti, furono condannati anche Di Agostino (a 28 anni) e Schaudinn (a 25). Nelle motivazioni della sentenza, il presidente della Corte d’Assise di Firenze Armando Sechi sottolineava che la strage aveva avuto “molteplici finalità”: “Indebolire il sistema democratico del nostro Stato; distogliere con false emergenze l’impegno civile, politico e giudiziario e determinare, dunque, quella situazione di incertezza e di disorientamento dei pubblici poteri e di sfiducia in questi da parte dei cittadini”, che sono per la mafia “i presupposti indispensabili per la crescita […] del proprio potere”.

La sentenza della Corte d’Assise di Firenze uscì pesantemente riformata dal giudizio di secondo grado, che si definì davanti al collegio della Prima Corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Giulio Catelani alla metà di marzo del 1990. Vennero confermate le condanne di Calò, Cercola e Di Agostino, ma Misso, Galeota e Pirozzi furono assolti dai reati di strage, attentato e banda armata. La Corte ritenne credibili le riunioni “politiche” del clan Misso e la consegna di esplosivi al clan da parte di Abbatangelo, ma non giudicò questi elementi sufficienti a provare il nesso con la strage. Nelle 380 pagine di motivazioni, tuttavia, veniva illustrata la doppia “causalità” dell’attentato, che secondo la Corte era stato funzionale sia a Cosa Nostra che ai neofascisti: “Luogo, tempo, circostanze e modalità dell’azione ripetono e ricalcano un triste copione stragista connaturato alla modalità terroristica di matrice eversiva di estrema destra”, scrivevano i giudici d’Appello. E più avanti aggiungevano: “Se si considera che un attentato del genere è stato studiato e voluto nei termini e nelle condizioni in cui si è verificato, si avrà la certezza che esso non fu frutto di improvvisazione, e che coloro che studiarono e ne attuarono la esecuzione, ebbero ben presenti le finalità che l’attentato stesso si proponeva di raggiungere. Ovviamente questo è uno dei dati più preoccupanti e allarmanti, sul quale le indagini non hanno potuto far luce ma, riconosciuta per certa questa componente più specificamente terroristica e tenuto conto della riferibilità alla mafia degli imputati identificati, la conclusione che si impone non può essere diversa da quella raggiunta dalla sentenza di primo grado e cioè che la individuazione delle condizioni, modalità, tempi di esecuzione, non possa essere affidata ad altri se non a gruppi terroristici i cui scopi e le cui finalità si trovavano per l’occasione, come già altre volte era accaduto, in consonanza con quelli della mafia”.
La scure di Carnevale
al momento giusto
Su questa sentenza si sarebbe abbattuta circa un anno dopo, il 5 marzo 1991, la scure di Corrado Carnevale. Con una decisione che suscitò vibranti polemiche politiche e giornalistiche, nonché sdegnate prese di posizione di molti giuristi democratici, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione annullava completamente il giudizio di secondo grado, giudicando “generici” e “equivoci” gli elementi di colpevolezza emersi in Appello, arrivando finanche a definire “assiomatica” e “arbitraria” la definizione di mafioso per Pippo Calò.
Carnevale annullò con rinvio, ma a rimettere le cose a posto provvedeva, nel marzo del 1992, la Seconda Corte d’Appello di Firenze, presidente La Cava, con un verdetto che ribadiva l’ergastolo per Calò e Cercola e la condanna di Schaudinn a 22 anni, riducendo a 24 anni la pena per Di Agostino. Per Misso, Galeota e Pirozzi – già assolti in via definitiva per i reati più gravi – venivano confermate le condanne per la detenzione di esplosivi.
Il quantitativo di esplosivi in dotazione al gruppo romano – scrivevano i giudici – faceva pensare a “un vasto […] programma di attentati”, per cui la strage del 904 sarebbe stata inserita “in una strategia terroristica di più ampio respiro”. Per quanto riguardava invece il gruppo napoletano, anche secondo l’ultimo collegio la consegna degli esplosivi da Abbatangelo a Misso non bastava a provare il nesso con la strage. Con questa pronuncia, sul troncone principale dell’inchiesta sulla strage del Rapido 904 calava il sipario. A farlo riaprire non riuscivano a concorrere neanche alcune morti sospette: dopo quella di Lombardi, l’inspiegata esecuzione di Galeota, freddato da un killer sulla strada del ritorno da Firenze dopo il processo d’Appello, e il misterioso suicidio in carcere, qualche anno dopo, del braccio destro di Pippo Calò, Cercola.
Il ruolo di Abbatangelo
e il “premio” finale
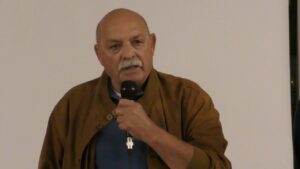
Parallela al procedimento “madre”, e in taluni punti in contraddizione con alcuni suoi esiti parziali (come la prima sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, e ancor più quella della Prima Sezione Penale della Cassazione), si era dipanata la vicenda processuale di Massimo Abbatangelo. La Camera dei Deputati concesse l’autorizzazione a procedere a suo carico nella seduta del 21 marzo 1990, e il processo, nel quale il parlamentare missino doveva difendersi dalle accuse di strage, banda armata, attentato per finalità terroristiche o di estorsione, e fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo, iniziò qualche mese dopo, andando avanti per circa un anno. Il 28 marzo del 1991, la Prima Corte d’Assise di Firenze, presieduta dal giudice Marcello De Roberto, condannava Massimo Abbatangelo all’ergastolo per tutti i reati contestati, consentendogli di stabilire un altro record negativo: quello di primo parlamentare della storia della Repubblica condannato alla pena massima prevista dal nostro ordinamento.
Nelle 384 pagine di motivazioni, depositate il 27 giugno del 1991, 89 giorni dopo la lettura del dispositivo in aula, il giudice estensore Pasquale Maiorano scriveva tra l’altro: “Il giudice deve giudicare non gli uomini in quanto tali, ma solo i fatti da loro commessi che si pongono in contrasto con le regole che la società si è data. Fatti come quello del 23 dicembre 1984, però, trascendono tali regole e si pongono non solo come violazioni dell’ordinamento giuridico, ma anche e soprattutto come un crimine contro l’umanità”.
Di questo crimine la Corte riconosceva Abbatangelo responsabile in toto, sia pure in concorso con altri. Le risultanze del dibattimento, a loro dire, dimostravano come la strage del Rapido 904 s’inquadrasse in quella più generale sinergia operativa stabilitasi tra la mafia e l’estrema destra eversiva fin dagli anni Settanta e continuata per tutti gli anni Ottanta. “Il ruolo svolto da Abbatangelo nella vicenda (partecipazione alle riunioni segrete e fornitura di candelotti) – scrivevano – non lascia dubbi sulla sua veste non di mero partecipante, ma di vertice della banda stessa”.
Tre anni dopo, questa impostazione veniva quasi completamente ribaltata dalla sentenza di secondo grado. Il 18 febbraio del 1994 la Seconda Corte d’Assise d’Appello di Firenze, presieduta da Elio Pasquariello, assolveva Abbatangelo da tutti i capi d’accusa tranne quello di detenzione di materiale esplosivo, condannandolo a 6 anni di carcere. Nelle striminzite motivazioni (138 pagine appena) depositate un mese dopo, il giudice estensore Mario Rotella scriveva che la cosiddetta “causale di genere”, basata sul comprovato nesso tra l’attività eversiva delle organizzazioni neofasciste e le strategie stragiste dei vertici di Cosa Nostra, “adottata come massima d’esperienza per l’interpretazione dei comportamenti dell’imputato e dei suoi sostenuti correi, in sé giustificabile nel processo, dev’essere infine riscontrata storicamente e provata compatibile con la rilevanza assoluta del reato in se stesso”. Insomma: il fatto che fosse stato provato che Abbatangelo, nei giorni immediatamente alla strage, avesse partecipato a delle riunioni segrete con la camorra e successivamente avesse trasportato dei candelotti di esplosivo, non era sufficiente a dimostrare un suo coinvolgimento diretto nel progetto dell’attentato.
Questo il “libero convincimento” della Corte d’Assise d’Appello di Firenze.
A Massimo Abbatangelo, pienamente riabilitato, nel 2017 è stato restituito il vitalizio da deputato della Repubblica, con la corresponsione di tutti gli arretrati non percepiti in precedenza.





