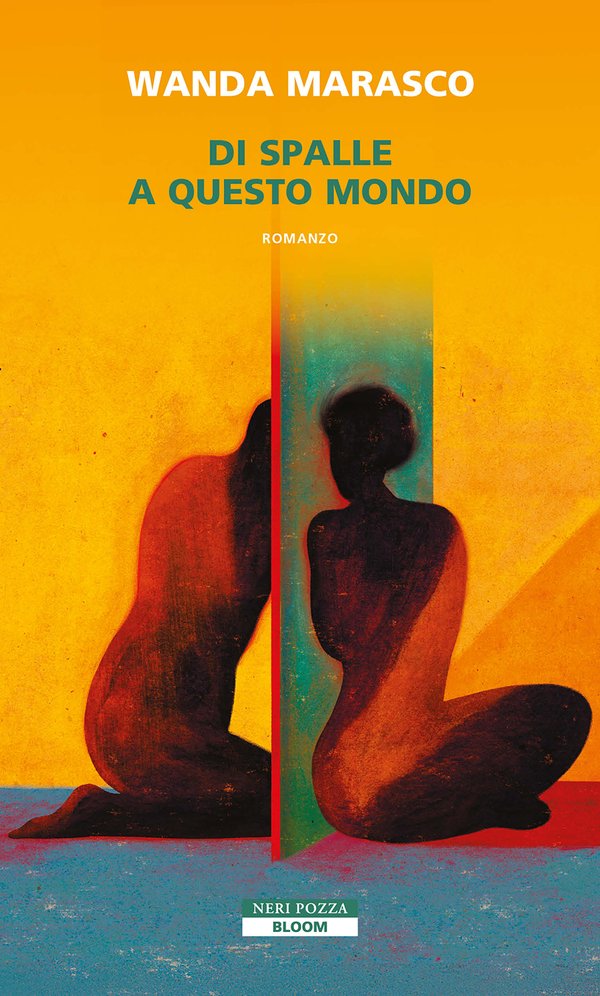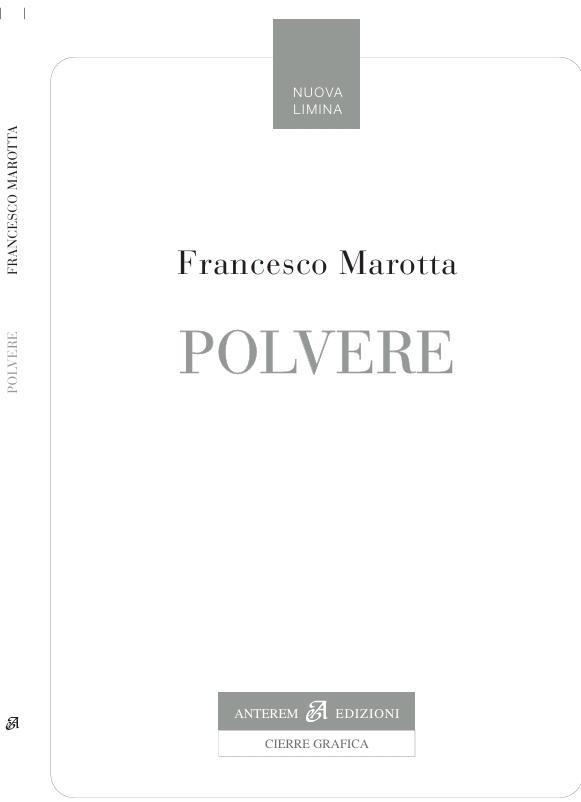Hai un lavoro da ultimare. I ritratti del Vulcano. La cosa mi darebbe una certa soddisfazione Sono pazzo se penso che dentro la mia torre dipingerai un cielo più sconosciuto e una terra più atterrita? Che tu, mendicando come me, chiederai alle viscere della Natura il senso? Che lo farai mescolando alla morte la tensione vitale? Perché l’idea è che tu venga qui a farmi compagnia con queste forze. Eduà, mi farai vedere come l’abbraccio fra l’esistenza e l’inesistenza difende fino all’ultimo il nostro terrore. Esiste una legge: senza l’intelligenza della morte le cose non sono mai state vive. Devi venire a ribadirlo attraverso la tua pittura, con l’unico sentimento che conti: appoggiarsi a uno spavento, a qualcosa che tremi quando noi tremiamo. Sorprendentemente non desidero che questo. E poi la perfezione di un addio. Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo, Neri Pozza, pag. 411.
Non c’è dubbio, le torri ospitano la follia. Qui, sulla collina di Capodimonte a Napoli, la torre accoglie la pazzia di Ferdinando Palasciano chirurgo e deputato italiano nato nel 1815 a Capua e morto nel 1891 a Napoli. In altri luoghi, la torre, quella del falegname Zimmer sul Neckar, adotta Hölderlin. Ancora un rimando, ma forse è un azzardo, potrebbe essere la torre, un cono, in pratica, che il personaggio chiave del Romanzo di Thomas Bernhard, Correzione, un certo Roithamer, realizza nella foresta del Kobernausserwald. Ecco, tutte queste abitazioni, reali o opera di finzione letteraria, sono abitate o abitano la follia. Perché? Una risposta potrebbe essere che, forse, abitare un luogo è vivere una volontà. Stare in quel desiderio incorruttibile di estrema tensione verso una perfezione, vicini a un’idealità, a un’unità che sarà inesplicabile, misteriosa e oscura. Se la follia di Hölderlin si manifesterà nel linguaggio poetico, quella di Roithamer sarà l’ossessione di un organismo portante capace di reggere la forza devastatrice della logica e della prepotenza del mondo. O dell’insensata indole della natura. Un’opposizione, quindi. Un resistere ostinato. Parole, queste, fondamentali di un sentire “picchiato”, di un patire la verità come un’anima che si deve sottrarre, annichilire e spegnere. La storia di Ferdinando Palasciano è accaduta in questo opporsi, reagire e sopportare, reggere il peso di un’idea di giustizia e di onestà. L’intensità. Sì, è stata l’intensità di voler correggere la Storia. Prima la passione, gli ideali liberali, l’idea della neutralità dei feriti in guerra, – lui che visitò Garibaldi ferito all’Aspromonte, lui che curò il cavallo del re Ferdinando e per questo in seguito graziato, dal re stesso, da una condanna a morte inflittagli dal generale di campo per aver curato i soldati nemici. Grazia che gli arrivò anche a causa della sua bassa statura. “Qua’ pena ’e morte? Palasciano? Chillo è accussì piccerillo, nun po’ fa male a nisciuno!” Pare che il re pensasse che un uomo così piccolo non avrebbe potuto nuocere, ma siamo già nella letteratura – poi il rifiuto di operare da chirurgo nel nuovo ospedale del Gesù Maria perché pensava, con ragione da vendere, che fosse inadatto e pericoloso per i pazienti, a causa della prossimità dei reparti chirurgici alle unità malattie infettive.
Così, nel marzo del 1866, si dimetteva dall’università, costretto a farlo dall’allora ministro Domenico Berti in accordo con il rettore Arcangelo Scacchi. Si concesse, quindi, alla politica e fu eletto deputato nel collegio di Cassino nel 1867 continuando a occuparsi della questione dell’assistenza ai feriti. E diventando per questo uno dei precursori della Croce Rossa, cosa per cui oggi è maggiormente ricordato. Fu nominato senatore nel 1876, quando già era assessore all’igiene del Comune di Napoli. Insomma del personaggio storico realmente vissuto queste sono solo poche notizie che vogliono introdurre il personaggio essenziale di questo nuovo romanzo della Marasco che, come ormai abbiamo imparato dai precedenti lavori, prima su tutti Il genio dell’abbandono, appunto una rielaborazione sulla figura di Vincenzo Gemito che, oltretutto, ritroviamo in dialogo con Palasciano, sono protagonisti che s’innescano su figure reali, storiche per accendere quella miccia dell’immaginazione e, quindi, della finzione capace di farci andare oltre quella soglia di ciò che è il dicibile e il dolente. Forse, come in questo caso, il tragico sia dell’esistenza sia di una storia che si ripete come un’ossessione. Una Storia folle, forse più alienata della stessa follia. Ma la scrittrice napoletana ha il dono della leggerezza così che le sue costruzioni romanzate sono veramente sapienti. A tratti, trattenute. Forse pudiche? O, forse, onestamente ammiccanti. In ogni caso, Di spalle a questo mondo si legge avidamente. La maestria della scrittura è da fuoriclasse, non meno l’idea di un amore, quello di Ferdinando Palasciano e di sua moglie Olga Pavlova Vavilova, una gentildonna e cantante lirica russa, che sorprende per l’intensità e la fragilità. Due figure, quella del medico e della paziente, Olga soffre di una zoppia, che s’incontrano quasi a sublimare un’idea d’imperfezione. Di smacco. D’irreparabilità. Sullo sfondo, la seduzione e la bellezza di Napoli. E dei suoi innesti linguistici. Qui è molto brava la scrittrice a non cadere nell’insidia di una lingua che travolge e incanta. Così che gli incastri “macchiettistici”, caricaturali, sono ben calibrati e azzeccati. Divertenti e allo stesso tempo amari. Basterebbe poco a rovinare il tutto. Notevole è l’invenzione della visita al re gravemente malato e senza speranza, in sostanza il re è in fin di vita, ma si potrebbe ancora salvare. È già stato visitato da illustri medici, ma non può e non vuole ricoverarsi in ospedale. – ’O Rre dint’ a nu spitale! Come a nu pover’ommo? – Chiede, allora, di altre eminenze Napoletane ma contrarie, uno dei quali è Palasciano, gli altri due sono Lanza e Prudente. Sono ricevuti a palazzo dal ministro Ferdinando Troya, fedelissimo del re. “Chiste so’ gghiuorn fatale! Si more o Rre cade ’o munno!” Chiedono di lavarsi le mani ma Troya ha un balzo. “Qua’ mane? Nisciuno ve ll’ha ditto? Voi il Re non lo potete toccare e nemmeno lo potete vedere. È per la dignità, avite capito? La regina ha dato ordini precisi, nisciuno ha da guardà ’o Rre in questa brutta condizione. Vuie dint’ ’a cammera d’ ’o Rre manco avite ’a trasì! Il consulto lo dovete fare con Ramaglia, areto ’a porta. Isso ve fa ’o quadro d’ ’a situazione e vuie arraggiunate. Iammo!” Si assiste, insomma, da vicino alla superbia e alla fine di un regno. Ferdinando Palasciano ha troppo introiettato, non regge. Una ferita che forse gli proviene dal passato, dal sangue di tanti feriti, dall’infanzia, dal colpo sparato dal nonno alla cavalla agonizzante, non si sa. Di certo, qualcosa gli accade: il buio di una luce che è la visione esatta dei folli. È ricoverato in manicomio. Dimesso, passerà i suoi ultimi anni alla torre, dove pare che l’amico Ranieri gli abbia portato le spoglie di Leopardi per farle custodire nel giardino. E lui aveva acconsentito. Non si poteva lasciare che le ossa del più grande dei poeti fossero disperse in una fossa comune a causa del colera. Poi, c’è l’amico Eduardo Dalbono, invitato dalla moglie Olga, a finire la serie dei paesaggi con il Vesuvio. Dalbono è un esponente della scuola di Resina, con Domenico Morelli, filippo Palizzi, Giacinto Gigante, Antonio Mancini, quindi dei grandi paesaggisti napoletani dell’Ottocento, qui rievocati insieme a Gemito, insieme a ministri, scienziati, personaggi illustri e popolani in un quadro d’insieme che rendono lo splendore di Napoli a fare da contraltare a una schizofrenia imperante, quasi che la follia di Palasciano si fondesse con qualcosa di più universale. Ecco, forse, con la nostalgia. Con l’amore. Con la morte. Con l’irreparabilità di una caduta. E si sa, quando c’è la nostalgia, c’è l’arte.
Un affondo, quello della Marasco, nel magma irrisolto di una cultura di un popolo e di un’umanità folle e zoppicante che non smette di convalidare il desiderio e la notte. Il fallimento. “La sirena e il centauro Vesuvio erano innamorati, ma si trascinavano dietro una natura rischiosa. Lei il canto che uccide, lui il dramma di governare il corpo e la mente. La gelosia di un dio li separò. Vesuvio fu trasformato in Vulcano. Partenope si uccise. Dalla sua morte è nata Napoli. Nella bellezza del paesaggio sono rimasti l’uno di fronte all’altra. Separati in questa sorte terribile: possono vedersi, ma non toccarsi. Non siamo mai fuori dagli spettri che ci lasciano le leggende”.
Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo, Neri Pozza, pag. 411