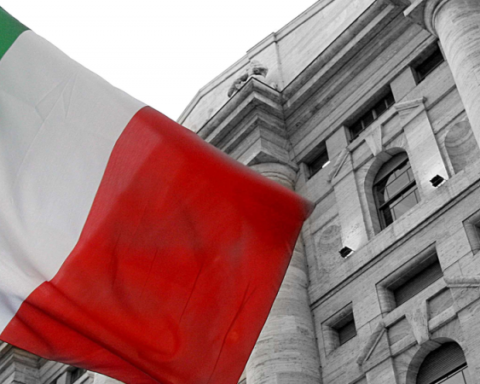Su un nostro articolo, scritto da Andrea Manzi e pubblicato circa due mesi fa, registriamo e pubblichiamo un articolato e denso intervento di Luigi Ferrara, psichiatra e intellettuale molto attento alle dinamiche sociopolitiche e, soprattutto, al posizionamento dell’uomo contemporaneo nella pervasiva dimensione neocapitalistica. Si tratta di un saggio che propone una visione alternativa rispetto a quella del servizio di RQ del mese di settembre: lo pubblichiamo con piacere per la ricchezza dei contenuti e il motivato e intelligente dissenso espresso, sperando che possa inaugurare e alimentare un proficuo dibattito sui temi legati al nostro tempo così controverso, peraltro sospinto da incessanti accelerazioni.
Gentile direttore,
sfogliando, come spesso mi capita di fare, “resistenze quotidiane”, ho avuto modo di imbattermi in una sua lunga e articolata riflessione (23.9.2023) sull’odierna condizione politico-culturale del nostro paese, la cui complessiva deriva culturale afferisce, riproducendola a sua volta, a quel più vasto movimento storico-politico occidentale avviatosi ormai da alcuni decenni, nella cui orbita modernizzatrice il satellite italiano è stato inglobato da un pezzo.
La sua lunga e articolata riflessione, ispirata dai valori liberaldemocratici di derivazione illuministica, orientata alla ricerca di autentici valori riformisti, è stata per me occasione di una ulteriore riflessione dettata dal suo riferimento a codici interpretativi, fonti e livelli di analisi che il suo scritto evidenzia, le cui conclusioni restano sostanzialmente agganciate a moduli teorici che se da un lato riflettono lo specifico storico-politico italiano, dall’altro non superano mai quel caratteristico limite, appunto, storico-politico, a cui approda gran parte della cosiddetta “cultura riformista” italiana e non solo.
La “luce dell’illuminismo”
e il riformismo fallimentare
Ora, la “luce dell’illuminismo”, che caratterizza anche le sue riflessioni, contiene due lunghezze d’onda: esso richiama non solo un preciso momento storico, ma contiene anche un determinato movimento di pensiero.
Sicché, nel ripercorrere, come lei fa, il percorso accidentato e sostanzialmente fallimentare della cultura riformista italiana, lei si imbatte proprio in quei limiti strutturali incarnati da un ceto politico di stampo ottocentesco che ai suoi occhi necessiterebbe di un “moderno processo di apprendimento globale” sulla falsariga della teoria di un famoso sociologo tedesco, Ulrick Beck, definita “cosmopolitizzazione” o ” secondo illuminismo”, nella forma di una “seconda modernità” nella quale potrebbero ricomparire i luoghi e l’anima di una politica liberale attualmente dismessa o negata, che dovrebbe fare i conti con “la società del capitale”.
Da ciò lei fa discendere le necessità e l’esigenza di un “partito democratico” che sappia calare all’interno della “logica capitalistica” elementi di equità.
Lei prosegue auspicando l’assimilazione per incorporazione della stessa metodologia innovativa che ha rivoluzionato il mercato e la cultura tecnologica, attrezzata di una strategia democratica di sviluppo attenta all’innovazione scientifica.
Tali sarebbero, dal suo punto di vista, i parametri cui aderire, sui quali allinearsi per evitare un “destino” che “l’arcigna Europa” infliggerebbe al nostro paese.
I limiti e gli equivoci
di una cultura superata
La sua ricerca di un’anima riformista identifica il “PD” quale vettore di giustizia sociale e di riforme.
Non mi soffermerò sugli esiti storici a dir poco disastrosi di tale identificazione, che è sotto gli occhi di tutti, piuttosto cercherò di evidenziare limiti ed equivoci cui incappa la cosiddetta cultura riformista italiana che, per entrambi gli aspetti evocati, derivano proprio da quel fusto illuministico a cui tale sinistra riformista affermava di richiamarsi.
“Polemizzare” col pensiero illuminista significa criticare a fondo l’onnipervasiva metafisica della luce: ciò, va da sé, non significa civettare con tendenze di pensiero misticheggianti o irrazionali (ciò che richiamerebbe la “polemica romantica” oltremodo nota…), ma si tratta di volgere lo sguardo riflessivo verso una “ragione sensibile”, una “ragione” che, diversamente dalla ratio illuminista, progenitrice della “razionalità aziendale” oggi onnipervasiva (per la quale l’unica cosa che conta è rendere redditizio in termini monetari l’operato umano e il mondo intero…), tenga conto invece degli aspetti più propriamente umani, ai quali riservi quella cura che la “ragione strumentale capitalistica” non conosce e anzi, fondamentalmente, disprezza.
Una “ragione sensibile”, nel senso più lato, considerando cioè l’ampio spettro semantico che la parola “sensibile” può avere.
Una “ragione” slegata dagli imperativi economici, anzi, capace di contrastarli e combatterli, che dovrebbe guidare l’agire umano, di cui oggi il mondo avrebbe estremamente bisogno.
Di fronte all’odierna crisi da collasso della modernizzazione, è necessario un tipo assolutamente diverso e antitetico di “ragione pratica” e di “immanenza”, che renda la critica sociale ancora più radicale e corrosiva, invece di indebolirla.
Più esattamente: il “contenuto materiale” delle potenze sociali disponibili, deve essere radicalmente liberato dalla sua “forma storica”, che ha avvelenato questo contenuto rendendolo distruttivo.
La paradossale irrazionalità
dell’illuminismo borghese
È pertanto necessaria una “ragione sensibile” che è proprio l’esatto contrario della “ragione astratta illuministica e borghese” modellata sulla “forma-merce”.
Si capirebbe allora che la sua pretesa assolutistica equivale solo a ridurre “contenuti sensibili”, qualitativamente differenti, all’interno di una logica autonomizzata: sappiamo bene che all’indifferenza del denaro nei confronti delle necessità materiali, corrisponde la forma teorica del metodo scientifico positivista, applicabile a qualsiasi contenuto.
Ancora oggi, a più di duecento anni di distanza, siamo abbagliati dallo “splendore dell’illuminismo borghese”: la storia della modernizzazione si inebria di metafore che evocano la luce.
Ma la simbolica della modernizzazione può essere criticata anche come paradossale irrazionalità della stessa ragione capitalistica, perché, curiosamente, le metafore illuministiche della luce, quelle legate per esempio alla nozione di “Progresso”, sanno di bruciato, di misticismo.
Sebbene invece la luce della ragione illuminista sia terrena, ha tuttavia assunto un carattere stranamente trascendentale: lo splendore celeste di un Dio del tutto impenetrabile si è secolarizzato nella banalità mostruosa del “fine in sé capitalista”, la cui Cabala della materia terrena consiste nell’insensata accumulazione di valore economico.
Questa non è ragione, ma la più alta follia.
Sicché, giungendo agli “eredi dell’illuminismo”, nostrani e non, si coglie come tale ragione irrazionale dell’illuminismo vuole mettere tutto in luce, ai cui bagliori taluni ancora si attardano ammantati da retoriche ormai desuete, quando non francamente allucinatorie.
Ma “questa luce” non è in alcun modo un semplice simbolo appartenente al mondo del pensiero, ha anche un reale significato socioeconomico. Ed è proprio questo che è stato fatale al marxismo tradizionale, al movimento operaio e alle declinazioni riformiste realizzate: essersi sentiti i veri eredi dell’illuminismo e della sua metafora sociale della luce.
Nella “Internazionale”, l’inno del marxismo, si dice del meraviglioso futuro socialista, dove “il sole splenderà per sempre”: un caricaturista tedesco ha preso alla lettera questa frase, mostrando “l’impero della libertà ” in cui “uomini sudati” alzano la testa verso il sole e sospirano:” …sono tre anni che brilla e non vuole saperne di tramontare”.
L’epoca delle “sveglie”
con competizione globale
Questa, ovviamente non è solo una battuta: la modernizzazione ha effettivamente “trasformato la notte in giorno” per cui, in sintesi, la produzione, la circolazione e la distribuzione delle merci devono funzionare con la famigerata logica dell'”h/24″.
Peraltro, come sappiamo tutti, l’epoca del capitalismo è anche l’epoca delle “sveglie”, fino al punto che, nella misura in cui la competizione diventa totale, l’imperativo sociale esterno si muta anche per l’individuo in coercizione interiorizzata: il sonno dell’uomo dell’economia mercantile diventa breve e leggero come quello di un animale selvatico. In tal senso esistono seminari di “self-management” in cui si possono praticare tecniche di minimizzazione del sonno il cui motto è “l’uomo d’affari non dorme mai”.
Proprio come i mercati finanziari.
Ma la sottomissione degli esseri umani al “lavoro astratto” non è possibile senza un controllo altrettanto totale, e ciò necessita di una sorveglianza altrettanto totale della piena luce, un po’ come nel corso di un interrogatorio quando un poliziotto punta una lampada accecante sul volto del prigioniero.
Non per niente la parola “Aufklarung” (Illuminismo) ha in tedesco un secondo senso, e cioè “riconoscimento del nemico”.
E una società in cui ognuno diventa nemico dell’altro e di sé stesso, perché tutti devono servire lo stesso Dio secolarizzato del capitale, diventa per necessità logica una struttura di sorveglianza e di auto-sorveglianza totale.
In un universo meccanicistico, anche l’uomo deve essere una macchina ed essere trattato meccanicamente: l’illuminismo lo ha preparato a questo.
“Sorvegliare e punire” di Foucault mostra come questa “visibilità ” sia diventata una trappola storica avendo assunto le caratteristiche del “Panopticon” inventato dal filosofo utilitarista liberale Jeremy Bentham che, alla fine del diciottesimo secolo, escogitò una “pedagogia della casa di correzione” che porta quel nome.
La stessa sfera pubblica dell’economia di mercato non è una sfera di libera comunicazione, bensì di sorveglianza e controllo analoga all’utopia negativa di George Orwell.
Dai campi di concentramento
ai grotteschi luna park
Ma, a differenza che nelle dittature totalitarie, in democrazia si tratta di auto-controllo, interiorizzato e gestito dai media, all’interno del quale i riflettori dei campi di concentramento si sono trasformati in un grottesco luna park: qui non si discute liberamente, ma si viene impietosamente illuminati.
Nella democrazia commerciale questo sistema è diventato così raffinato che gli individui obbediscono spontaneamente agli imperativi capitalistici e, come robot, seguono ciecamente la strada che è stata loro tracciata.
Il marxismo, contrariamente alle proprie aspirazioni sociali, integrando il pensiero meccanicistico illuminista e la sua perfida simbolica della luce, è diventato un protagonista del “lavoro astratto” “ontologizzando il lavoro”.
Tutto ciò che c’è di dispotico nel marxismo deriva dal liberalismo illuminista.
In tal senso, gli spasmi attuali della società globale smentiscono le aspettative ireniche nate dopo la fine del “comunismo”: la guerra in Ucraina, il riesplodere del conflitto israelo-palestinese, testimoniano la drammatica precarietà della “costruzione post-1989”.
L’interpretazione generale degli eventi deve tener conto di alcuni fatti essenziali sui quali, soprattutto a sinistra, si è prodotta una totale afasia.
Già nei primi anni ’90, dal disastro delle “democrazie progressive” del “socialismo reale” e dal naufragio totale del presunto bipolarismo politico-economico, “intellighèntsia ufficiale” dell’occidente, avrebbe potuto sviluppare una riflessione critica e auto-critica incisiva, capace di scandagliare il significato profondo di quel collasso epocale.
Delirio autocelebrativo
dell’apologia neoliberale
L’omologazione delle strutture socioeconomiche globali al paradigma occidentale, nella sua ultima e più militante versione neoliberista, andò di pari passo con il miope trionfalismo del “mondo libero” e con l’afasico disfattismo della precedente opposizione critica-ideologica.
Travolti dal delirio autocelebrativo dell’apologetica neoliberale, gli esponenti (soprattutto marxisti) di una critica sociale finita al tappeto, ripudiarono le loro obsolete velleità di trasformazione sociale per marciare finalmente in armonia con lo spirito del tempo e con l’entusiasmo dei neofiti.
Il “cane morto” del marxismo fu interrato senza troppe cerimonie mentre, simultaneamente, le opere di Smith, Von Hayek, Popper facevano il loro ingresso in grande stile nelle biblioteche degli ex-nemici giurati dell’esistente.
Per una minoranza, questo riposizionamento non significò necessariamente l’abbandono di qualsiasi postura critica: in apparenza lo tsunami ideologico anti-sociale “liberista” poteva essere arginato solo facendo appello agli ideali e ai valori originariamente “liberali” dell’illuminismo nella forma del “riformismo sociale” e dell’esaltazione dei “diritti umani”, questa volta non più minacciati dal “totalitarismo comunista” ma dagli “eccessi” di un liberismo senza freni, di cui però nessuno osava più mettere in dubbio la legittimità storica.
In questo modo si perfezionò un singolare riallineamento sul piano ideologico, perché i teorici del mercato e delle classi dirigenti globalizzate, ormai sature di retorica liberale e kantiana, erano convinti che la società mondiale della democrazia e dell’economia di mercato fosse la migliore realizzazione del patrimonio ideale ed etico-morale illuministico.
Ad accomunare entrambe le fazioni era quindi il tenace riferimento ai valori illuministico-occidentali: in una forma più militante e trionfalistica per i cantori “del sol dell’avvenire capitalistico”, in una forma più indulgente e attendista per i critici.
Secondo questi ultimi la Vittoria dei valori occidentali si sarebbe avverata in nome dei “diritti umani e in opposizione all’irrazionalità” dell’economicismo liberista, nel contesto di una società veramente “aperta e liberale”.
La tragedia newyorchese del 2001 e la successiva, sanguinosa crociata ideologica e militare della superpotenza americana hanno estremizzato in maniera parossistica la tendenza dell’occidente verso il fondamentalismo democratico-illuminista e hanno messo in luce il nesso indissolubile tra ragione illuministica, valori occidentali, democrazia politica, economia di mercato e militarismo globale poliziesco.
Le “amnesie”, le ipocrisie e infine l’impotenza della sinistra derivano anche dalla mancata comprensione storica di due testi che, a distanza di vent’anni l’uno dall’altro, hanno costituito l’alfa e l’omega di questa colossale torsione storica: “Capitalismo e libertà” di P. Friedman negli anni ’60, e “La fine della storia” di F. Fukuyama nell’89.
Ne è emerso il desolante panorama di una critica sociale che, rifiutandosi di analizzare sensatamente la realtà sociale contemporanea, si rovescia, volente o nolente, nella forma fenomenica del suo contrario, cioè nella pura e semplice legittimazione.
In tale sconfortante e desolante deserto culturale, è iniziata, nella seconda metà degli anni ’80, una revisione “demitologizzante” del pensiero marxista, portata avanti dalla “Scuola di Norimberga” della quale Robert Kurz ne è principale ma non unico esponente, riflessione volta alla costruzione di un paradigma teso a penetrare a fondo la “totalità negativa” della società moderna e della sua crisi fondamentale.
Benché allievi di Adorno e Horkheimer, della più nota e famosa “Scuola di Francoforte”, il gruppo di lavoro di Kurz e collaboratori ben presto ne prese le distanze, proprio a partire dalla francofortese “Dialettica dell’Illuminismo”.
La critica contro l’illuminismo di cui si è detto all’inizio assume il significato di una indispensabile “pars destruens” come preliminare a una radicale riflessione critica, così estranea al minimalismo pseudo-riformista e dell’idiosincrasia post-moderna per le “grandi narrazioni”.
La ragione illuministica
non coincide con la razionalità
Fondamentale resta quindi tale focus, perché la resa dei conti con la filosofia illuministica sottolinea proprio il fatto che essa non è solamente una corrente di pensiero formatasi nel corso del XVIII secolo e culminata nella filosofia kantiana, né tanto meno la identifica con il processo sovrastorico, e in ultima analisi distruttivo, con cui l’uomo realizza il suo dominio sulla natura, nel senso della “dialettica francofortese”.
Essa è piuttosto l’auto riflessione della coscienza sociale borghese e l’ideologia di imposizione della società capitalistica fondata sul “valore”.
Con questa espressione si intende una forma sociale che ha modellato progressivamente la sua prassi produttiva, riproduttiva e simbolico-culturale sugli imperativi della valorizzazione capitalistica e quindi sulla produzione di merce e sulla universalizzazione della pratica monetaria.
Come riflessione specificamente storica, la ragione illuministica non coincide affatto con la razionalità tout-court, non è infatti una facoltà rimasta incomprensibilmente latente nel corso della storia umana, fino allo start-up nella società borghese: è una forma di ragione o, più precisamente, la “ragione di una forma”, cioè la ragione plasmata sulla “forma-valore”.
Come il valore di una merce fa completamente astrazione dalle sue qualità sensibili, anche questa forma di ragione mira a trasformare ogni realtà sensibile in mere quantità di valore astratto, nel corso di un processo distruttivo e auto-distruttivo in cui la stessa struttura istituzionale e politica della società della merce collassa e il cui ultimo stadio può essere identificato nei fenomeni di estesa e devastante destatalizzazione e anomia sociale e nelle guerre dell’ordine mondiale.
Nella “totalità feticistica”, il portatore funzionale delle esigenze della valorizzazione è “il soggetto”, cioè l’individuo che ha interiorizzato gli imperativi della dinamica capitalistica al punto tale da non essere più in grado di elaborare l’eteronomia del processo sociale.
Questo “soggetto” percepisce la realtà solo attraverso il prisma della forma astratta del valore: il denaro come apriori in contanti.
La storia del soggetto è quindi anche la storia della sua legittimazione nella filosofia illuministica e nei suoi derivati: le metamorfosi dell’autoriflessione illuministica, identificabile come “storia intellettuale della modernità” hanno accompagnato le vicende di questo soggetto, in una oscillazione continua tra i due poli dell’oggettivismo, assimilabile a un meccanismo governato da leggi naturali e necessarie, quasi scientifiche e insuperabili, che il singolo deve limitarsi a comprendere ed eseguire, e del soggettivismo, in cui il singolo contrappone la sua “esistenza” a una società di cui non riesce a cogliere la struttura feticistica.
Lo stesso marxismo, con le sue promesse escatologiche, può essere decifrato come il progetto, naufragato, di una ragione illuministica allo stato puro, nella forma di una palingenesi sociale, apparentemente post-borghese, ma in realtà anch’essa assoggettata agli imperativi della merce.
La tendenza oggettivista si afferma ulteriormente con lo strutturalismo, mentre le tendenze post-moderniste convertono la critica sociale dell’ermeneutica incessante del “testo sociale” da parte di un soggetto ormai deprivato di qualsiasi capacità di intervento sulla sua realtà.
La dimensione menomata
del rapporto tra i generi
Sicché, una volta identificato il senso segreto della filosofia illuministica come ideologia del feticismo sociale moderno, non è difficile smascherare il linguaggio orwelliano in cui si esprimono i suoi “valori”: non si tratta solo di negare “l’universalismo habermasiano” dei “diritti umani” nella sua portata storico-culturale, ma di sottoporli a una critica fondamentale; come prodotto della società del valore, i diritti umani sono i diritti del “soggetto” nella sua esistenza monadizzata, sotto il dettato del valore e della sua valorizzazione, e l’universalismo di tali diritti è altrettanto falso quanto l’universalismo della società della merce e del suo soggetto.
In primo luogo, lo “zoon politikon” a pieno titolo della società della merce è proprio il “soggetto”, “l’uomo solvibile”, in grado di acquistare forza-lavoro o di vendere la propria, il lavoratore, il titolare di potere d’acquisto. Per chi è impossibilitato a operare nella sfera della valorizzazione l’alternativa è tra l’invisibilità in un limbo sociale o addirittura la perdita dell’esistenza fisica.
Infine, anche “l’asimmetria nel rapporto tra sessi”, lungi dal costituire un mero problema di equiparazione giuridica, è in realtà una dimensione profonda della struttura sociale: da una parte la sfera primaria “maschile” connessa con la valorizzazione del lavoro e della politica, dall’altra tutte le attività di cura, assistenza, di supporto psico-emozionale, costituiscono la sfera secondaria, “dissociata” dalla prima e identificata con un “femminile ideologizzato” (donna=emozionalità=natura).
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la suddivisione delle attività produttive e riproduttive sociali secondo “criteri di genere” che caratterizzano le società premoderne.
Qui il rapporto tra le due sfere è dinamico, dialettico e idiosincratico: la sfera dissociata femminile, per quanto necessaria alla sopravvivenza della società nel suo complesso, figura allo stesso tempo come una dimensione menomata, inferiorizzata e per di più sottoposta a una tensione critica che la “valorizzazione maschile” cerca di reintegrare al suo interno mediante la loro economicizzazione sotto forma di “servizi”.
Contemporaneamente, l’ingresso delle donne nella sfera produttiva, perlopiù in posizioni subordinate, mette in crisi tutti quei momenti della riproduzione sociale, che, pur essendo estranei al mercato, rappresentano il presupposto segreto della sua sopravvivenza.
In sostanza, la crisi della modernità basata sulla “forma-valore” e del “soggetto” non può essere superata nei limiti del paradigma illuministico ma richiede, all’opposto, una critica radicale, una rottura decisiva con la sua logica.
Del resto, al presente, non si intravede sul piano pratico nessuna opzione che si orienti realmente in questa direzione.
L’atteggiamento contemplativo di un’opinione pubblica sempre più apatica, disorientata e spaventata dalle ripercussioni della crisi, non lasciano presagire nulla di buono a questo riguardo.
Prospettive capovolte
interne al capitalismo
Per concludere: è nel mainstream della coscienza sociale (inclusa la “Scienza”) che si manifesta il degrado del presupposto fondamentale di ogni teoria, vale a dire la capacità di collocarsi in una prospettiva virtuale esterna o superiore, ossia di “distanziarsi”.
Ma l’unica prospettiva riconosciuta dallo pseudo-dibattito dominante, che presuppone pur sempre il consenso universale sull’economia di mercato e sulla democrazia, è una prospettiva capovolta, tutta interna al capitalismo: è questo a rendere il dibattito così deprimente e insulso. Una percezione immanente, priva di distacco, non potrà mai dar vita a una riflessione teorica; ciò che appare come riflessione o si contrabbanda come tale, resta confinata sin dal principio sul livello fenomenologico.
D’altro canto, questa limitatezza si concilia perfettamente col “Credo post-moderno” che nega qualsiasi differenza tra “l’essenza e l’apparenza” e proclama la fine delle “grandi narrazioni”, ossia la fine di ogni teoria che abbia per oggetto la “totalità”, che si sforzi di ricostruire un nesso tra essenza ed apparenza mediante la riflessione critica.
Dove non esiste un livello astratto della riflessione teorica, d’altra parte, non può esistere nessuno sviluppo sul piano concreto.
Un tipico rappresentante dell’odierno clima “post-moderno” è Ulrick Beck, la cui analisi della società trasfusa nell’opera “Seconda modernità” è del tutto avulsa da qualsiasi concetto critico delle forme sociali capitalistiche e del suo irrazionale carattere feticistico, che non è in grado di collocare il fenomeno della globalizzazione in una prospettiva teorica, come per il fenomeno dell’individualizzazione negli anni ’80.
Lo stesso Beck che, pur ignorando la legittimazione filosofica del disarmo postmoderno nella teoria critica, l’ha messo in pratica con fervore estremo, impersonandolo nella sua figura di sociologo, vorrebbe nascondersi sotto il mantello di una “grande narrazione”.
In questo modo però lo specchietto per le allodole di Beck si raddoppia: in un primo momento si vuole prolungare irriflessivamente la modernità capitalistica con la formuletta sterile della “seconda modernità”, sotto lo pseudonimo ornamentale di “modernità riflessiva”; viene poi effettuato il tentativo esplicito di oltrepassare questo tipico camuffamento postmoderno, allo scopo di superare solo apparentemente la postmodernità: un dibattito sulla globalizzazione privo di sostanza teorica viene promosso al rango di “grande narrazione”.
I predicatori di speranza
del nuovo pragmatismo
La limitatezza fenomenologica, il credo della futile ostilità nei confronti delle “grandi teorie” vorrebbe ora assurgere al ruolo di “grande teoria”.
A dimostrare l’insensatezza di questo trucco da baraccone c’è il fatto che Beck si illude di aver scovato un Autore o un Co-autore collettivo assolutamente appropriato per la fatidica “grande narrazione” della globalizzazione, infatti afferma: “Da molto tempo Marx non è più un libero pubblicista e un ‘critico-critico’, ma un funzionario della Banca Mondiale: pubblica sotto diversi pseudonimi su Financial Times, sul New York Times o su Der Spiegel”.
Ma, bisogna ribadirlo, sono proprio gli attori delle istituzioni nazionali e internazionali dei mercati finanziari e del giornalismo economico che manifestano, per ragioni ontologiche, la più assoluta assenza di distacco dal carattere delle loro azioni e dei loro impulsi, poi tradotta dai predicatori di speranza del “nuovo pragmatismo” nel linguaggio di una politica ormai spettrale, visto che l’incapacità di distacco e la riduzione funzionalistica del pensiero ufficiale, in pieno XXI secolo, hanno fatto passi da gigante, sia nel mondo accademico, sia nella coscienza quotidiana delle masse.
Va detto inoltre che le élite funzionali del capitalismo ottocentesco esibivano ancora sotto molti riguardi la “formazione intellettuale tipica dell’alta cultura borghese”, di conseguenza anche se non svilupparono mai, in prima persona, una riflessione critica, furono comunque in grado di comprenderla, almeno in maniera rudimentale.
Ma chiunque abbia avuto occasione di conoscere più da vicino gli odierni funzionari del management, delle istituzioni del capitalismo finanziario e della politica o abbia preso visione dei loro scritti, non può che reagire con sgomento di fronte all’incultura e alla trivialità da barbarie di ritorno di questi spiriti, il cui livello filosofico-concettuale è sub-adolescenziale e inversamente proporzionale a quello delle loro cognizioni tecniche e mediatiche.
La “giungla mediatica del capitalismo globalizzato” ha generato dunque una specie di “idiotismo rurale” di secondo grado: il ragionamento di questi “idioti funzionali” del capitalismo (così come quello degli “idioti dello specialismo accademico”) non si condensa mai in una riflessione sintetica, limitandosi invece a una cottura a fuoco lento in una serie a puntate senza una fine prevedibile, mentre la loro prassi sembra guidata più dall’istinto della “seconda natura” che dal pensiero cosciente.
Rispetto a tutto ciò la cosiddetta sinistra non è ormai più in grado di incidere significativamente in alcun modo su questi eventi. Sempre che l’abbia mai fatto, e non sia stata invece sin dall’inizio una pedina, anche molto importante, per lo sviluppo e il perfezionamento dell’imposizione capitalistica.
La cosiddetta sinistra
nel tranello neoliberale
Di fronte alla crisi la cosiddetta sinistra sforna ricette di tenore neoliberista tanto quanto la presunta controparte di destra, se non di più. Tale situazione è particolarmente tragica per quella sinistra che aveva sempre sognato di “marciare alla testa del progresso”.
Questo slogan oggi non ha più alcun senso, in quanto “quel Progresso” non era altro che il concetto dell’imposizione e dello sviluppo storico del moderno sistema della merce, che da alcuni decenni è entrato in collisione con i suoi stessi limiti. A questo proposito affiora una singolare inversione, in cui i paradigmi classici della sinistra e della destra addirittura si scambiano di posto: in linea di massima, in entrambe le fazioni, sono ormai tutti conservatori e neoliberali ma questa convergenza profonda manifesta, comunque, differenze tali da rivelarci come i fronti della riflessione si siano scambiati.
La “crisi capitalistica” non può essere affrontata ricorrendo a soluzioni dissennate quali “il sovranismo” o, peggio ancora, il “complottismo” che, per parte sua, appare particolarmente insidioso soprattutto per il fatto che, come spesso accade in periodi di forte crisi difficili da interpretare senza un lavoro di analisi e di approfondimento, legge gli eventi “soggettivizzando le colpe”, trascurando invece le motivazioni strutturali e, in tal senso, funziona come arma di distrazione di massa estremamente funzionale al mantenimento dello status quo.
La fascinazione di tali pseudo soluzioni poggia sul vuoto lasciato proprio dalla sinistra, spesso colpevolmente, spesso perché impossibilitata a causa del suo “retroterra riformistico compatibile con il sistema capitalistico”.
È stato ironicamente osservato che oggi è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo: forse è ora di contemplare anche l’eventualità che la fine del mondo possa scaturire proprio dalla sopravvivenza del capitalismo.