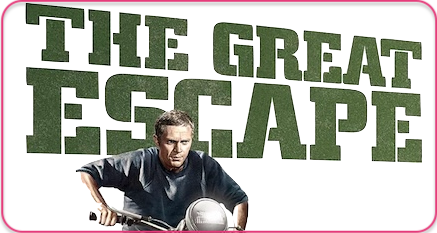La morte è la sigla finale perfetta. La camera ardente come studio televisivo. Titoli di coda i necrologi. La memoria trucca, addolcisce, imbalsama. Stiamo celebrando da due giorni la maschera funebre di un Paese che non sa distinguere tra cultura e intrattenimento, tra arte e televisione, tra eros e siparietto. I notiziari rievocano la figura di Pippo Baudo con l’enfasi dei funerali di Stato: il “re della tv”, “la memoria condivisa di un Paese”, “un pezzo di storia nazionale”. Tutto vero, se per storia intendiamo la somma dei nostri conformismi, e per memoria la collezione dei nostri tic collettivi. In fondo Baudo, che scopro dalle rievocazioni in tivvù sin dal 1959 (mio anno di nascita), qualcosa ha insegnato. Non l’arte, non la bellezza, ma il potere della ripetizione.
Il coro degli elogi postumi, immancabile e in gran parte ipocrita, rivela più della carriera del defunto che della sua reale statura. Perché Baudo non è stato né un innovatore, né un intellettuale travestito da showman. È stato il perfetto sacerdote di una liturgia minore: il varietà televisivo. La sua forza non era il genio, ma la perseveranza. Il suo talento non era l’invenzione, ma la capacità di occupare lo spazio, di durare, di riempire per decenni il palinsesto con la stessa formula, la stessa dizione impostata, lo stesso sguardo paternalistico rivolto a una platea rassicurata. Oggi, nella ridda di cordogli istituzionali, l’assenza di memoria critica è disarmante. Non una voce che ricordi come il modello Baudo abbia cementato il provincialismo culturale italiano: l’ossessione per il Festival di Sanremo come misura unica della musica e la spettacolarizzazione del nulla in prima serata.
Questa è l’Italia che oggi applaude sé stessa, specchiandosi nella propria mediocrità e celebrandola come grandezza. Eppure basterebbe pensare con un minimo di onestà. Baudo non è stato un artista, ma un funzionario dello spettacolo, un burocrate della scena che amministrava applausi come altri gestiscono pratiche d’ufficio. Ha scoperto cantanti, sì, ma nella stessa misura in cui una rete televisiva, per forza di cose, produce fenomeni commerciali. La sua eredità non è un canone, ma un archivio di ricordi rassicuranti: sigle orecchiabili, gag innocue, un lessico familiare che sopravvive solo nella nostalgia di chi teme il vuoto del presente. Solo e sempre la forza di durare, di resistere, di essere sempre presente ben prima dell’epigono Marzullo.
La celebrazione postuma di Pippo Baudo è la nostra ultima fantasia di innocenza: credere che la televisione ci abbia dato un destino. Eppure il fenomeno merita attenzione non tanto per ciò che il protagonista è stato – un conduttore televisivo longevo e disciplinato – ma per ciò che la sua morte rivela di noi. La parola che più ricorre è “re della televisione”. Un’etichetta semplice, quasi monarchica, che serve a imbalsamare una carriera in una formula immediatamente comprensibile. Baudo non ha inventato la televisione, non l’ha trasformata, non l’ha problematizzata. L’ha abitata. Nelle ricostruzioni agiografiche si parla di “scopritore di talenti”, di “traghettatore di generazioni”, di “uomo colto e raffinato”. Tutto vero, in parte. Ma è vero anche che il talento scoperto è tale perché la televisione lo ha certificato, e il raffinatissimo salotto di prima serata non ha mai rischiato di mettere in crisi il pubblico. In un Paese allergico alle rotture, la mediazione rassicurante di Baudo era il massimo dell’audacia consentita. La celebrazione, dunque, non riguarda l’uomo, ma il dispositivo.
Pippo Baudo è diventato segno di sé stesso: non più persona, ma funzione. E oggi viene chiamato a rappresentare la televisione nel suo stato puro, la macchina che organizza rituali collettivi e li trasforma in memoria nazionale. L’universo digitale post-televisivo, con i suoi frammenti infiniti e le sue voci dissonanti, non produce più re, ma solo influencer passeggeri. La morte di Baudo segna quindi la morte di una televisione monarchica, verticale, capace di unificare un Paese intero attorno a una scaletta. La retorica funebre tenta di illuderci che quell’Italia esista ancora, ma la realtà ci dice che non c’è più alcun trono da occupare. La morte, si sa, trasforma ogni biografia in mito. Ma il mito Baudo è costruito su un equivoco: confondere la longevità con l’importanza. Durare non significa incidere. Riempire il tempo non significa creare senso.
La televisione di Baudo ha anestetizzato più che educato, ha intrattenuto più che provocato, ha consolidato abitudini più che stimolare immaginari. Eppure oggi la si celebra come fosse arte, cultura, patrimonio nazionale. La verità è che celebriamo noi stessi, non lui. Celebriamo la nostalgia per un’Italia ingenua, monocorde, convinta che il prime time Rai fosse il centro del mondo. Celebriamo l’illusione che basti il sorriso di un conduttore a garantire la coesione di un Paese. Celebriamo, in definitiva, la consolazione della mediocrità elevata a sistema. Pippo Baudo non merita disprezzo, ma nemmeno il monumento che gli si vuole erigere. Era un professionista serio, che ha servito la televisione con la disciplina di chi conosce le regole del gioco. Non ha mai avuto l’ambizione di cambiarle. È stato, in questo, lo specchio perfetto dell’Italia che lo ha seguito: un Paese capace di sopravvivere a tutto, ma incapace di reinventarsi. Ora che la sua voce si è spenta, restano le repliche, i montaggi celebrativi, i necrologi in sovrappeso. Ma al di là dell’enfasi, resta anche una lezione più amara: la nostra incapacità di distinguere tra grandezza e popolarità, tra cultura e intrattenimento, tra icone e abitudini. L’Italia che piange Baudo non piange un artista, ma la rassicurante mediocrità che ha amato per cinquant’anni. E forse, in fondo, è questo che ci meritiamo.
(per gentile concessione dell’autore e de “l’Altravoce”)