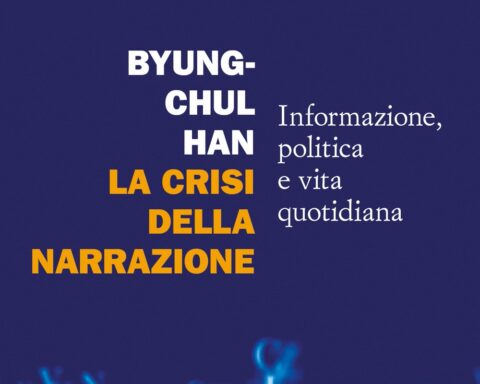La Roma che oggi viene indicata come città del disastro urbano fu negli anni trenta, e per molti anni a seguire, centro culturale e fucina di capolavori cinematografici per cui il mondo guardò all’Italia con ammirazione.
La vita nei bar e in particolare in caffè-luoghi di aggregazione come Rosati, si anima per la presenza di giornalisti, cineasti, attori, musicisti, scrittori come Alberto Moravia, PP Pasolini, Alberto Arbasino, Vitaliano Brancati e tanti altri. Per lo più uomini, più qualche attrice di contorno. Epperò tra questi c’è una donna autorevole per il suo background culturale e le sue competenze cinematografiche: Suso Cecchi D’Amico, dove Suso è a sostituzione del nome di battesimo Giovanna.
La figlia Caterina, che recentemente ha curato e pubblicato insieme a Francesco Piccolo un libro su sua madre dal titolo ‘La fortuna di essere donna’, edito Einaudi, afferma che più di una volta per via di questo nome gli stranieri la scambiarono per un uomo, eppure lei fu sempre Suso. L’intento del libro è quello di “rivalutare la scrittura per il cinema, finora considerato unicamente ancillare nei confronti del lavoro registico”.
La D’Amico è certamente la più importante sceneggiatrice di Cinecittà, senza la quale il nostro cinema di quegli anni non sarebbe risultato d’esempio nel mondo. Per oltre mezzo secolo, dall’immediato dopoguerra fino ai primi del duemila, ha scritto più di 120 sceneggiature per i grandi registi del nostro cinema.
Nata a Roma nel 1914, casualmente come scrive nella sua autobiografia, Suso si forma sotto l’influenza del padre Emilio Cecchi, critico letterario, anglista e giornalista (suo merito, aver portato in Italia i libri di James Joice), e della madre Leonetta Pieraccini, scrittrice e pittrice, in particolare affermata ritrattista. Come suo padre, Suso si appassiona alla letteratura inglese, e perfeziona i suoi studi a Cambridge.
L’approfondimento delle lingua inglese le consente di esercitare anche il mestiere di traduttrice di romanzi come Jude l’oscuro di Thomas Hardy e tanti altri. La sua rete fittissima di scambi culturali si accresce grazie al matrimonio con Fedele D’Amico, musicologo (anche Suso ha studiato musica), figlio del noto critico e teorico teatrale Silvio. In questa quotidianità dove si respirano cultura ed arte, Suso concepisce e cresce tre figli, Caterina, Masolino e Silvia (tutti e tre nel solco dei genitori per quanto riguarda la passione per il cinema e il teatro), figli che non trascura mai, riuscendo sempre a conciliare il suo ruolo di madre con quello di scrittrice, traduttrice, sceneggiatrice. Tra l’altro il peso della famiglia è tutto su di lei, perché il marito, catto-comunista, è ben presto candidato alla clandestinità, e poi perché successivamente, nel dopoguerra, si ammala di tubercolosi. Anche le loro condizioni economiche non sono soddisfacenti, ma questo le serve da sprone, e con la forza del suo carattere e delle sue crescenti competenze, riesce a guadagnarsi nel cinema un posto di assoluto rilievo, nonostante l’epoca sia a predominante figura maschile. La sua prima sceneggiatura, la scrive insieme a Moravia, Flaiano e Castellani, ed è per Avatar, prodotto da Carlo Ponti. I 4 si riuniscono con entusiasmo, ma a un certo punto il progetto naufraga, non se ne fa niente. Suso però non si perde di coraggio.
Sceglie di lavorare con Luigi Zampa, che le fa conoscere Anna Magnani, di cui diventa grande amica. La descrive così:
“Non era bella, spesso cupa come il suo cane lupo color dell’ebano. Aveva sempre le occhiaie, un colorito terreo e i capelli neri come non si può immaginare, della consistenza di una matassa di seta pesante. Le gambe erano magre e leggermente storte, era piccolina e forte di fianchi. Aveva un décolleté splendido, come pure lo erano le mani e i piedi. Dovunque entrasse e in scena, non guardavi altri che lei. Era poi capricciosissima e prepotente.”
Il lavoro di Suso, sceneggiatrice unica e irripetibile nel panorama italiano, si definisce attraverso la realizzazione di film nati da traslazioni di importanti opere letterarie. La sua narrazione ha una splendida tenuta. Lei non teme la frase: Sì, ma è migliore il romanzo. Maestra di questo tipo di adattamento, acuta osservatrice della realtà e dei suoi risvolti sociologici ed antropologici, nonché dotata di grandi autonomie lavorative, mette in campo dei taglia e cuci che impreziosiscono il narrato.
Lavora poi con Visconti, la loro collaborazione durerà dieci anni. Grande successo del Gattopardo, interpretato da Burt Lancaster. E poi, sempre con Visconti, firma le sceneggiature de Lo straniero, Rocco e i sette fratelli, l’acclamato Bellissima , sviluppato da un soggetto di Cesare Zavattini e sceneggiato da Suso insieme allo stesso Visconti e a Francesco Rosi. Quando Visconti sarà colpito da un ictus, seduta alla moviola del montaggio c’è sempre lei al suo fianco, ci sarà fino alla sua morte, il 17 marzo del 1976.
Con Zavattini, Vittorio de Sica ed altri, scrive anche Ladri di Biciclette, una delle storie più drammatiche del nostro cinema del neorealismo.
Merito suo, è anche quello di avere aperto la strada, con le sue narrazioni, alla commedia all’italiana. Nel 1958 scrive insieme ad Age e Scalpelli (difficile restare fuori dalle loro frequenti liti, ma lei ci riesce) la sceneggiatura de I soliti ignoti diretto da Mario Monicelli, e a seguire tanti altri film (Casanova ’70, Le fate, Boccaccio, Speriamo che siafemmina, Parenti serpenti). Altro merito, quello di avere messo insieme La Loren e Mastroianni. Mai coppia cinematografica più indovinata e bella.
Sempre nella sua autobiografia, di Mastroianni racconta:
“È un attore molto dotato, che si è divertito a lavorare. Non ha mai studiato un copione. Ha sempre cercato, per quanto possibile, di non leggerlo neppure. A lui piace andare in giro, si adatta con estrema facilità a qualsiasi ambiente. Non è di quelli che con la testa tra le mani si concentrano per entrare nel personaggio, come De Niro. Mastroianni è un caso piuttosto unico, in questo senso. […] Ha un orecchio eccezionale, che lo guida sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa.”
Riguardo al suo lavoro:
“La sceneggiatura è il bozzolo e il film la farfalla. Il bozzolo ha già in sé il film, ma è uno stato transitorio, destinato a trasformarsi e poi sparire. Lo sceneggiatore deve impadronirsi al meglio della materia e lavorarci poi con il regista e con i colleghi per trarne una proposta valida a sfruttare al massimo le possibilità del regista ed evitando il pericolo di fare letteratura. Deve scrivere con gli occhi.”
Lavora poi con Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, Luigi Comencini.
Nel 1988 l’Università degli Studi di Bari le assegna una Laurea honoris causa in Lingue e Letterature straniere con la seguente motivazione: «La sua tecnica agguerrita e la sua vasta cultura sono stati preziosi nel lavoro letterario del film… Ha rielaborato i soggetti originali con profondo intuito letterario e straordinario senso cinematografico».
Nel 1994 la Mostra di Venezia le aggiudica il Leone d’oro alla carriera.
Nel 2001 il regista Martin Scorsese chiede la sua collaborazione per la stesura di un documentario sul cinema italiano dal titolo Il mio viaggio in Italia.
Nel 2010 muore a Roma dopo lunga malattia.