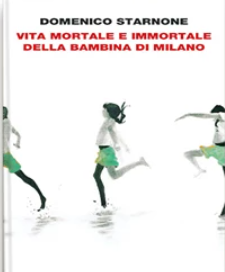Esploriamo la forza narrativa di Anna Banti, capace di dar voce a una figura femminile ribelle e luminosa : Artemisia Gentileschi.
Anna Banti è lo pseudonimo di Lucia Lopresti, nata a Firenze nel 1895. Cresciuta in un ambiente colto, si laurea in Lettere con una tesi sull’arte secentesca, ricevendo lodi da Benedetto Croce. La storia dell’arte è la sua prima grande passione: è curiosa, instancabile, con uno sguardo attento e personale.
Nel 1924 sposa il critico d’arte Roberto Longhi, con cui fonda la rivista “Paragone”. Dopo una crisi personale e intellettuale, si rende conto di voler seguire più la sua immaginazione che il rigore della ricerca storica. Decide quindi di allontanarsi dalla critica d’arte per dedicarsi alla scrittura narrativa, dando vita alla figura di Anna Banti, un’identità scelta da un ricordo d’infanzia e già usata in segreto in gioventù. Con questo nuovo nome si emancipa dalla figura ingombrante del marito e intraprende un percorso autonomo, creando una forma di narrazione in cui arte e scrittura si fondono. Il romanzo Artemisia, dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi, rappresenta il culmine di questo nuovo approccio: una storia dell’arte reinventata attraverso la narrativa, in cui la scrittura stessa diventa mezzo per raccontare la pittura. Durante la sua lunga carriera, Anna Banti ha scritto numerosi saggi e romanzi, sempre caratterizzati da uno stile raffinato e da un’attenzione particolare agli aspetti umani e sociali delle storie che raccontava. La sua opera si colloca quindi all’incrocio tra letteratura, storia dell’arte e impegno civile: attraverso le sue pagine, Anna Banti ha dato voce a chi era stato troppo a lungo silenziato, ha raccontato la storia con un’attenzione particolare agli aspetti umani e sociali, e ha mostrato come l’arte possa essere uno strumento di conoscenza e liberazione.
Muore a Roma nel 1985, lasciando un’eredità culturale preziosa e un contributo fondamentale alla riscoperta delle donne nell’arte.
Nel romanzo “Artemisia”, Anna Banti intreccia profondamente la propria esperienza personale con la vita della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, dando vita a un’opera che fonde memoria, dolore e riscrittura creativa. La narrazione si apre con un’immagine intensa: nell’agosto del 1944, tra le macerie di una Firenze devastata dai bombardamenti, l’autrice si ritrova seduta sulla ghiaia del giardino di Boboli. La perdita che la affligge, però, non è solo materiale: sotto quelle macerie è andato distrutto il manoscritto a cui aveva lavorato a lungo, nel quale Artemisia era diventata una presenza viva, una “compagna di tre secoli fa” che respirava attraverso le pagine.
Nel cuore del romanzo, questo legame si incarna in una scena potente: Artemisia, mentre dipinge Giuditta e Oloferne, trasforma la tela in uno strumento di rivalsa. Circondata da dame affascinate dal modello maschile, la pittrice raffigura sé stessa nei panni dell’eroina e dona al volto di Oloferne le fattezze dell’uomo che l’aveva violentata. Il quadro non è solo arte, ma una vendetta postuma e una dichiarazione di identità: Artemisia non è una vittima né una figura mitica, ma una donna complessa e irriducibile.
Con Artemisia, Banti non scrive una semplice biografia, ma costruisce un ponte emotivo e intellettuale tra due donne separate dal tempo, accomunate dalla forza, dalla solitudine e dal desiderio di resistere all’oblio. In questo incontro tra Seicento e Novecento, tra storia e rovina, la scrittura diventa un modo per far vivere ancora una volta entrambe.
PASSO DEL LIBRO
Con Artemisia, Anna Banti non si limita a raccontare la vita della pittrice, ma la reinventa, restituendole una voce e una dignità artistica e umana. La scrittura è intensa, vibrante, capace di immergere il lettore in un mondo di passioni, violenze e lotte per l’affermazione personale e artistica. Artemisia Gentileschi emerge così come una figura emblematica, simbolo di una femminilità forte e creativa, ma anche di una sofferenza personale che ha saputo trasformare in arte. La struttura del romanzo richiama la pittura barocca, a cui sembra ispirarsi per l’impostazione delle sue scene: lunghe, statiche, più che raccontare eventi, ritraggono momenti emblematici della vita della protagonista. Le sequenze narrative appaiono come “quadri di lanterna magica lunare, piatti e freddi”, in cui le immagini scorrono e si fondono l’una nell’altra, sospese in una sorta di immobilità visionaria. Brevi lampi di luce mettono a fuoco, di volta in volta, ambienti e aspetti del temperamento di Artemisia: dall’infanzia segnata dal legame con la fragile Cecilia Nari, al trauma del processo per lo stupro subito da Agostino Tassi, fino al matrimonio riparatore imposto dal padre, e ai numerosi spostamenti (Firenze, Napoli, Londra), attraverso cui Artemisia cerca, con determinazione e inquietudine, di affermare la propria vocazione artistica.
Anna Banti con questo lavoro non ha solo scritto una biografia romanzata, ma ha contribuito a modificare la percezione culturale delle donne artiste, inserendole finalmente nel racconto storico con tutta la complessità della loro esperienza.