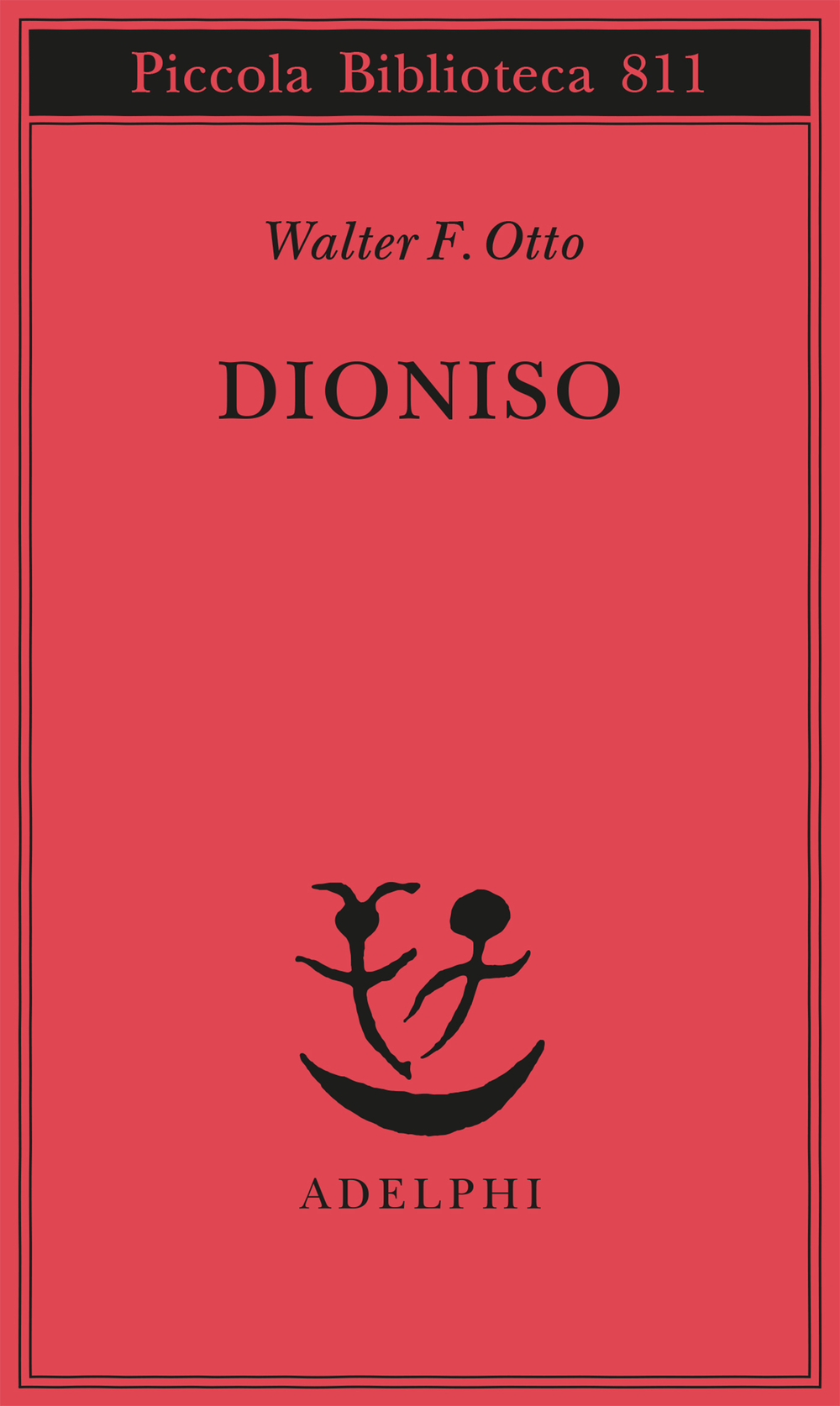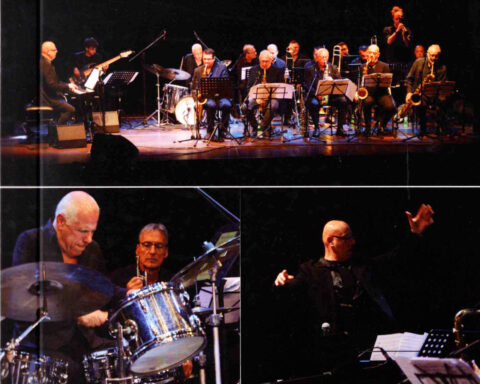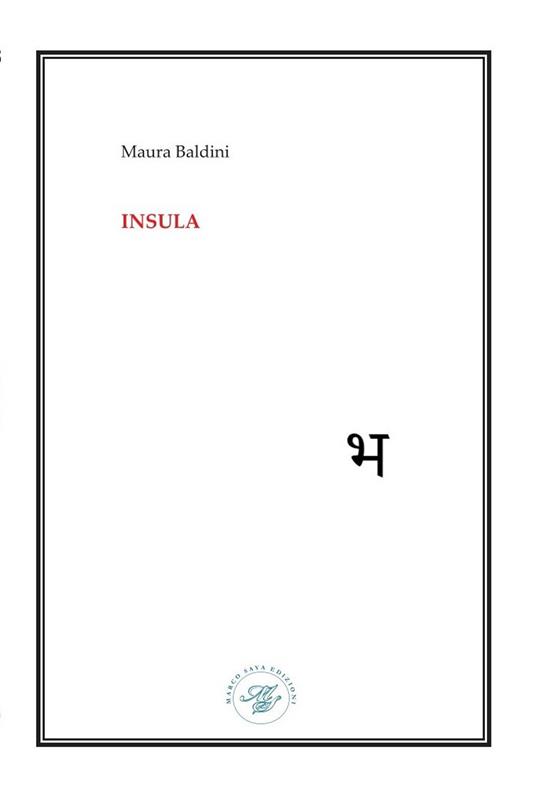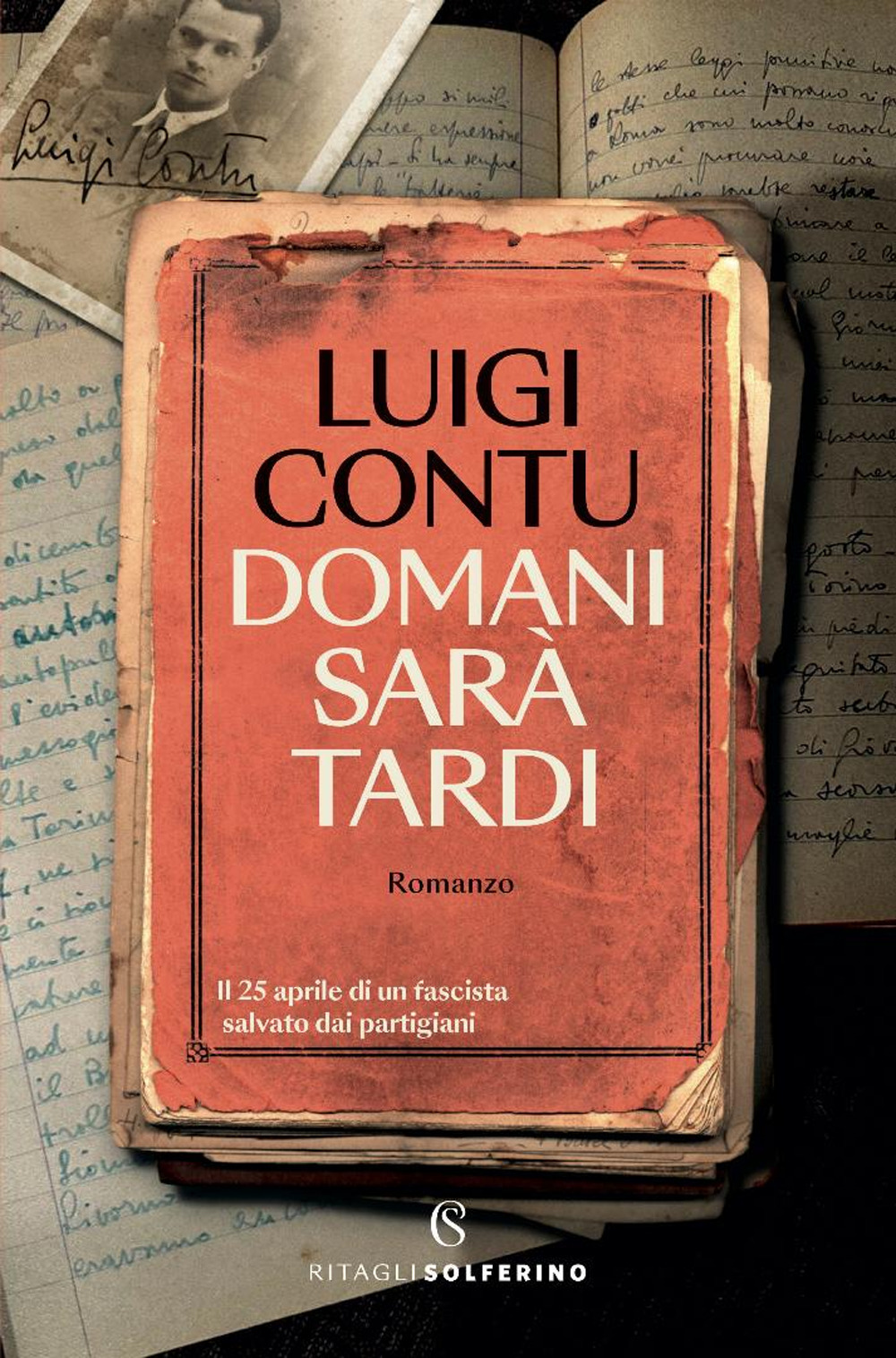Un dio furioso! Un dio, della cui natura fa parte l’essere folle! Che cosa avevano mai sperimentato o visto gli esseri umani a cui dovette imporsi una simile, inaudita rappresentazione? […] Chi genera qualcosa di vivo deve immergersi nelle profondità primigenie dove dimorano le potenze della vita; e quando riaffiora avrà negli occhi un lampo di follia, poiché laggiù la morte abita insieme alla vita. Lo stesso mistero primigenio è folle: è la matrice della duplicità e dell’unità del discorde. Non c’è bisogno per questo di rifarsi ai filosofi, anche se qui ci sarebbe da citare diversi passi di Schelling. Tutti i popoli e tutti i tempi lo testimoniano con le loro esperienze di vita e le loro usanze cultuali. Walter F. Otto, Dioniso, Adelphi, pag. 285. A cura di Giampiero Moretti che nella postfazione ci informa del libro uscito nel 1933 come terzo volume di una serie di studi sulle religioni e le culture dell’antichità che si concluderà nel 1938.
Sulla scia di Nietzsche, la grecità, se così si può definire una cultura unica nel suo rapporto con il divino, è quel fenomeno che non può essere affrontato né esclusivamente da un punto di vista filologico ricostruttivo e neppure da quella maniera retorica e dirompente di una prospettiva estetica, cioè la grecità come modello insuperabile di bellezza in un canone extrastorico valido in senso assoluto. Il successo del libro, come ben rimarca l’autore della postfazione, è la tesi straordinaria di Walter F. Otto (1874 – 1958) di una grecità che va inserita in un orizzonte di una percezione del divino che l’uomo greco realmente incontra non come qualcosa d’immaginato o escogitato come proiezione, ma come ciò che realmente accade ed è attivo nella forma di una spiritualità ontologicamente presente.
Secondo la tesi di Otto, condivisibile e ben espressa dal curatore, la presenza del divino costituisce l’origine del fenomeno religioso, una presenza che, presso i greci, assume sia forma del mito-racconto, sia la forma del culto azione (in ogni possibile variante di entrambe le forme, ognuna a suo modo fondata sull’originaria manifestazione del divino). In pratica, prima la presenza del divino poi tutto il resto. Scrive Otto: “Il divino si è manifestato a ogni popolo, e ha conferito carattere non soltanto ai culti ma, al contempo, allo stesso essere e agire di quei popoli, e ha dato la sua impronta al loro carattere di popolo. E tuttavia il divino di cui offre testimonianza la fede del popolo ellenico resta per noi eternamente memorabile per la sua profondità e la sua ricchezza”. Primo cardine del mito come del culto, quindi, è il divino.
Il sentire il divino da parte dei greci è una prerogativa essenziale dell’esistenza e della speculazione intorno all’essenza dell’essere cui Dioniso, secondo Otto, interpreta la divinità eccezionale e fondamentale alla comprensione sia di una cultura di una civiltà sia dell’esistenza stessa. Il concetto di Otto dell’Ergriffenheit, l’essere, il sentirsi afferrati dal divino, in qualche modo, rivela come l’imprescindibilità del divino resti ciò che di necessario si debba percepire del mondo come rapporto tra umano e divino. Una relazione che si dichiara, si annuncia come un movimento internamente e comprensibilmente reversibile: l’umano per il divino e il divino per l’umano. Qualsiasi esperienza non può fare a meno di questo binomio, pena la radicalità di un sentire che è sempre contraddittorio, Dioniso, infatti, è la divinità per eccellenza, dove convergono gli opposti. In Dioniso varie polarità contrapposte coincidono e deviano nello stesso istante in cui sembrano unite o distinte. Si avverte, in tal modo, una comprensione assoluta di ciò che è scissione, e di ciò che è separato. Vita e morte. Istinto e cautela. Bestialità e umanità. Spiritualità, misticismo e immediatezza. Piacere e dolore. Ebbrezza e sobrietà, calma. Fragore, tumulto e silenzio. Follia e ragione divergono sempre in un’unità che è l’essenza stessa del divino. Dioniso non è un Dio come gli Dei dell’Olimpo. La sua natura è mortale e immortale, nasce da Zeus e da Semele, donna mortale che lo partorisce prima che sia incenerita dal fulmine del suo sposo celeste. Il padre Zeus, scrive Otto, non lasciò che suo figlio perisse. Freschi rami di edera lo protessero dalla vampa in cui arse la madre. La sostituì lui stesso, accogliendo nel suo corpo divino quel frutto non ancora capace di vivere, per poi darlo alla luce quando il numero delle lune fu compiuto. È così che il “due volte nato” divenne dio – il dio del piacere ebbro – ancora prima del suo ingresso nel mondo, oltrepassando ogni dimensione umana. E tuttavia era destinato, lui, il portatore di gioia, al dolore e alla morte. E qui ha ragione Giampiero Moretti, Dioniso va incontro al particolare destino di rimanere ai margini del divino inteso in senso pienamente olimpico, il divino cioè che non viene per nulla, o appena, sfiorato dal dolore umano e del mondo visibile: l’essere destinato allo smembramento, all’essere dilaniato, è il marchio della transitorietà, di una sofferenza cui gli Olimpici sono per essenza sottratti, cui la forma stessa del divino “olimpico” è sottratta. Il libro di Otto, tuttavia, ha una cadenza filologica estrema che è bene affermare, i miti e i culti nonché le referenze letterarie sono precise e ben riportate, – si capisce anche quanto la narrazione del mito di Dioniso sia variegata spazialmente e non solo temporalmente – e quindi gli amanti di una ricerca dove Dioniso appare nelle sue varie e multiformi vesti troveranno nel volumetto referenze ben riportate sebbene in apparenza ne appesantiscono la lettura. Detto questo, ciò che è di notevole interesse è la prospettiva dell’approccio che nel ribaltamento e nelle distanze di ogni analisi precedente, anche alle pretese affinità con la religione cristiana, vede il mito di Dioniso, o meglio la figura di Dioniso come essenzialmente qualcosa di greco e non di asiatico. In gioco, e qui non si può non concordare con il curatore, c’è ben altro che dispute filologiche di attribuzioni o quant’altro, ma: il divino grecamente sperimentato e interpretato da Otto come un’eccezione nella storia dell’umanità testimonierebbe un rapporto uomo-dio-uomo che accade lì e soltanto lì, nella Grecia spirituale che è “ovunque”, ma non dappertutto, non comunque.
Il libro suddiviso in capitoletti a tema “Patria del culto di Dioniso”, “Il figlio di Zeus”, “I miti della sua epifania”, “Il dio folle”, e cosi via fino a contarne una ventina, ci conduce attraverso pagine affascinanti e filologicamente meticolose alla scoperta di un dio affascinante che immancabilmente ci riporta ad Apollo, alle letture strabilianti di Nietzsche e a quelle non meno acclamate e originali di Giorgio Colli. Presenza mistica o immediata, estatica o tragica, Dioniso si cristallizza in una ragione che comprensiva del suo aspetto irrazionale riduce la contraddittorietà a senso e significato in un dominio distintamente esistenziale e ontologico, ma soprattutto realmente accaduto e sperimentato in Grecia in un’eccezione nella storia dell’umanità. Nietzsche, in La volontà di potenza, così scrive: “Dioniso, sensualità e crudeltà. Si potrebbe interpretare la caducità come godimento della forza che genera e distrugge, come creazione costante”. Colli invece, in Dopo Nietzsche: “Tolto l’orrore della morte, anche il dolore è trasfigurato, è visto in una luce dionisiaca, poiché esso è uno strumento, una manifestazione della vita, non della morte. Nell’immediato c’è la radice del dolore, la violenza, ma anche della gioia, il giuoco. Dolore, gioia, morte esprimono l’immediato, appartengono alla vita”. Per dire come Dioniso è una cerimonia del divino, una folgorante lacerazione che imprime di sé non solo la civiltà ellenica ma ogni astrazione o riflessione novecentesca, che ha pensato l’abisso come possibilità di accedere a quella parte oscura e misteriosa che il logos, nella sua tradizione prima ecclesiale e poi positivista, aveva permeato la cultura dell’Occidente. Dioniso, ci ricorda Otto, è anche maschera. Non una non vita nella sua intrinseca fissità dello sguardo, ma l’essenza stessa della vita che è il vedere, l’avvistare, il distinguere. Dioniso è chi osserva. È il dio della presenza, una vicinanza che estranea. Così la maschera ci dice, scrive Otto, che la manifestazione di Dioniso, che si distingue da quella delle altre divinità per la sua chiara percettibilità e per la sua urgenza, è connessa con l’infinito enigma della duplicità e della contraddizione. E chissà magari che non sia tempo di proporre Dioniso come una categoria della conoscenza.
Walter F. Otto, Dioniso, Adelphi, pag. 285