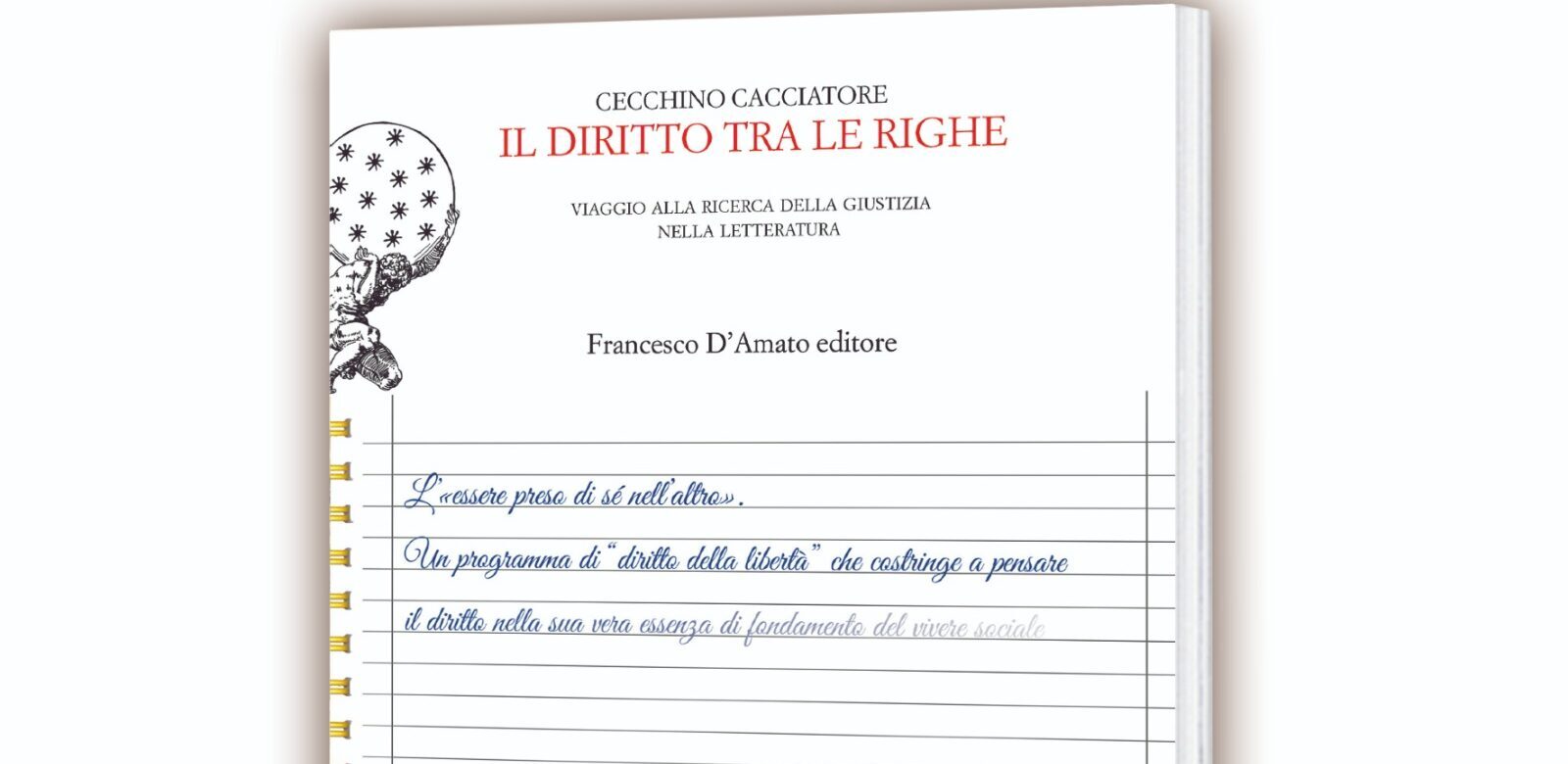Se il cielo è vuoto, se non si ha più nostalgia per il sacro, anzi lo si sbeffeggia, se non si crede più possibile una palingenesi sociale ed economica che radicalmente rimetta in ordine le ingiustizie tra chi vive (pochi) in una ricchezza esorbitante e tra chi (la stragrande maggioranza dell’umanità) è al di sotto dei livelli minimi di sussistenza, allora ci si richiude nel perimetro garantito ma stanco di una laicità borghese che non ha più molto da chiedere alla vita. Certo, sarà ancora possibile sfogliare in modo distratto e annoiato le pagine di Repubblica o mandare qualche invettiva a Salvini, come fa Piero nella “Collina di Euridice” (commedia di Paolo Puppa, Premio Pirandello ’96), o alzare muri intorno alle nostre rassicuranti villette a schiera con giardino e pitbull per paura dello “straniero”, ma resterà immedicabile l’incapacità di capire il senso più profondo dell’esistenza. Ed ecco, allora, che risulterà addirittura benemerita l’azione di un virus venuto da lontano o la guerra alle nostre porte per fare il lavoro tanto sporco quanto necessario di interrompere la catena generazionale. “Meglio sarebbe stato non nascere”, come dicevano un po’ retoricamente gli antichi greci e ribadito a gran voce dal grande Giacomino Leopardi nelle Operette morali, richiamato legittimamente da Puppa nella breve prefazione di un suo prezioso volume, “Il teatro della pandemia”.

Di fatto siamo ancora lì. E la drammaturgia di Puppa, a me pare, tutto questo ci ricorda impietosamente. Sono un uomo di teatro e sono portato ad analizzare i testi considerandoli come bocconi di carne e sangue. E di carne e sangue, ce n’è tanta nei testi di Paolo, anche se, a prima vista, questa carne e questo sangue risultano essere ben nascosti sotto lo sproloquiare fluviale dei suoi vari protagonisti.
Ma andiamo con ordine. A Paolo mi lega un’antica amicizia. Ho sempre letto con grande profitto i suoi libri e apprezzato il suo rigore di saggista e studioso, mi sono appassionato ai suoi salotti notturni (tanto da dirigere con la sua complicità a Salerno per più di dieci anni una rassegna di “Teatro della notte”, in tempi ormai lontani, con diversi altri compagni d’avventura quali Rino Mele ed Achille Mango) tra Pirandello, Ibsen, Rosso di San Secondo, Savinio e la drammaturgia borghese di fine ottocento e novecento; ho partecipato a tante iniziative che ci hanno visto coinvolti insieme fino ad arrivare alla riscrittura del “Giovanni Episcopo” di D’Annunzio che, divenuto il nostro “Episcopus”, ci vide lavorare fianco a fianco, Paolo come autore ed io come regista, in uno spettacolo che andò in scena alla “Leuciana Festival”, rassegna di teatro molto importante sul finire degli anni ’90 a Caserta Vecchia, con protagonista Francesco Silvestri, prematuramente scomparso, autore tra i maggiori del cosiddetto periodo post eduardiano e vincitore anche del premio UBU come migliore attore, successivamente, con Servillo. Fu in quella occasione che ebbi modo di apprezzare tutta la sua capacità, fiuto ed efficacia del grande drammaturgo. Anche lì, un lungo e fluviale monologo, suddiviso in tre parti che partiva a cose fatte, ad avvenimenti avvenuti. Il protagonista riviveva tutta la sua vita nel primo e terzo segmento del testo da un anonimo stanzone di ospedale psichiatrico e nel secondo (un vero e proprio “colpo di scena”) gettandolo incongruamente in uno studio televisivo moderno, in una trasmissione del dolore tipica di quegli anni e che dura ancora oggi, dove non si faceva e si fa nessuno scrupolo a riversare su platee allargate i dolori personali della povera gente che ignara si confessa pensando così di avere il suo quarto d’ora di celebrità come una giusta ricompensa, come un feroce risarcimento alla propria vita così miserabile. Un monologo, che prima di tutto, non era mai solo un soliloquio, ma che tendeva piuttosto a farsi dialogo, o quanto meno a proporsi come partitura di un virtuale canone a due voci, dato che sempre presupponeva la presenza muta di un ascoltatore/spettatore. Emma Grimaldi, a tale proposito, scriveva nella prefazione al testo pubblicato nella collana di teatro “corponovecento” nel lontano 2005, ”(…) Presenza simultanea, sulla quale, come su una lastra di specchio, il flusso discontinuo, spesso divagante o ripetitivo, di quell’unica voce, si riflette consapevolmente, lasciandosi sorprendere nell’atto di spiare, soppesare, le reazioni suscitate dal suo raccontare. Un raccontare che nel suo elaborarsi, già si è dato i modi della recita”.
Ora, vengo al punto. Diciamocelo francamente, ma credo che lo stesso Puppa ne sia consapevole, questo modo di intendere la drammaturgia è un po’, diciamolo pure “fuori corso”. In un’epoca post drammatica dove i testi di parole se ci sono (e ce ne sono certamente) timidamente s’affacciano su una scena sempre più dominata da post-registi e attori performer che hanno decisamente cancellato la loro subalternità ai personaggi; una scena dove c’è sempre meno spazio per personaggi in preda ad una bulimia logorroica, ossessiva e disturbante. Oggi i palcoscenici sono pieni di corpi spesso molto svestiti che si muovono, urlano, smaniano, e testi come quelli di Paolo (una volta messo all’angolo anche il teatro di narrazione che pure ha avuto un momento molto fortunato) che hanno invece una fiducia senza limiti nella parola che può essere sì fraintesa (il padre dei Sei personaggi docet), ma è e resta pur sempre l’unica possibilità (simulando o dissimulando) per testimoniare il nostro passaggio e la nostra presenza sulla scena del mondo. In realtà, noi siamo esseri di un giorno (torno ancora una volta ai nostri amati greci), presto dimenticati (sopravviveremo a una, massimo due generazioni, ai nostri figli e /o nipoti, se abbiamo lasciato loro una buona memoria, o qualche proprietà con un po’ di soldi), e quindi non possiamo far altro che, almeno per un po’, trovare qualcuno che ci ascolti. E questo, seppure solo per un momento può renderci meno infelici e darci l’illusione di una piccola immortalità. Ma questo, più in generale, è anche il compito del teatro: riportare momentaneamente in presenza “l’assente”.
Ecco, allora, e concludo l’altro aspetto della drammaturgia di Paolo. Per scrivere questi lunghi monologhi egli si fa abile e capace ascoltatore. Solo uno che ascolta può, poi, come un fedele testimone restituire con appassionata pietà le vicende di tanti uomini, donne devastate da una scontentezza infinita. Paolo ama così tanto i suoi personaggi che sempre più spesso se ne fa loro interprete. E qui, la nostra sorpresa è forte, si resta dapprima ammirati e poi via via sempre più impressionati dalla capacità vorace del Puppa performer, che con la sua totale adesione empatica ci espone ad una “prossimità persino disturbante”, come dice molto convincentemente Nicola Pasqualicchio in un saggio riportato nel volume, “Tra Venezia e Saturno”, in suo onore. Di questa cosa ne ho avuto anche recentemente contezza. Proprio a Salerno, in occasione di una giornata dedicata a Gennaro Vitiello, un grande della sperimentazione teatrale degli anni ’50 e ’60 napoletana, a conclusione dello stesso, Puppa ha letto uno stralcio del suo, “Non rinuncio a te per un pipistrello ovvero diario del virus”, lasciando la platea del teatro a bocca aperta. Sconcertata, certamente per il disturbante contenuto, ma al tempo stesso, ammirata per la camaleontica capacità mimetica del Puppa professore calato con una tale impressionante adesione nel virus assassino dandogli voce e gesti di una impressionante credibilità. Qualità, questa, riservata solo ai grandi interpreti.