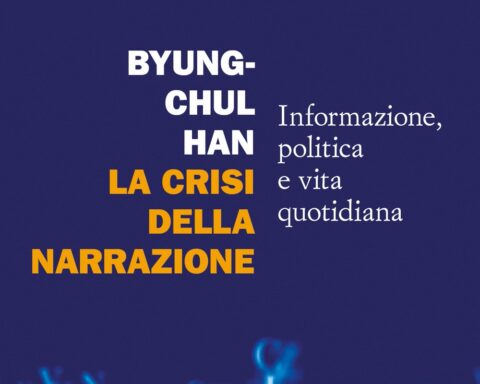A cinque anni dall’emanazione del decreto legislativo che impose l’isolamento in Italia, riflettere sugli effetti della pandemia da Covid-19 rimane essenziale per comprenderne l’impatto non solo sotto il profilo sanitario, ma anche in termini geopolitici, sociali e, soprattutto, psicologici. Un evento di portata epocale che si tenta, spesso maldestramente, di relegare all’oblio collettivo, ma che ancora oggi lascia segni profondi nella società. Sebbene possa sembrare prematuro riaprire le ferite di quel periodo, è necessario analizzarne le conseguenze collettive e individuali prima che il tempo le cristallizzi, assimilando l’anomalia come parte integrante della normalità. Perché no, non è stato un evento normale.
La tendenza a dimenticare può avere una funzione terapeutica, come insegna la tragicommedia Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo, rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un pubblico inizialmente riluttante a rivivere gli orrori del conflitto si ritrovò, al termine della rappresentazione, immerso in un silenzio assordante, sopraffatto dall’emozione, prima di cedere a pianti e abbracci liberatori. Questo ci porta a una domanda fondamentale: fino a che punto è opportuno dimenticare? E quanto del contesto sociale attuale è stato silenziosamente plasmato dagli eventi della pandemia?
Tralasciando l’aspetto legato alla mortalità, già ampiamente documentato nei bollettini medici che entravano quotidianamente nelle case chiuse tra il 2020 e il 2021, è cruciale soffermarsi sulle ripercussioni del lockdown e della condizione di isolamento. Questo periodo non solo ha modificato radicalmente la quotidianità degli italiani, ma ha anche messo in evidenza una falla sistemica a lungo occultata: l’ossessione per la produttività. Una produttività smodata, incessante, considerata imprescindibile per il funzionamento della società contemporanea.
Vittime dell’ossessione
per la iper-produttività
Questa ossessione per la produttività e la performance, che caratterizza la nostra società, è stata brillantemente descritta da Byung-Chul Han. Secondo il sociologo, la nostra cultura moderna si è trasformata in una “società della performance”, dove l’individuo non è più solo un oggetto di sfruttamento, ma un’autosfruttante macchina performativa. Ogni individuo è chiamato a superare continuamente i propri limiti, a ottimizzare la propria esistenza in un ciclo incessante di realizzazione e successo. In questo contesto, l’individuo non è più vittima della disciplina esterna, ma diventa autore della propria prigionia, costretto ad autoimporsi la continua spinta a performare. L’iperproduttività diventa un imperativo culturale, dove il valore di una persona è misurato dalla sua capacità di essere sempre più performante, sempre più ottimizzata.
Nei successivi anni post-pandemici, in particolare tra Millennials e Generazione Z – ribattezzata anche Covid Generation – è emerso un fenomeno che inizialmente ha generato sensi di colpa e inadeguatezza: la nostalgia per il lockdown. Da un sentimento isolato e inespresso, è nato un riconoscimento collettivo, un’eco che ha attraversato gruppi di giovani, i quali hanno iniziato a interrogarsi sulla natura di quel periodo e sul perché, a distanza di anni, in alcuni momenti sembrasse mancare. Un fenomeno che ha assunto sempre più rilievo, slegandosi progressivamente dalla dimensione sanitaria e dal lutto per concentrarsi sulla sospensione temporanea di ritmi imposti e sulla percezione di un tempo finalmente disponibile e condiviso.
Il fenomeno della quarantine nostalgia, esploso sui social e in particolare su TikTok, ha accumulato oltre 80 miliardi di visualizzazioni e interazioni, testimoniando la complessità di un sentimento apparentemente paradossale: il desiderio di tornare a un periodo in cui il mondo era immerso in un evento traumatico.
Si ha tanta voglia
di tempo rallentato
Se si prescinde per un momento dalla dimensione sanitaria, il lockdown ha rappresentato per molti, soprattutto per i più giovani, un’improvvisa sospensione della frenetica corsa alla produttività. Il tempo ha assunto un ritmo diverso, non più scandito da esami, concorsi, scadenze, né dalla necessità di una vita sociale incessante per evitare il timore di rimanere indietro. Era un tempo sospeso, uguale per tutti. Nessuna competizione, nessun confronto. Nessun articolo sensazionalistico a celebrare l’impresa di un ventenne laureato in tempi record, capace di alimentare in altri un senso di sconfitta e frustrazione che, in troppi casi, sfocia in gesti estremi e disperati.
All’improvviso, le persone hanno avuto il tempo di dedicarsi alle proprie passioni, di sperimentare senza la pressione della performance, esplorando dimensioni dell’esistenza meno legate alla prestazione immediata e al consumo frenetico. La possibilità di riappropriarsi del tempo per sperimentare senza la pressione di dover continuamente ottimizzare le proprie attività ha creato uno spazio autentico di comunità, in cui non era più il risultato materiale a contare, ma la qualità dell’esperienza stessa. In questo contesto, attività tradizionali come la cucina o la cura di sé non sono diventate semplicemente un ritorno a forme di socialità superficiali, ma un’occasione per riconsiderare la relazione tra individuo, tempo e produzione, ricollocando questi elementi in un quadro più umano, meno assoggettato alle logiche di prestazione imposte dal sistema produttivo.
Il lockdown ha offerto l’opportunità di mettere in discussione le proprie scelte di vita e di valutarle sulla base di ciò che realmente conta, svincolandosi dalle pressioni esterne. In un mondo improvvisamente fermo, rallentare la corsa e seguire il proprio ritmo non era più fonte di senso di colpa. Ma una volta tornati alla normalità, la corsa non solo è ripresa, ma ha accelerato ulteriormente.
Tanti più giovani
in psicoterapia
Oggi, l’aumento dei giovani che ricorrono alla terapia psicologica è un segnale inequivocabile. Il fenomeno della FOMO (Fear of Missing Out), già pervasivo prima della pandemia, si è intensificato, portando con sé ansia, depressione e attacchi di panico. E se tutto questo fosse una conseguenza non della pandemia in sé, ma della consapevolezza che essa ha generato? Se il Covid-19, pur nella sua drammaticità, avesse svelato le fragilità di un sistema che impone ritmi disumani? Se il lockdown avesse concesso, per la prima volta, la percezione di avere davvero tempo, per poi infrangere questa illusione con un ritorno alla realtà ancora più spietato?
Il ritorno alla normalità non ha rappresentato un semplice ripristino delle dinamiche pre-pandemia, ma un’accelerazione di quei ritmi, intensificati da una rinnovata precarietà, sia esistenziale che economica.
Anche dal punto di vista globale, il lockdown ha avuto impatti ambivalenti, tra i quali emergono, tuttavia, alcuni benefici inaspettati. La sospensione delle attività industriali e il drastico calo della mobilità hanno contribuito a una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, tanto che alcune delle più grandi metropoli mondiali hanno registrato una temporanea purificazione dell’aria e una riduzione dell’inquinamento acustico. Sebbene il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua siano stati di breve durata, essi hanno avuto il merito di aprire una riflessione globale sulle politiche ambientali e sul nostro impatto quotidiano sul pianeta.
Questi temi sono particolarmente rilevanti per la Generazione Z, una coorte che si trova ad affrontare un mondo segnato da crisi ecologiche, disuguaglianze sociali e economiche, nonché da un riscaldamento globale sempre più incombente. La Gen Z, dunque, si trova a dover raccogliere i cocci di un mondo che, in gran parte, è stato distrutto dalle generazioni precedenti. In risposta a questa eredità, la nuova generazione sviluppa un senso di responsabilità collettiva che si traduce in una crescente ansia per comportamenti ritenuti non etici o dannosi per l’ambiente. In un mondo che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto la temporanea sospensione della frenesia produttiva e dei meccanismi di consumo, molti giovani hanno avvertito una sorta di “respirazione” collettiva, una parentesi di respiro — aria non inquinata — che ha consentito loro di scollarsi, anche se solo per un attimo, dal perpetuo senso di responsabilità.
Ragazzi alla ricerca
di un posto nel mondo
Eppure, proprio mentre le nuove generazioni si trovano ad affrontare le sfide globali più urgenti, come il cambiamento climatico, e le difficoltà interpersonali, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il ritorno alla normalità non ha fatto altro che esacerbare la sensazione di precarietà. In un contesto in cui la stabilità appare sempre più come una chimera, il desiderio di riappropriarsi di quel tempo sospeso, di quel respiro profondo che solo la pandemia aveva saputo offrire, si è trasformato in una vera e propria forma di resistenza. In questo scenario, il lockdown si erge come un simbolo di un’epoca che non esiste più, ma che al contempo racchiude una lezione fondamentale: la vita non può essere ridotta a una corsa incessante, né a una performance che non conosce tregua. Il sistema imposto alla nostra società ha rivelato la sua frenesia, ma anche la sua insostenibilità. Le nuove generazioni, pur consapevoli delle sfide, sono chiamate a riflettere su come attribuire valore al proprio tempo. La pandemia ha insegnato che, a volte, fermarsi è indispensabile per poter andare avanti. Tuttavia, è stato proprio il modo in cui il flusso della vita ha ripreso a scorrere, al termine del lockdown, a rivelarsi traumatico per molti. La vita non solo ha ripreso il suo ritmo naturale, con la sua corsa affannosa, ma ha anche modificato in maniera tangibile i concetti sociali, economici e politici. La sensazione di precarietà, che è sopravvissuta al termine di questo periodo, continua a aleggiare nella vita dei giovani e degli adolescenti. La consapevolezza che qualunque evento possa accadere, che le situazioni apocalittiche, un tempo patrimonio esclusivo del cinema thriller, possano manifestarsi nella realtà, come nel caso della pandemia, ha generato una diffusa sensazione di instabilità, trasformandosi in una perenne ansia. Anche sul piano economico, l’inflazione e l’aumento dei prezzi alimentano una condizione di instabilità. Pertanto, sebbene sia indubbio che negli ultimi cinque anni le nostre esistenze siano state stravolte, il sentimento di nostalgia legato al lockdown ha fatto emergere un aspetto significativo, soprattutto nei giovani e negli adolescenti: la necessità di ritagliarsi delle pause da un flusso incessante della vita che non concede sosta.