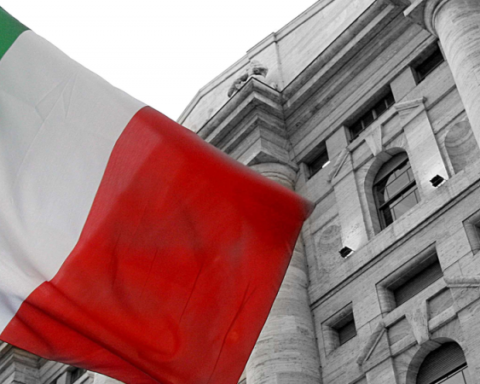In Italia si contano numerose associazioni di medici artisti, sezionate anche in categorie: scultori e pittori, fotografi, poeti e scrittori. L’approccio all’arte ha motivazioni diverse, le più comuni sono la via di fuga dalla realtà avvertita come usurante e l’attitudine individuale, che cresce e non molla. Quando si parla di medici artisti, il pensiero vola dritto verso Pianeta Jannacci. Burlone e anti-sistema, distante dai recinti, di fronte al coinvolgimento associativo nella sezione musica e spettacolo, risponderebbe con i versi modificati di una canzone: “Si potrebbe andare tutti allo zoo comunale. Vieni anche tu? No, io no!”
Enzo Jannacci è morto di cancro il 29 marzo del 2013 nella sua Milano più che da bere … da digerire con la cinarina. Uomo poliedrico (musicista e cantautore, cabarettista e scenografo), icona assoluta della scena musicale del dopoguerra, rifiuta ogni etichetta definendosi “medico fantasista”. Diplomato al Conservatorio milanese Giuseppe Verdi e medico specialista in chirurgia generale, lavora in Sud Africa al fianco di Christiaan Barnard, il cardiochirurgo del primo trapianto cardiaco; completa, in seguito, la formazione in chirurgia toracica presso la Columbia University di New York. Nonostante gli studi al Conservatorio, il lavoro discografico e la collaborazione con artisti immortali – tra i tanti Giorgio Gaber, Dario Fo, Luigi Tenco – non rinuncia mai all’esercizio della professione medica ospedaliera e come medico di famiglia, fino all’età pensionabile. Fermo sostenitore dalla Sanità pubblica e delle risorse da impegnare in tale direzione ai fini di un Sistema Sanitario Nazionale efficiente e democratico, negli ambienti milanesi viene definito “il comunardo”. Di certo è un filantropo che guarda i più deboli, gli illusi e i disillusi: uomini e donne senza proscenio nei suoi testi balzano alle luci della ribalta sociale. “El portava i scarp del tennis”, canzone in dialetto milanese, scritta nel 1964 in collaborazione con Dario Fo, racconta del barbone in zona Forlanini, che cambia strada e cartone senza lasciare qualcuno o qualcosa e quando ritorna, trova il solito niente. Ma in tale intreccio di libertà e solitudine, insegue il suo bel sogno d’amore. In molti testi di Jannacci emerge l’attenzione verso il triangolo industriale, al cui interno vibra la difficile integrazione tra padroni e operai, macchine e muscoli, cittadini del nord e quelli provenienti dal sud in cerca di una migliore fortuna.
Tra i personaggi narrati c’è “Vincenzina”, la donna che “tutti i giorni vive la fabbrica e non esiste null’altro che fabbrica”, c’è Bobo Merenda, inconsapevole assemblatore di bombe, che perde la vita in un’esplosione e rimane di lui la metafora di una lente a contatto. Nella storia di “Mario”, sopraffatto da quell’assordante rumore di fondo delle città, perde la voce, e si respira altra solitudine. Il tormentone del brano “Quelli che” è stato definito un vero trattato di antropologia nazionale: “Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeh. Quelli che fanno l’amore in piedi convinti di essere in un pied-à-terre. Quelli che l’ha detto il telegiornale, oh yeh.” Surreale e ironico cantastorie, coglie il lato drammatico della vita, spoglio da ogni retorica e stucchevole compassione, questo e molto di più è Enzo Jannacci. Oh yes!