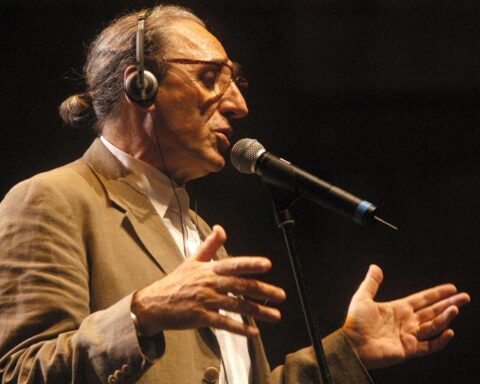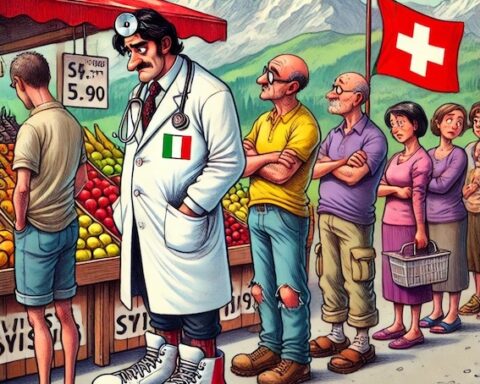C’è chi sceglie in autonomia di programmare la propria morte e chi, nonostante le condizioni di salute avverse, lotta con le esigue forze per continuare il suo percorso esistenziale. Perché, come recita il detto, “la speranza è l’ultima a morire.” Nel primo caso rientrano Ellen e Alice Kessler, che hanno premeditato le modalità e la data di un finale domestico. Le gemelle sassoni, da sempre simbolo di emancipazione, hanno optato, all’età di 89 anni, per il suicidio assistito tramite l’iniezione endovenosa del tiopentone sodico: un barbiturico storico, utilizzato per la protezione cerebrale nei casi di ipertensione endocranica e in anestesia generale come ipnoinduttore, prima dell’avvento del propofol. Gli effetti farmacologici del tiopentone sono legati alla particolare liposolubilità, che consente il rapido passaggio attraverso la barriera ematoencefalica con perdita immediata della coscienza profonda fino all’arresto delle funzioni vitali.
Il caso Kessler ha sollevato un vespaio di polemiche e reazioni contrastanti nell’opinione pubblica e nelle varie fazioni politiche, divisi in due fronti: uno a sostegno del libero arbitrio anche nella gestione della propria morte, l’altro contrario alle decisioni autonome nel rispetto della vita intesa come dono prezioso e sacro. La complessità del tema coinvolge più punti, tra questi: la libertà e la dignità del singolo, l’etica sociale e la deontologia professionale medica. Cos’è il suicidio assistito? Una pratica in cui è richiesta l’assistenza medica nella valutazione del caso con le opportune informazioni e nella prescrizione dei mezzi necessari per raggiungere l’obiettivo. Ma è la persona stessa ad eseguire l’atto finale. Pertanto va distinto dall’eutanasia attiva e da quella passiva: nella prima il sanitario è parte attiva nella somministrazione del farmaco letale, mentre la passiva consiste nell’interruzione di terapie e mezzi strumentali (macchine di ventilazione o devices di assistenza ventricolare e polmonare) di sostegno vitale.
Il pensiero laico di bioetica contemporanea attribuisce un valore prioritario all’autonomia della scelta: “La vita è soggettività e autodeterminazione. Ogni individuo dovrebbe poter scegliere liberamente come vivere e come morire.” Concetti inaccettabili per la morale cattolica, che considera tali libertà una minaccia ai valori fondamentali dell’uomo, anche in considerazione di possibili strumentalizzazioni delle persone fragili e non da ultimo il rischio che il desiderio di farla finita in particolari momenti diventi una scelta senza ritorno. Diversi Paesi hanno legalizzato il suicidio assistito. La Svizzera figura come il primo al mondo che, nel range di alcune condizioni, ha provveduto a depenalizzarlo. Spetta, invece, ai Paesi Bassi il primato di aver reso legali dal 2002 il suicidio assistito e l’eutanasia. In ambito europeo seguono Belgio, Lussemburgo e Spagna. E, ritornando al caso Kessler, la Germania, grazie alla sentenza Costituzionale Federale, nel 2020 ha riconosciuto il diritto di fine vita – “beihilfe zum freitod” – in maniera autonoma o con l’aiuto di terzi. Di fatto le Kessler hanno agito da sole, in presenza di un medico e dell’avvocato di fiducia. L’eutanasia attiva non è legale in Italia. In base alla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, sarebbe possibile, in mancanza di una legge ancora ferma in Senato, il suicidio medicalmente assistito o eutanasia passiva nel rispetto di quattro parametri: la patologia irreversibile, le gravi sofferenze fisiche e psicologiche, la dipendenza dai trattamenti di sostegno vitali e le piene capacità cognitive del soggetto richiedente.
L’Associazione Luca Coscioni si batte da anni per la libertà di autodeterminazione della persona gravemente ammalata, sostenuta dai sondaggi che evidenziano un ampio consenso popolare a favore di una legge sul suicidio assistito e sull’eutanasia. E viene fuori quanto la politica sia indietro rispetto agli obiettivi associativi e all’opinione pubblica. Per quanto riguarda i sanitari, oltre la questione morale, non esiste una posizione unica. In molti casi essa converge sulla difficoltà nella valutazione di punti salienti: la reale irreversibilità della malattia, il reale valore dell’autodeterminazione del paziente e il timore di derive sociali che sfocino nella “normalizzazione” della morte assistita. Il dibattito rimane aperto. Ma nel dialogo tra dubbi professionali e valori personali diversi, può nascere un equilibrio capace di coniugare cura, umanità e libertà.