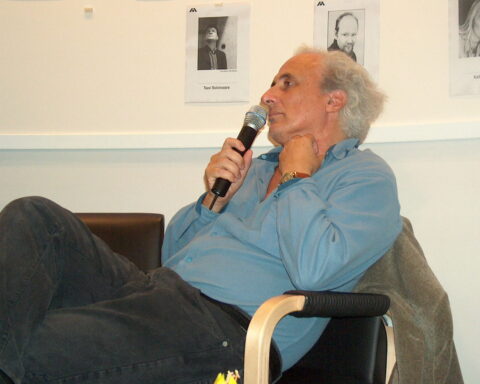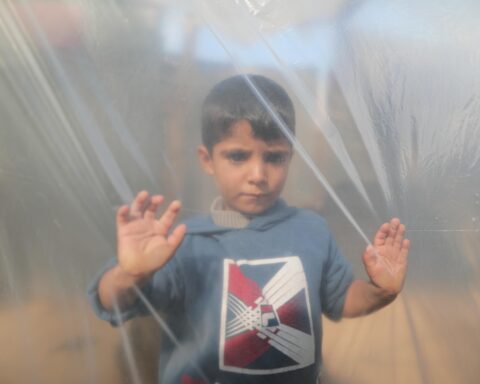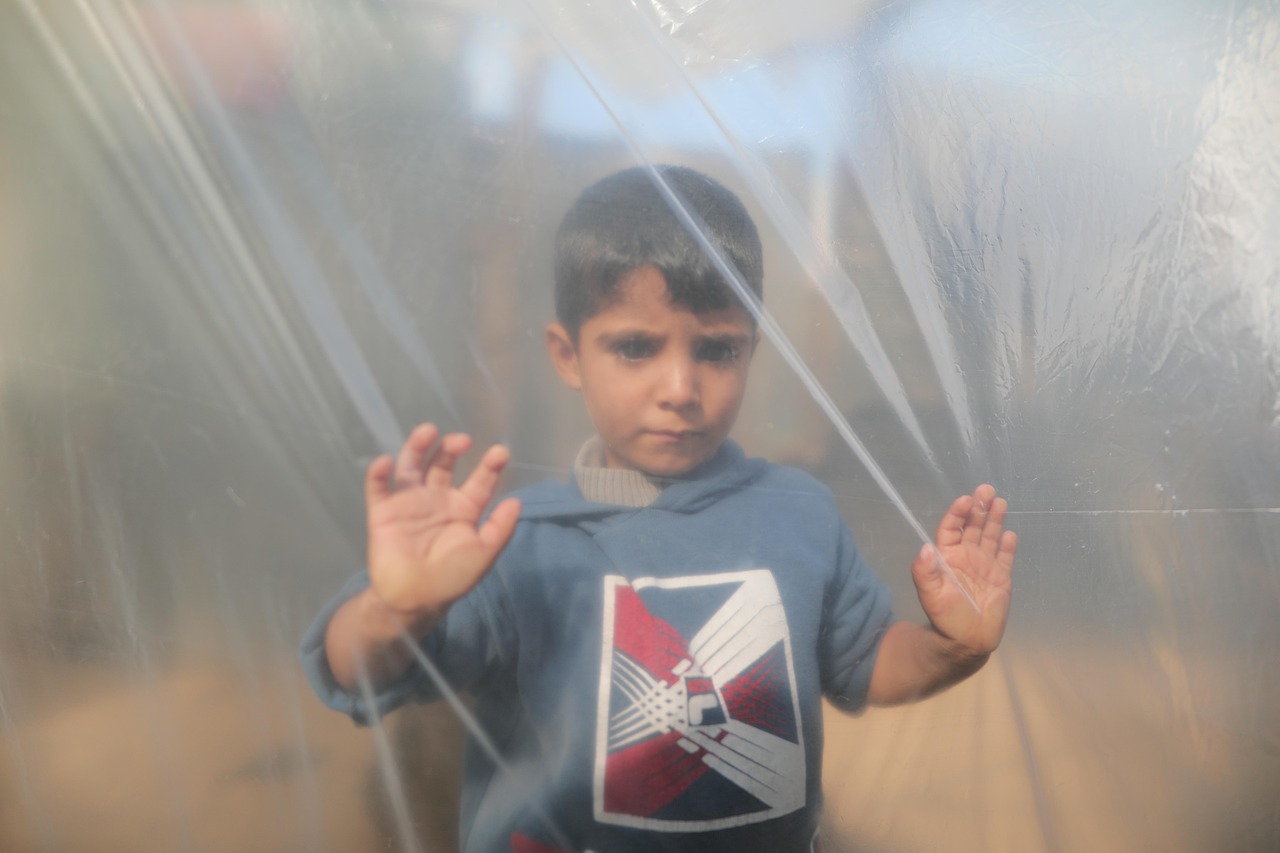L’adagio 201 di Erasmo da Rotterdam ha per titolo ‘Conviene nascere o re o matti’ (‘Aut regem aut fatuum nasci oportet’), espresso all’inizio della cruda satira dell’Apocolocyntosis, (la ‘zucchificazione’ dell’imperatore Claudio), scritta da Seneca nel 54, alla scomparsa dell’inetto e feroce tiranno che lo aveva condannato all’esilio. L’adagio 201 è scritto dopo il 1513, non molto dopo il ritrovamento della satira di Seneca, il riferimento alla quale apre la prima parte di quello che appare un piccolo trattato sul potere, utilizzando riferimenti mitici e storici per definire i caratteri della follia dei potenti e dei tiranni: “Invero, ragiona Erasmo, nell’antichità come anche dopo chi potrà attribuire senno ad Agamennone o ad Aiace, poi a Creso o Serse, a Nerone o a Caligola o Eliogabalo? E ancora oggidì non si vedono prìncipi, anche cristiani, unicamente vanitosi e oziosi, tutto fuorché filosofi, come richiedeva il divino Platone?”.
La seconda parte dell’adagio anticipa, le tematiche che saranno al centro della più strutturata ‘Institutio principis christiani’ del 1516, in cui si elencano le virtù dell’ottimo ‘princeps’ cristiano, teso a perseguire l’interesse collettivo: un trattato “in cui l’umanista olandese prospetterà un compiuto ed elaborato progetto di educazione del principe e fornirà un prontuario d’indicazioni, massime e consigli relativi all’arte del buon governo” (Elisa Tinelli).
«Anneo Seneca era uomo di intelletto piacevolissimo, riporta un adagio in quell’operetta di cui abbiamo appena detto (Apocolocyntosis 1,1): “Conviene nascere o re o sciocco”. Ma è meglio citarlo con le sue stesse parole: “Io”, dice, “so di essere divenuto libero da quando è morto l’uomo che aveva realizzato il proverbio ‘Conviene nascere o re o sciocco’”. E ancora nel medesimo libretto: “Ha ucciso in una sola casa Crasso il Grande, Scribonia, Bassionia, gli Assarii, benché nobili, Crasso, poi, tanto sciocco che avrebbe anche potuto esser re”. Di nuovo in un altro passo: “Ha interrotto la durata regale di una stupida vita”. Ora se davvero Esiodo ha scritto che non è certo cosa da nulla ciò che diviene celebre nella lingua popolare, forse non sarebbe fuori luogo indagare cosa abbia dato luogo a questo proverbio, che congiunge due concetti tanto dissimili, il re e lo sciocco, in modo che entrambi appaiano similissimi l’uno all’altro, tanto più che il merito peculiare dei re e il solo veramente regale è superare tutti gli altri per saggezza, lungimiranza, prudenza. Ne consegue dunque che i famosi re antichi erano notevolmente caratterizzati da stoltezza, come si può apprendere in parte dai racconti dei poeti e in parte dalle memorie degli storiografi. Giacché Omero ha imitato il suo Agamennone e i tragici Omero: lo ritraggono ambizioso piuttosto che assennato. Quale stoltezza più grande che comprare il titolo di comandante a prezzo del crudelissimo assassinio dell’unica figlia (Ifigenia, ndr)? Quale stupidaggine più grande che sguainare la spada per una fanciulla barbara in modo tanto infantile da sottrarre ad Achille la sua amante, non potendo conservare i propri amori, e questo certamente non senza una gravissima spaccatura dell’intero esercito (…). Inoltre, com’è poco saggio lo sdegno di Aiace! Com’è senile il deliro di Priamo mentre, abbracciando Elena, donnetta dal pudore prostituito, e chiamandola figlia, afferma di non essere pentito della guerra nella quale aveva ricevuto tante sconfitte, era stato privato di tanti figli, tante volte funestato dal lutto, perché Paride si impadronisse dell’amante! Perché farla lunga? Tutta l’Iliade, in tutta la sua lunghezza, non contiene nient’altro che, come ha elegantemente scritto Orazio, “un mare di re e popoli stolti” (epistole 1,2,8). Eppure anche l’Odissea ha i suoi proci e gli Alcinoi, grossolani e stupidi. Anzi, si ritrae persino Ercole forzuto e animoso, ma di intelletto ebete e grossolano. Già Esiodo, che alcuni vogliono più antico di Omero, chiama i re doróphagoi (mangiatori di doni) e népioi (sciocchi). Credo perché sia sapevano poco riguardo all’amministrazione dello stato sia aspiravano all’accumulo di ricchezza in tutti i modi leciti e illeciti piuttosto che agli interessi comuni del popolo. Si dipinge così anche il famoso Mida, insignito di orecchie d’asino per la sua ottusità. E non so se sia pertinente a questo argomento anche il fatto che gli antichi teologi, senza dubbio dei poeti, assegnano ad Apollo e Pallade la sapienza, a Giove, sovrano degli dei e degli uomini, invece, lasciano il fulmine, il tridente e il famoso cenno del capo e il sopracciglio col quale fa tremare tutto l’Olimpo. Del resto quale perdigiorno, quale buffone hai mai detto più buffonate in modo più buffonesco o è stato sregolato in modo più sregolato di costui, al quale hanno dato il regno del mondo? (…) Ma per venire alla storia più recente e lasciar stare le favole, che testa infine credi che avesse Creso, re di Lidia – se pure fu tale quale lo ha dipinto Erodoto –, che, confidando nelle gemme e nell’oro accumulato, si indignava con Solone perché non gli aveva assegnato l’epiteto di felice?O cosa si può immaginare di più stolto di Serse, quando inviava legati al monte Athos e lo cercava di intimorire con lettere molto offensive e minacciose, quando ordinava di infliggere un certo numero di frustate al mare Ellesponto? E non è stata minore la regale pazzia del famoso Alessandro il Grande, quando gioiva di essere salutato come il figlio di Giove, disconosciuto il padre, mentre faceva a gara col vino, mentre nei banchetti ostentava di essere adorato come un dio dagli adulatori, mentre si lamentava che questo mondo fosse stretto per le sue vittorie e, entrando nell’Oceano, cercava altri mondi da conquistare. Per non citare poi i Dionigi, Tolemei, Giulii, Neroni, Tiberii, Caligola, Eliogabali, Commodi, Domizii, uno dei quali ha rivendicato il nome di dio, essendo indegno della parola ‘uomo’, un altro si è consegnato per intero alla derisione degli adulatori, un altro per ambizione ha scosso rovinosamente il mondo intero con tumulti assolutamente folli. Ma giustamente sembrerei sciocco io, che comincio questo catalogo e cerco, come si dice, l’acqua nel mare».
Erasmo da Rotterdam, Adagio 201 (trad. Emanuele Lelli).