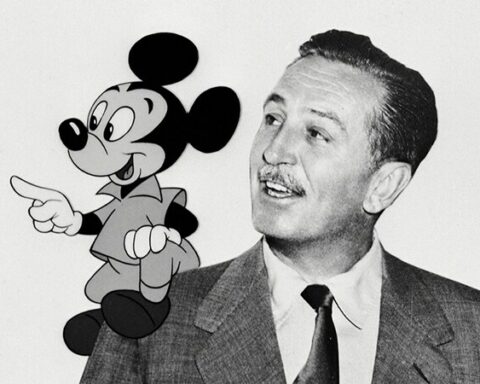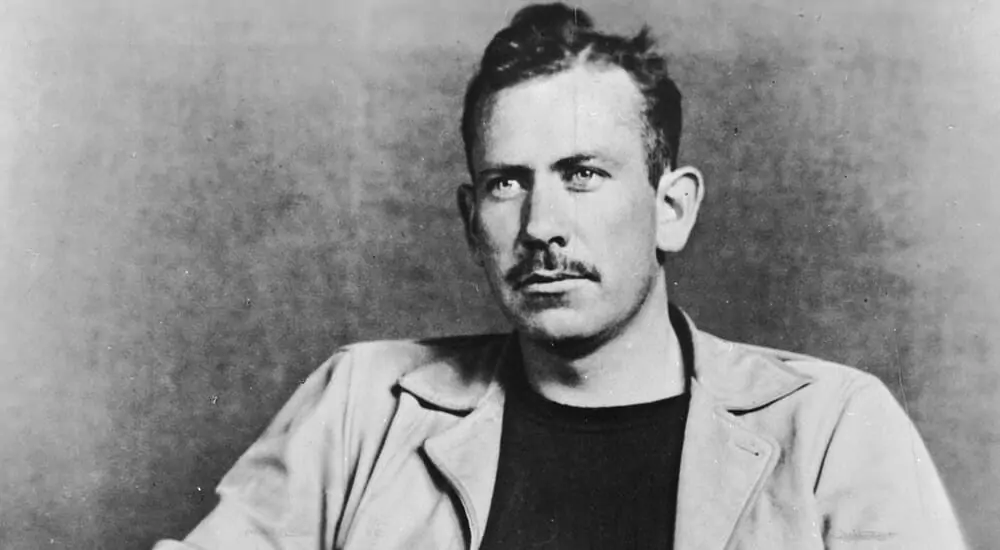“Dovremmo leggere soltanto quei libri che ci fanno male e ci feriscono. Se il libro che stiamo leggendo non ci sconvolge come un colpo alla testa, perché ci dovremmo prendere il fastidio di leggerlo?”
Franz Kafka
L’arancia meccanica. Tre capolavori in uno: quello dell’autore del libro, il britannico Anthonj Burgess, considerato uno degli scrittori più rappresentativi del Novecento, della traduttrice per l’italiano Floriana Bossi, e del regista dell’omonimo film, lo statunitense Stanley Kubrick. Si tratta di un libro letto per la prima volta molti anni fa. Libro prima, film dopo, ancora libro. Lettura e visione da cinebrivido, soprattutto nelle ore della cupa.
Ero una quaglia senza pelle. Le emozioni entravano senza bussare. Le gocciole di rugiada della mia fantasia ne inventavano altre. E se leggendo, la biffa di Alex la conoscevo già, vedendo il film mi era sorella. Una sorella crudele, dagli zughi scintillanti…
Ebbene sì, col drugo Alex, Burgess ha inventato uno dei personaggi più cattivi della storia della letteratura. Crudeltà per crudeltà. Nessun migno tictac, nemmeno un piccolo poco. Nel planetario, solo progetti di violenza e sconquassi, che riempiono le gaioffe di denghi e nella cupa si va in giro a locchiare su chi sfogare i propri scapricci distruttivi, su quali tuberose scaricare le berte.
Da ragazza mi colpì il brivido, reale e surreale come il libro, che l’opera di Burgess mi trasmetteva.
Da adulta mi colpisce l’intima paura che suscita. Leggo e quasi ho bisogno di girarmi dietro per vedere se c’è una granfia che mi vuole afferrare, per ficcarmi in gola una lisca col sugo che schizza e cola.

Ecco, cosa straordinaria dell’opera è il linguaggio interamente diverso, perché Burgess ha inventato NADSAT (in russo vuol dire adolescente), uno slang artistico che mette in bocca ai suoi personaggi criminali.
Una lingua inglese, che si avvale dell’ausilio di molte parole mutuate dal russo, oltre a quelle frutto della fantasia dell’autore. Una lingua che nel testo porta ritmo, originalità, atmosfera, usata da Burgess per dare un’’accelerazione cerebrale’. Una lingua che all’inizio della lettura è ostica, ma dopo un po’ ti ci abitui e non ci fai più caso, anzi la vuoi così. Si comprenda dunque perché la versione italiana è un capolavoro anche di Floriana Bossi, prima traduttrice del libro, e di Marco Rossari, traduttore successivo anche lui di notevole bravura. Così, poco diventa piccolopoco, faccia è biffa, sigaretta è cancerosa, sangue è sugo, Dio è Zio, e così via.
Il libro si avvale anche di una lettera di Burgess al ‘Los Angeles Times’. Qui racconta di essere andato a vedere il film e di aver dovuto fare a spintoni per entrare, e afferma che “L’arancia meccanica, anche se frutto del suo albero, è di Stanley Kubrik”, rendendo con queste parole grande omaggio alla maestria del regista, “al suo lavoro tecnicamente puntuale, poetico, capace di schiudere allo spirito nuove prospettive”. Il film vince 4 Oscar, 2 Nastri d’argento, 3 Golden Globes. Chissà però se le parole dell’autore sono sincere. In realtà prima del film, il libro ha venduto solo 4000 copie ed è solo grazie al film che lo conoscerà il mondo intero.
Il titolo nasce dal fatto che molti anni prima in un pub di Londra colpì Burgess quanto detto da un uomo: “Quello lì è sballato come un’arancia meccanica”.
Un ventennio dopo, nel 1962, L’arancia meccanica diviene titolo della sua opera, in un periodo della vita in cui credendo di essere seriamente malato scrive forsennatamente, anche 4-5 romanzi all’anno.
Alla fine degli anni cinquanta la criminalità giovanile è in aumento e questo lo porta a decidere di parlarne, inventando Alex, un personaggio di inaudita crudeltà, che è anche il narratore ‘onnisciente’ del libro. Il libro fa scalpore e ancor più il film. Si teme l’emulazione dei crimini di Alex e la sua banda, ed apre accesi dibattiti. Invece secondo l’autore il senso dell’opera è proprio il contrario, mostrare il male nella sua peggior forma per infondere disgusto. E Kubrick: “Il male, così come il bene, non possono essere inculcati, almeno non nella misura in cui non rispecchino la propria indole”.
Alex ama la buona musica , più di ogni altra quella della nona sinfonia di Beethoven, che costituisce la parte immortale della colonna sonora del film. Com’è possibile, chiedono a Kubrik, che un personaggio così crudele e perverso ami Beetheven? ’Replica: “Anche i nazisti amavano Beethoven.”
Ancora gli chiedono la ragione di aver mostrato una violenza così estrema e criminale, e lui risponde: “Ritrarre così la violenza è stato un atto catartico e caritatevole insieme. Mia moglie è stata violentata e brutalizzata a Londra da tre disertori americani. Il tema della violenza e dello stupro è da me fortemente sentito”.
Ritornando a Burgess, sua intenzione con questo libro, è parlare, oltre che di criminalità giovanile, di inconscio, perché Alex lo rappresenta: “Nel proprio inconscio, ciascuno di noi uccide e violenta.”
Affronta poi il tema del lavaggio del cervello, perché quando Alex, tradito dai suoi amici, viene imprigionato e sembra, dico sembra cambiare (in realtà sta solo fingendo), commette ancora un omicidio. Lo Stato (interpretato da varie figure gerarchicamente importanti), ritenendo a questo punto che il sistema carcerario non serva ad annullare il male e nemmeno a contenerlo, mette in pratica sulla cavia Alex il Sistema Ludovico, che in qualche modo ricorda quanto di catartico può sortire la tragedia greca sullo spettatore. Detto anche Trattamento della Redenzione, si tratta di una tecnica sperimentale di rieducazione del soggetto, che avviene però costringendolo a vedere, nel ‘filmodromo dell’inferno’, per intere giornate, filmati che mostrano scene violente. Il nostro antieroe viene legato su una sedia e i suoi occhi vengono tenuti aperti da pinze. Non può in nessun modo sfuggire a questa tortura, che dura interminabili quindici giorni e che gli provoca nausea, vertigini, desiderio di morire.
Qui si inserisce un altro tema importante, quello etico (ai sostenitori del metodo, fa da contraltare il sacerdote della prigione coi suoi ragionamenti), e comunque anche il sistema Ludovico è fallace, in quanto porterà Alex ad essere libero e non commetterà crimini, ma ancora una volta fingerà una bontà che non c’è. Stavolta però ne ha consapevolezza e da questa consapevolezza inizia in lui un processo di maturazione preludio di un vero cambiamento. Detta così, la trama del libro (e del film, che non è in tutto e per tutto uguale), sono banalizzate. In realtà si tratta di un libro stupefacente e pieno di ritmo, e al contempo complesso, capace di turbare fortemente chi legge, o vede. E comunque anche chi solo legge, vede.