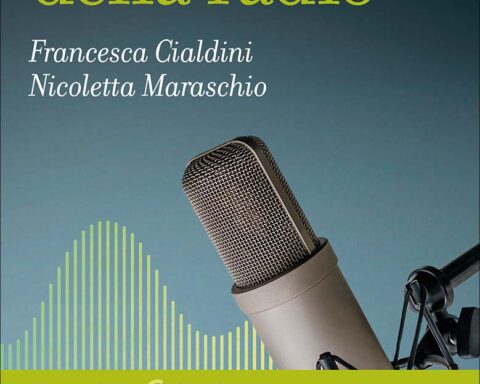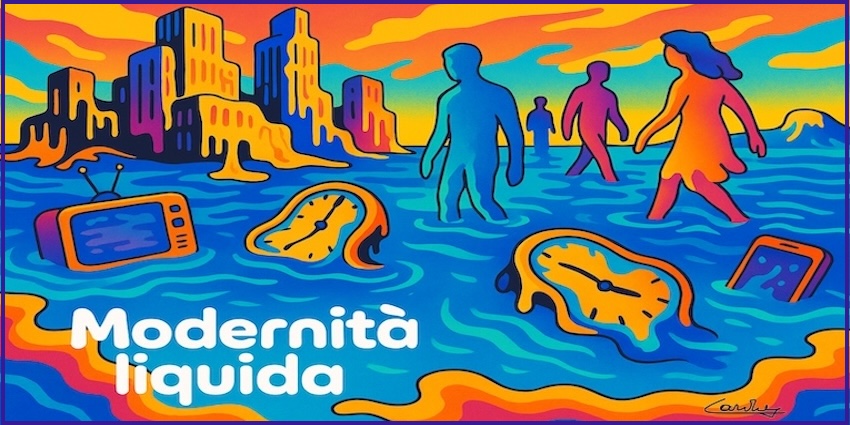È da tempo che la politica ha smesso di essere progetto ed è diventata mercato. Non di idee, ma di emozioni, di quelle peggiori: paura, rancore, diffidenza, rabbia. È questo il cuore del marketing dell’odio, la strategia che permette ai partiti di acquisire consensi facendo di ogni conflitto un brand.
L’assassinio di Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre 2025 durante un evento all’Università dello Utah, è stato la dimostrazione plastica di come il ciclo dell’odio non si interrompa neppure davanti alla morte. Kirk, fondatore di Turning Point USA, voce di punta del trumpismo e idolo delle destre americane più aggressive, era un professionista della disputa e del conflitto politico. La sua deprecabile uccisione è stata immediatamente assorbita da quel meccanismo che lui stesso aveva contribuito a costruire: ideologia estrema, accuse, sospetti, razzismo soft, polarizzazione e mutamento delle tragedie in carburante politico.
I trumpiani non hanno perso tempo ad accusare i Liberal -chi altri?- rei di diffondere odio (sic!), mentre in Italia, la notizia è rimbalzata come un sasso in uno stagno già fangoso di suo: Giorgia Meloni ha accusato l’opposizione di godere della morte di Kirk, e l’opposizione ha ribattuto rinfacciando le sue tenui parole sui 70.000 morti e i 230.000 feriti a Gaza e il sostegno zelante a Netanyahu. Morale: ognuno ha trovato un modo per fare della tragedia altrui un’arma di indignazione propria.
L’odio come merce: breve manuale d’uso
Il marketing dell’odio non è improvvisazione, ma tecnica consolidata in cinque mosse:
- Polarizzazione: dividere la società in due blocchi inconciliabili. “Noi” contro “loro”. I migranti, l’élite, i comunisti, i fascisti: l’importante è che ci sia un nemico, altrimenti lo si inventa.
- Spettacolarizzazione: trasformare divergenze reali in battaglie esistenziali. Nessuna discussione su tasse o sanità: meglio gridare alla guerra culturale (così non ci sono dati da mostrare).
- Amplificazione social: odio in formato meme, clip virali, tweet che infiammano. L’algoritmo, si sa, preferisce l’urlo al sussurro, l’abbaiare al mormorio.
- Vittimismo strategico: chi è accusato di fomentare l’odio risponde: “Vedete? Mi attaccano perché dico la verità”. Ogni critica diventa certificato di autenticità.
- Dolore come spot: tragedie e morti non servono a riflettere, ma a posizionarsi nel mercato politico. Il dolore altrui diventa investimento di capitale politico.
Risultato: un mercato redditizio dove le emozioni servono più di una proposta politica.
Trump, Kirk & C.: la scuola americana del rancore
Se questo modello ha un maestro, quello è Donald Trump. Fin dagli anni ’80 ha capito che la provocazione vende. La sua carriera politica è stata costruita su nemici immaginari e reali: i messicani “stupratori”, i media “corrotti”, i giudici “politicizzati”. Ogni insulto subìto è trasformato in prova del complotto: l’odio diventa collante identitario.
Charlie Kirk, giovane smart e socialmente più agile, è stato uno dei suoi migliori allievi. Ha fondato Turning Point USA trasformandola in una macchina di propaganda pensata per i campus americani, con linguaggio aggressivo, clip virali, merchandising patriottico. Kirk non ha mai esitato a usare il conflitto come leva di consenso. L’ironia tragica è che proprio lui -dichiaratosi disposto ad accettare una statistica che prevedeva “qualche” morto (nel 2024 ci sono stati ~2.300 decessi per armi da fuoco tra minori di 18 anni!) pur di avere la libertà di possedere armi- sia finito vittima della sua statistica.
L’Italia e la fiera dell’ipocrisia
Nel nostro Paese il copione è stato recitato con zelo.
- Destra: “L’opposizione festeggia un assassinio, e poi parlano di odio!”.
- Sinistra: “Voi piangete Kirk e sostenete Netanyahu; ma Gaza è un cimitero a cielo aperto”.
- Media: pronti a trasformare ogni dichiarazione in click, titoli urlati, servizi urlati più dei titoli.
La tragedia è diventata terreno di scontro simbolico. Nessuno si è fermato a chiedersi se il linguaggio dell’odio possa avvelenare la democrazia; perché?… ma è MARKETING! Ripugnante quanto volete ma è marketing! La regola di mercato è: Se l’odio è merce che si vende bene, perché rinunciarci?
Breve genealogia dell’odio politico
Il linguaggio dell’odio non nasce con i social. Ha radici antiche. I pamphlet rivoluzionari del Settecento, i giornali faziosi dell’Ottocento, i manifesti totalitari del Novecento: tutti hanno usato categorie nette, slogan, nemici. La differenza, oggi, è la velocità e la pervasività. Twitter, TikTok e Facebook hanno trasformato la retorica dell’odio in catena di montaggio: ogni insulto diventa virale, ogni bugia si moltiplica in tempo reale.
Non è solo questione di parole dure. Il linguaggio dell’odio si basa su tecniche precise:
- Deumanizzazione: l’avversario di turno non è più un interlocutore, ma un invasore, un traditore, un parassitaspecie se immigrato e clandestino.
- Semplificazione estrema: “prima gli italiani”, problemi complessi ridotti a slogan, belli, sintetici, riempiono la panza e non li impegnano a risolvere nulla.
- Apocalittica costante: ogni scelta è “l’ultima battaglia”, ogni elezione “il destino della civiltà”.
- Umorismo tossico: meme, parodie che normalizzano l’odio sotto la maschera della leggerezza.
Perché funziona l’odio?
Funziona perché tocca corde profonde. La psicologia sociale ci ricorda che gli esseri umani amano sentirsi parte di un gruppo e odiano sentirsi minacciati. L’odio semplifica, dà un senso di comunità, produce adrenalina. Inoltre, in un mondo saturo di informazioni, il messaggio aggressivo è quello che buca lo schermo.
Il linguaggio dell’odio diventa quindi un prodotto perfetto per il mercato politico odierno: costa poco, si diffonde velocemente, fidelizza gli elettori. È, in altre parole, una start-up del rancore con margini di profitto altissimi visto il costume di mettere il cervello a riposo e di non chiedersi perché.
Le conseguenze: oltre il like, la violenza
Il problema è che il marketing dell’odio non resta confinato online. Gli Stati Uniti sono pieni di episodi in cui la retorica politica ha alimentato violenza fisica: dall’assalto a Capitol Hill nel 2021 fino a gesti individuali come l’omicidio di Kirk.
In Italia, i toni accesi alimentano aggressioni verbali, divisioni familiari, persino violenze di piazza. La società si frantuma in microtribù convinte che l’altro sia non solo un avversario, ma un nemico da abbattere. E quando la politica perde la capacità di mediazione, resta solo il conflitto permanente.
Ci sono soluzioni?
Non ci sono soluzioni facili. Alla base c’è un cambiamento culturale ed il marketing dell’odio è troppo redditizio per sparire. Ma non tutte le polemiche sono odio o veleno, possiamo riconoscerli. Il problema si pone quando l’odio diventa strategia deliberata, cosa che sta avvenendo ora.
Se l’odio è merce, allora noi siamo i consumatori, perché il marketing dell’odio funziona solo se trova mercato. Sta a noi decidere se comprare o restituire al mittente… E, per quanto redditizio, è un prodotto che avvelena chi lo compra, ma alla lunga anche chi lo vende.
Di certo se si va avanti così rischiamo di diventare tutti iscritti ignari al partito del rancore… e se non cambia d’emblée qualcosa nei prossimi mesi, l’odio troverà il suo naturale esito. Purtroppo.
Fonti
- Wikipedia – Killing of Charlie Kirk
- Reuters – Charlie Kirk’s allies warn Americans to mourn him properly or else
- ANSA – Meloni: noi accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Kirk
- Corriere della Sera – L’assassinio di Charlie Kirk e l’odio social
- Martha C. Nussbaum, The Monarchy of Fear: A Philosopher Looks at Our Political Crisis, Simon & Schuster, 2018.
- George Lakoff, Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate, Chelsea Green, 2004.
https://www.thetrace.org/2025/07/gun-deaths-suicide-