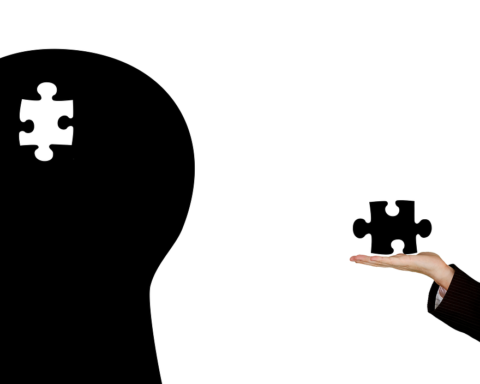Caro direttore,
ho avuto occasione di leggere e ascoltare i riflessi dell’iniziativa realizzata dalla collaborazione tra Fondazione Banco di Napoli e RQ, focalizzata sul controverso tema della salute mentale nell’ambito del progetto “Non è mai troppo tardi”.
Ricordo che in un’altra epoca, un altro Manzi, Alberto, conducesse un programma televisivo dal titolo omonimo il cui fine era una sorta di tentativo di “alfabetizzazione collettiva” come volano sociale per completare quel processo di rinascita postbellica verso cui l’Italia stava proiettandosi. Tenendo aggiornata la memoria, ne traggo spunto sia per via di analogie che di metafore per l’odierna fase storico-politica e più in generale della sua cifra culturale: là si trattava di formare, qui, oggi, nonostante il riformismo socialdemocratico (condensato per esempio nella “legge 180” ), si tratta di “ripartire da zero”. O quasi.
La retorica ha esaurito la spinta propulsiva
che ha costituito il movimento basagliano
Questo “quasi zero” è l’indice di un processo storico che, quanto al cosiddetto “movimento basagliano”, ne connota la deriva sostanzialmente apologetica e meramente rivendicativa come esito di un pensiero sommario che, organizzato sulla sola custodia del “corpo sacro” di Basaglia, ne ha realizzato, per via di mummificazione, quella monumentalizzazione retorica cui è venuta meno la spinta propulsiva che ne avevano segnato l’esordio e gli esiti. L’assimilazione meramente lessicale del suo pensiero si alimenta del solo senso della militanza, ormai più che residuale, che, alla luce della reale sostanza problematica della questione psichiatrica, dà espressione a una complessiva impotenza di cui è sintomo la dismissione di un autentico pensiero critico che ne sappia riprendere le implicazioni del suo pensiero così come della sua opera.
Non mi pare essere questa l’occupazione e l’orientamento degli esponenti che si richiamano a Basaglia: è sufficiente un rapido passaggio anche presso quei “Dsm” a conduzione basagliana per constatarne l’assenza. Certamente il clima politico degli ultimi anni ha costituito un terreno di coltura ideale per combinare al tempo stesso la generale dismissione del SSN e la specifica “vis” anti-legge 180.
Registriamo un’adesione superficiale
che diventa aziendalismo prestazionale
Nello specifico va ribadito però che tale vis fa molto comodo a quegli operatori della salute mentale e a quei servizi che NON hanno MAI preso sul serio il pensiero di Basaglia, limitandosi a una adesione superficiale presto confluita in quell’aziendalismo prestazionale a conduzione manageriale che, anche in Campania e nella stessa Salerno, conta sempre più affiliati tra i suoi adepti. È frequente ascoltare costoro (e ne ho avuto la riprova nel corso del recente convegno del dicembre scorso presso il Dipartimento di Filosofia del Campus di Fisciano che non a caso titolai “Il non-luogo della psichiatria e il non-ancora della salute mentale”) per coglierne il loro sillabare fatto di rimasticature e di luoghi comuni che ne indicano l’aspetto fittizio e strumentale: poiché, di fatto, è della loro ipocrisia etica, morale e intellettuale che si tratta.
Come “questione politica e culturale” innanzitutto. Come è possibile che dai livelli apicali fino all’ultimo operatore discenda ancora la cultura dell’istituzione e spesso della contenzione (benché chimicamente rimodulata…!) , che i servizi territoriali riproducano logiche asfittiche e meramente ambulatoriali, che si accetti l’omissione e la reticenza sulle case farmaceutiche che occultano i dati sfavorevoli circa i farmaci che vendono. Che vendono e sono acquistati da TUTTI gli operatori…
Come è possibile che da tali vertici coli una tale massa di ignoranza e di pregiudizi che ne fa la sua miseria fino a permearne istituzioni e servizi?
Ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere Beppe Dell’Acqua un po’ di anni fa: la sintonia fu immediata e, mediata dalla sua passione e dalla sua esperienza, ci portò a organizzare nel 2019 un convegno a Milano che decidemmo di titolare “Legge 180: l’eterna incompiuta”; fummo ospitati nella splendida cornice della sala Alessi di Palazzo Marino (sede del comune di Milano) e potemmo contare anche sulla presenza della professoressa Giannichedda, come sempre impreziosita dal suo treccione che ne indicava in un qualche modo una certa solidità identitaria e di appartenenza. Forse d’altri tempi, ma sicura e affidabile.
Fu nel corso dell’intervento dell’allora assessore alle politiche sanitarie di regione Lombardia, Gallera (passato alla storia delle disgrazie causate dal Covid-19 in virtù dei suoi strafalcioni a commento di quell’evento…) che udii Beppe sibilare in un “….ma è un discorso autistico….!!”. Ebbene quella connotazione , che voleva sottolineare un tipico distacco di cui facevano parte le astrattezze retoriche e di circostanza dell’assessore Gallera, suonano un po’ beffarde se ricondotte al clima odierno per quanto riguarda lo stato delle cose. Sul piano della riflessione e delle pratiche intendo.
Il discorso di Basaglia è sulla psichiatria
e non sui manicomi, come dicono alcuni
Mi capita sovente insomma di ascoltare le ingenue “metafisiche” che molti, anche troppi, addetti ai lavori e colleghi, sciorinano come un’ovvietà indiscutibile, in buona compagnia anche di giovani leve che, causa un accademismo tanto colonizzato da un provincialismo scientifico quanto monolitico nella sua subalternità culturale, purtroppo non fanno eccezione: la reiterazione nostalgica delle acquisizioni post 180, le odierne confische delle stesse a opera di un clima politico avverso, la riproposizione di stucchevoli e immaginifici virtuosismi legati all’ambiguo e opaco concetto di “salute mentale” che, nella sua connotazione ossimorica, funziona come riferimento palingenetico rispetto a diritti decurtati e bisogni insoddisfatti.
Formula passepartout, analoga al ricorso al “biopsicosociale” come sintesi compromissoria: entrambe onnicomprensive, dicono tutto di tutto senza dire più niente, perché svuotate di senso da un utilizzo meramente retorico. Soprattutto mancanti di prospettiva, se non quella deducibile dall’esperienza triestina sempre più simile a un’enclave i cui confini geopolitici e teorici vengono certamente erosi sul piano economico e delle risorse umane, tuttavia quando osserviamo il progressivo impoverimento dei servizi sul territorio non dovremmo tanto ipotizzare “un intelligent design reazionario” quanto chiederci quale integrazione di pensiero sia sopraggiunta alle parole e ai contenuti di Basaglia che non siano quelle cui ci si riferisce più facilmente, ovvero quelle legate al superamento dello scandalo manicomiale, piuttosto che quelle legate alla critica dei costrutti epistemici della psichiatria come istituzione: è proprio il monologo della ragione sulla follia l’oggetto principale della ricerca di Basaglia, essendo il superamento del manicomio nient’altro che la negazione della legittimità di tale monologo.
Chissà se “l’odierno savoir faire psichiatrico territoriale”, gestito con logiche manageriali da soggetti che sembrano profilati più su prassi da London Economics School che da consapevolezze etico-politiche orientate alla cura, chissà se questo assetto territoriale sottoscriva la negazione della legittimità di cui sopra.
La “Gestalt” del binomio “pensiero/pratica” di Basaglia è troppo spesso dimenticata per permettere e autorizzarsi a un uso di parole isolate dal suo “testo/ pratica”, e quindi impoverite e pervertite al solo uso retorico e lessicale. È di facile riscontro in questi casi che tali giaculatorie vengono impiegate per definire l’atto di rivoltare le frittate, atto questo notoriamente molto più accetto e accettabile in ambienti conservatori. Ne ho incontrato molti, anche al recente convegno del dicembre scorso, dove furono convocati psichiatri (alcuni attivi localmente e gestori di Dsm di notevole estensione…), filosofi, antropologi e sociologi con l’intento di “riaprire” una discussione pubblica che fosse anche una denuncia della deriva involutiva della psichiatria. A costoro furono sottoposte le seguenti tracce tematiche:
– la psichiatria alternativa italiana e le sue radici culturali e scientifiche;
– il concetto di salute mentale e le sue ambiguità;
– tra colonizzazione e ricerca di nuovi paradigmi: lo stato dei saperi “psy”;
– quale formazione per l’operatore della salute mentale.
A causa del fenomeno di decontestualizzazione di cui prima, ormai sistematico in gran parte del campo psichiatrico, si è potuto assistere al singolare fenomeno per cui la “riflessione basagliana” sulla psichiatria e sulla natura della clinica psichiatrica scompare per lasciare posto a un pensiero sommario, stereotipato e presuntivamente basagliano fatto di un misto di indignazione filantropica e di flebile spirio riorganizzativo condotti con un insopportabile paternalismo gentile e accondiscendente.
Rischiamo un oscurantismo conoscitivo
con ricadute sociali molto forti
Nessuna o scarsa consapevolezza, per esempio, dell’enorme impatto culturale e politico del trasmettere il “come si fa” delle pratiche antistituzionali, spesso solo narrate che documentate e rese trasmissibili. Si cercavano insomma (…e si continuerà a cercare…) degli interlocutori con ancora sufficiente resistenza, lucidità e consapevolezza da non lasciarsi risucchiare dai tanti specchietti per le allodole disseminati su quella palude oltremodo ristagnante che è l’odierno status della psichiatria italiana e non solo. Perché il rischio di un reale oscurantismo conoscitivo con le sue ricadute sociali in termini di livelli e qualità assistenziali che permea l’attuale composizione discorsiva è quello di un tragico esito paradossale: quello di una psichiatria che alleggerita la clinica dalla “soggettività” per realizzare “soggetti ologrammi- DSM profilati” finisca nella metafisica poco concreta della evanescente “salute mentale” in totale assenza di strategie.
Il solo richiamo, nostalgicamente condotto da Beppe Dell’Acqua, è insufficiente per quanto sapienziale e ricco di pathos. Il pathos di una vita e di una pratica che ci giunge dalla voce di Beppe con tutto l’impatto e la rilevanza storica, etica e politica dell’epica basagliana. Esperienza e testimonianza incarnata la sua, memoria preziosa cui oggi non corrispondono ricordi congrui e prospettici da cui aspettarsi un nuovo dinamismo che, invece, è possibile solo con una riattivazione di un pensiero critico che individui e riconosca le proprie resistenze interne, quelle che Luciano Carrino in un lavoro di oltre trent’anni fa (“La dimensione affettiva del lavoro critico”) chiamava “le componenti parassite dell’identità professionale”, cioè quelle componenti che rendono “istituzione” ogni tecnica e ogni sapere che, in tal modo, perde ogni capacità di interrogarsi fino a costituirsi come schermo all’interrogazione. Schermo che riappare, oltre a quello opaco della salute mentale, nel concetto di empowerement per alludere alla finalità principale cui condurrebbe la “nuova via descritta dalla recovery“: l’acquisizione di potere da parte di individui e di gruppi. Non sembra esserci un’adeguata percezione delle implicazioni di un tale termine, spesso inflazionato e acriticamente recepito. Anche da questo caso si evince il grado di opacità e dunque di resistenza del pensiero fino al dover constatare che …c’è chi si stanca, chi tradisce, chi continua svogliato, chi continua più settario di prima, chi perde il cervello, chi vende il cervello…. A nessuno di tali “stati di coscienza” sembra appartenere la semplice constatazione che un processo di empowerment è tale soltanto se da esso risulta una diminuzione sensibile del differenziale di potere fra chi il potere ce l’ha e non ce l’ha: l’implicazione rimossa è che si tratta di una “democratizzazione” (!!) delle risorse, dei saperi e delle opportunità che avviene attraverso processi di transazione morale e politica culturalmente e socialmente specifici, la cui generalizzabilità è forse possibile ma è ancora tutta da dimostrare. Questioni di fatto neglette dalla cui rimozione ne discende una regolazione operativa relegata alla dimensione infantile, dunque pensiero senza parola.
Il pensiero manageriale pensa di poter gestire
la complessità con ricette di gestione aziendale
L’assenza drammatica di riferimenti valoriali e teoretici generano il puerile e irresponsabile “pensiero manageriale” che pretende di gestire la complessità della più clinica delle discipline la cui struttura è perlomeno multidisciplinare, con ricette di gestione aziendale, tale essendo l’odierno e ordinario habitus psicoattitudinale dei gestori dei cosiddetti mental disorders. Indicativa di questa situazione fu un dibattito svoltosi nel 2002/2003 tra un gruppo di epidemiologi e statistici della sanità guidati dall’americano Christopher Murray e alcuni rappresentanti di governo che si lamentavano del fatto che “le misure epidemiologiche create da Murray avessero condotto l’O.M.S. a descrivere la realtà sanitaria dei paesi e la diffusione delle malattie, in forma distorta rispetto alla realtà”. Murray rispose in questi termini: “I modelli matematici che utilizziamo sono più vicini alla realtà della realtà stessa che, di fatto, diventerà sempre più un fattore di confondimento”.
Il divorzio tra sapere e trasformare
appare oramai ineluttabile
Al di là dell’aspetto provocatorio per affermare la sofisticazione dei modelli matematici impiegati, tale provocazione la dice lunga su come saper descrivere la realtà possa illudere di potere fare a meno della realtà stessa. Aumentare la quantità e la qualità della “denominazione della realtà” non necessariamente ne aumenta la comprensione e i mezzi per la sua trasformazione. Un esito a cascata di questi processi di impoverimento teoretico è quello del divorzio fra processi intellettuali conoscitivi e processi etici trasformativi: la debolezza di pensiero teorico (sostituito spesso da funzioni descrittive) determina la perdita di ogni possibile utopia della trasformazione dell’esistente. Si assiste pertanto a una tragica caduta della tensione al cambiamento e dunque alla perdita della dimensione etica come elemento costitutivo dei processi di conoscenza. La constatazione coincide con una verità storica difficile da digerire: un enorme patrimonio di conoscenze non ha generato trasformazioni delle politiche dei paesi, quasi che il divorzio fra sapere e trasformare sia ineluttabile e che le trasformazioni avvengono attraverso cammini diversi da quelli generati dalla conoscenza e che le conoscenze non abbiano la forza di generare cammini di trasformazione. Salvo l’ulteriore constatazione che siano quelli di derivazione ideologica a produrre e riprodurre l’esistente: vedi il caso della metamorfosi del S.S.N. in “aziendalismo prestazionale a trazione privatistica”.
In definitiva e come parziale conclusione: si tratta di “riaprire” il contenzioso che concerne il “dispositivo psichiatrico” che, strutturatosi come “specificità della medicina mentale”, costituisce un campo di forze attorno al quale si può dire che si è raccolto l’essenziale, ovvero:
– l’asse del potere
– l’asse della verità
– l’asse della soggettivazione
Tre aree problematiche che condensano tutta la complessità della disciplina psichiatrica e, soprattutto, richiamano ciò che ho evocato all’inizio: la reale sostanza problematica della questione il cui nucleo centrale è se essa esiste come branca della medicina, o invece, nel momento in cui assume come oggetto della sua osservazione e del suo intervento aspetti sempre più lontani dalla medicina, essa cessi di esistere come specialità medica e incominci a esistere come qualcosa d’altro, di indefinito e necessariamente da definire. È solo in tal modo che , forse, si potrà dischiudere un’autentico senso a quella nebulosa concettuale che oggi, invece, costituisce il riferimento alla “salute mentale”.
“Psichiatria”, ovvero “salute mentale”, sarà quindi ciò che risulterà da un lavoro critico su quella che ancora oggi costituisce una massa opaca e ambigua di fatti cui manca un’adeguata opera di differenziazione e di risignificazione.
“Psichiatria”, ovvero “salute mentale” sarà anche l’imminente pubblicazione degli atti del convegno del dicembre scorso e la pubblicazione di un libro che ne raccoglierà l’elaborazione, coerentemente con l’esortazione spinoziana secondo cui “l’ignoranza non è un argomento”.