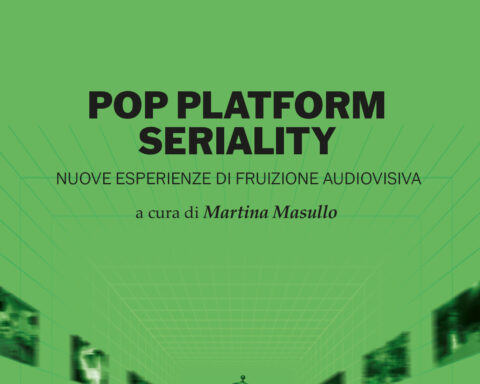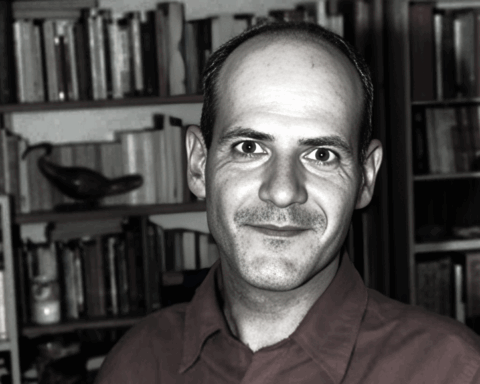Cosa ci dicono, oggi, i cantautori nel tempo del dominio dell’autotune e dei dissing? Come si muovono i portavoce della musica e della canzone d’autore – quella frutto della centrale “tradizione italica”- nel tempo della digital society? Ci dicono tantissimo. E si muovono con passo intelligente e sensibile in spazi e luoghi dove il dominio è, invece, completamente nel segno dell’ascolto collettivo, della voglia di stare assieme, della passione di guardare al nuovo e dal desiderio di ritrovare “piccoli mondi antichi e moderni”. E senza dimenticare una presenza intelligente nell’universo dei social. E tutto questo lo abbiamo ritrovato nel concerto di Andrea Tarquini “Da Stefano Rosso in poi” sabato scorso nella sezione “Suoni” nell’ambito della IX edizione dei Racconti del Contemporaneo che accompagna la mostra di Philippe Halsman “Lampi di genio” nel salernitano Palazzo Fruscione.
Dopo i saluti d’apertura del Presidente di Tempi Moderni, Marco Russo, e introdotti da Carlo Pecoraro (sempre capace d’unire la passione dell’ascoltatore al rigore filologico del critico musicale) entra in scena con chitarre e voci Andrea Tarquini. E ci porta tutti nel solco delle sue canzoni. Donandoci una densa ghirlanda di racconti in musica che attraversa tutto il suo impegno di cantautore.
Una storia questa di Tarquini che lo vede poco più che ventenne già protagonista di importanti luoghi “sacri” della musica (su tutti il Folkstudio, straordinaria palestra del miglior cantautorato made in Italy) e poi l’incontro con Stefano Rosso (in un continuo miscelare amicizia e fatica, quotidianità e ricerca) cui dedicherà un raffinato e malinconico omaggio antologico “Reds” (2013).
Il lavoro di Tarquini è un continuo attraversare la musica: larghi echi della sonorità italiana, omaggi al grande sound americano e poi swing manouche, flatpicking, fingerpicking, tantissime storie di vita vissuta o ascoltata il tutto senza dimenticare passioni politiche (la sensibilità socialista come motore e visione) e quella febbre di verità che è forse la concreta testimonianza che un cantautore oggi possa (debba) mettere in campo.
La ricerca di Tarquini continua e si solidifica in due lavori totalmente personali che seppure cromaticamente pieni di una soave intimità sono magnificamente aperti al mondo (penso a “Fiore rosso”) oppure sono storia di vita quotidiana (“Il destino è un pianoforte”) nel suo “Disco rotto” (2018). Ma è con “In fondo al ‘900” magistrale viaggio nella memoria (individuale e collettiva) dove gli echi del secolo breve tornano impetuosi e necessari come un racconto capace di sintetizzare il nostro vissuto (su tutte è sicuramente “Ufo Robot” che è un potente mash-up tra tensioni politico-eversive fine anni Settanta e la nascente “Goldrake Generation”) oppure la ferita profonda di un amico che non c’è più (“Uve al sole”).
In mezzo a queste produzioni la vita. Tanta vita e poi dialoghi con i principali musicisti italiani, viaggi, concerti, una precisa attenzione strategica alle piattaforme digitali e ancora i numerosi premi vinti (in particolare nel luglio del 2022 la targa “Un Autore per la Musica Italiana – Premio Città di Quiliano 2022”). È fondamentale sottolineare che in tutte le sue canzoni– e i momenti live ne sono precisa testimonianza- l’attenzione verso i testi e le storie (un continuo circumnavigare la vita quotidiana, gli affanni amorosi, le emozioni, la critica sociale, la riflessione esistenziale) non sopravanza l’attenzione verso il nucleo musicale. Infatti, la musica non è mai secondaria nel percorso del nostro cantautore romano. Anzi c’è un rigore costante e continuo verso la musica. E così, proprio in questa riuscita tensione tra racconto e musica ci piace leggere la forza e l’originalità del lavoro di Andrea Tarquini e il suo intenso e sorridente attraversare il mondo della musica.
Certo a questo aggiungi la bellezza del “terzo tempo” dove il post-concerto all’insegna di chiacchiere amicali, voglia di nuovi progetti, vino bianco, polpette al sugo, un piatto di milza… e il mondo davvero ti sembra meno “disonesto” e addirittura più bello. Ma questa, signori e signore, è tutta un’altra storia.