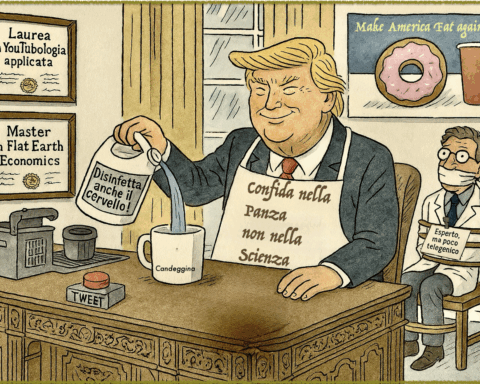L’Europa si trova oggi ad affrontare una crisi di identità e di efficacia politica che sembra riflettersi in ogni aspetto del processo decisionale e della governance. In questo momento storico l’UE è percepita come un’enorme macchina burocratica, impegnata a definire minuziosamente persino le caratteristiche più futili come “quanto devono essere curvi i cetrioli” o “quanto lunghe le banane”, mentre fatica a delineare una politica estera unitaria.
La struttura dell’Unione Europea risponde a decenni di integrazione progressiva di popoli abbastanza diversi tra loro, che ha portato alla creazione di un sistema di Nazioni e Agenzie che hanno dovuto collaborare per definire un percorso comune. Tuttavia, questo encomiabile afflato di viaggio unitario ha avuto un rovescio della medaglia: le lunghe procedure per raggiungere una Concordia Generale post II guerra Mondiale, sono confluite in una pretesa unanimità che qualsiasi pessimo docente di Scienza della politica ci dirà che è un istituto antidemocratico in quanto è l’autostrada al potere di veto, alla burocrazia da bilancino del farmacista dove teorizzando di andare tutti d’accordo, insieme appassionatamente, si rallentano processi e interventi tempestivi ed efficaci alle sfide contemporanee: in pratica è un’ipocrita concordia collettiva che si tramuta, in concreto, in un pantano di fango.
L’Europa, in questo momento storico si trova a dover gestire una politica interna frammentata, in cui gli interessi nazionali prevalgono sull’obiettivo comune di un’Europa proiettata verso il futuro. La frammentazione politica è evidente nei meccanismi decisionali: questa divisione si manifesta anche nella difficoltà di individuare una leadership condivisa in un contesto in cui ogni Stato membro porta con sé tradizioni differenti, visioni del mondo e priorità diverse, il tentativo di forgiare un’agenda politica comune si scontra sempre con interessi locali e nazionali. Il risultato è una politica interna che, se da un lato avvalora una presunta partecipazione democratica, dall’altro fatica a dare un messaggio unitario e deciso a livello internazionale.
Tra gli esempi più eclatanti dei disastri provocati dall’unanimità è il caso del primo ministro ungherese Viktor Orbán: l’Ungheria ha adottato una linea nazionalista e sovranista – lontana dai principi democratici occidentali – ed utilizza l’unanimità della UE per bloccare decisioni che ritiene non conformi agli interessi del suo Paese. Questa tattica avvera il rischio che interessi nazionali ristretti possano compromettere la capacità dell’UE di affrontare con decisione e velocità le crisi internazionali che richiedono una risposta forte ed unitaria. La mancanza di una visione strategica condivisa non solo limita il peso politico dell’Europa, ma alimenta anche il dibattito interno su quale dovrebbe essere il suo ruolo. In tale contesto, la necessità di riformare i meccanismi decisionali diventa sempre più pressante, affinché si possa garantire una maggiore efficienza e coerenza nell’agire esterno.
Il percorso verso un’Europa federale è costellato di resistenze di vario genere. Da una parte, vi è la necessità di preservare le peculiarità nazionali, elementi fondamentali per il patrimonio culturale di ogni Paese, dall’altra vi è l’urgenza di superare queste differenze per costruire una politica comune che permetta di rispondere efficacemente alle sfide globali. Il compromesso tra sovranità nazionale e interesse collettivo richiede un ripensamento profondo dei meccanismi istituzionali e della filosofia politica alla base dell’Unione Europea.
La revisione dei processi decisionali, la semplificazione della burocrazia e l’introduzione di strumenti più flessibili per il coordinamento politico sono passi indispensabili per trasformare l’Europa da una macchina burocratica in un’organizzazione politica dinamica e reattiva.
Verso una riforma dell’Unione Europea: prospettive e soluzioni
È chiaro che il modello da seguire va verso una leadership politica capace di guardare al futuro e di mettere in atto riforme strutturali che pur mediando tra gli interessi nazionali, deve anche ispirare un senso di appartenenza e di identità comune per consolidare un progetto europeo unificato.
La nuova leadership deve avere la capacità di cogliere le sfide contemporanee – dalla crisi economica alle tensioni geopolitiche, fino ai problemi legati alla migrazione e alla sicurezza – e un approccio integrato e una volontà politica forte, in grado di superare le divisioni interne e di dare voce a un progetto condiviso di progresso e benessere comune.
Nel contesto attuale, numerosi sono gli interventi di intellettuali, politici e studiosi che auspicano una profonda riforma delle istituzioni europee. Tra le proposte più discusse vi è la necessità di snellire i meccanismi decisionali, eliminando quei passaggi burocratici che rallentano molto la capacità di intervento dell’UE. Un’altra proposta riguarda il rafforzamento delle competenze dell’Unione in materia di politica estera, al fine di renderla un attore globale più incisivo e capace di contrapporsi efficacemente alle crisi internazionali.
Insomma per riorganizzare operativamente l’UE occorre semplificare la burocrazia e i meccanismi decisionali, abbandonando in molti settori il requisito dell’unanimità in favore di maggioranze qualificate che permettano risposte rapide ed efficaci. Ciò significa ridurre i passaggi burocratici, centralizzare le competenze chiave (soprattutto in politica estera e sicurezza) e potenziare il ruolo della Commissione Europea come organo esecutivo e di coordinamento.
 Numerosi intellettuali e leader politici hanno proposto riforme in questa direzione. Romano Prodi, ad esempio, ha sostenuto a lungo l’idea di un’Europa più efficiente e meno frammentata, puntando a un rafforzamento delle istituzioni comuni per superare la lentezza decisionale. Emmanuel Macron, dal canto suo, ha avanzato l’ipotesi di una maggiore integrazione politica e di strumenti decisionali più snelli, capaci di far fronte alle crisi in modo tempestivo. Anche Guy Verhofstadt ha evidenziato l’urgenza di un’Europa operativa e agile, capace di trasformarsi da macchina burocratica in un organismo proattivo e unito.
Numerosi intellettuali e leader politici hanno proposto riforme in questa direzione. Romano Prodi, ad esempio, ha sostenuto a lungo l’idea di un’Europa più efficiente e meno frammentata, puntando a un rafforzamento delle istituzioni comuni per superare la lentezza decisionale. Emmanuel Macron, dal canto suo, ha avanzato l’ipotesi di una maggiore integrazione politica e di strumenti decisionali più snelli, capaci di far fronte alle crisi in modo tempestivo. Anche Guy Verhofstadt ha evidenziato l’urgenza di un’Europa operativa e agile, capace di trasformarsi da macchina burocratica in un organismo proattivo e unito.
In sintesi, la strada per una riorganizzazione efficace dell’UE passa per la modernizzazione delle sue strutture istituzionali e per un rafforzamento della leadership politica, elementi considerati indispensabili per far fronte alle sfide globali in maniera coordinata e tempestiva.
Per raggiungere tale obiettivo, è necessario un profondo ripensamento dei meccanismi istituzionali, prima fra tutti l’abolizione dell’unanimità; solo attraverso un percorso di riforma strutturale e di rinnovamento politico l’Europa potrà riconquistare la sua capacità di essere protagonista nel panorama internazionale, superando l’immagine di “grande burocrate e nana politica” e riaffermando i valori di unità, solidarietà e progresso che ne hanno sempre caratterizzato il progetto.
Ormai son passati 75 anni dal trattato di Parigi che fondò la CECA e più di 30 anni dal trattato di Maastricht che istituì la UE… quello che c’era da regolare è stato fatto, l’Euro è la nostra moneta unica ed è forte (forse più) come il dollaro. L’Europa deve venir fuori dall’idea di voler dare direttive su tutto, ogni stato Nazionale ha tradizioni storiche, alimentari e comportamentali proprie… ma ciò che invece sarà duro combattere è che in un’UE che si occupi solo di argomenti fondamentali per tutti gli Stati quali politica estera, sicurezza, innovazione tecnologica, migrazione, cambiamento climatico ed energia, non ci sarà spazio per quella miriade di uffici e di funzionari occupati finora a dirci come etichettare i prodotti, quali i loro requisiti estetici, quali le procedure amministrative, come mettere le bandiere negli uffici e addirittura la loro inclinazione all’esterno, quale tipo di carattere usare nei documenti, la spaziatura dei caratteri, i colori, l’inclinazione dei timbri… e -regolamento 2257/04- anche stabilire la curvatura massima dei cetrioli (10 mm) e la lunghezza delle banane (max 14 cm).
Ecco, sarà duro fare a meno di tutto quel sottobosco politico, fatto di sottocapi, sergenti e caporali a guardia del fieno per i muli.