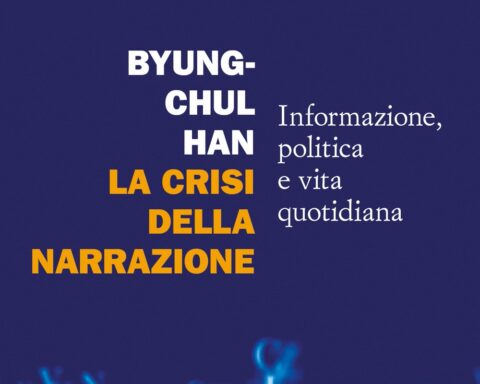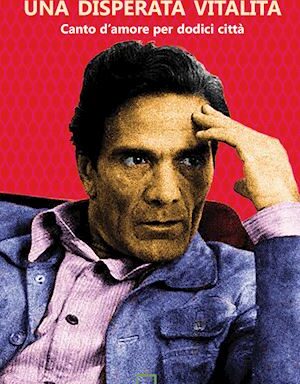Oggi ci addentreremo insieme nel mondo di “Se una notte di inverno un viaggiatore”, di Italo Calvino
“La storia inizia con il Lettore – un personaggio generico, che rappresenta ogni lettore – che si appresta a leggere il nuovo romanzo di Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore. Tuttavia, scopre presto che il libro che ha in mano è difettoso: le pagine si ripetono, il testo è incompleto. Tornando in libreria, incontra Ludmilla, una Lettrice affascinata dalla stessa opera. Insieme, si imbarcano in un viaggio letterario alla ricerca del vero romanzo, ma ogni volta che trovano quello che sembra essere il libro giusto, qualcosa li interrompe: un errore tipografico, una trama spezzata, un manoscritto scomparso.
Ogni nuova lettura li catapulta in un mondo diverso: un thriller in un paese dell’Est, un racconto erotico, un poliziesco, un giallo orientale, un diario esistenziale, un testo filosofico… Dieci in tutto. Ogni incipit ha un tono, uno stile, un ambiente e dei personaggi completamente differenti, e ogni volta il romanzo si spezza proprio sul più bello, lasciando il Lettore in una condizione di desiderio insoddisfatto.
La vicenda si sviluppa quindi su due piani: da un lato, la trama esterna del Lettore e della Lettrice, che si conoscono, si attraggono, si inseguono e si interrogano sulla funzione della lettura; dall’altro, i frammenti interni dei dieci romanzi, che rappresentano una sorta di viaggio nei generi letterari, nei linguaggi, nei mondi immaginari.
Nel corso del libro, Calvino riflette su che cosa significhi leggere, sulla tensione tra chi scrive e chi legge, sull’infinita frammentazione della realtà e sul potere del linguaggio. Il Lettore diventa una figura quasi eroica, sospesa tra l’ansia di completare una storia e la consapevolezza che ogni storia è, in fondo, un modo per cercare un senso che non si lascia mai completamente afferrare.
Il romanzo si chiude in modo circolare: dopo mille interruzioni, equivoci, editori corrotti, scrittori fantasma e trame che si perdono, il Lettore si ritrova finalmente a letto, accanto a Ludmilla, pronto a leggere… Se una notte d’inverno un viaggiatore. Il cerchio si chiude. Ma non si tratta di un finale rassicurante: è un invito, piuttosto, a entrare in modo consapevole e attivo nell’universo del testo, accettando che la letteratura non dia certezze, ma apra possibilità.”
PASSO DEL LIBRO SCELTO Ascolto podcast
COMMENTO
Nel romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, la figura del Lettore non è solo un personaggio, ma un simbolo vivo e universale: rappresenta chiunque si avvicini a un libro cercando qualcosa, che sia evasione, conoscenza, emozione, identità o ordine nel caos. Calvino costruisce un’intera narrazione in seconda persona – “tu” – per coinvolgere direttamente chi legge, costringendolo a specchiarsi nel protagonista, a interrogarsi sul proprio modo di leggere, sui desideri e le frustrazioni legati all’atto della lettura.
Il Lettore, nel romanzo, vive una continua tensione tra attesa e disillusione: ogni volta che comincia una storia, questa viene interrotta, deviata, censurata, smarrita o trasformata in qualcos’altro. Questo meccanismo, seppur frustrante, rivela un messaggio profondo: la lettura non è mai un atto passivo né lineare, ma un’esperienza fatta di ricerca, interpretazione, inciampi, e soprattutto di desiderio inappagato. Ogni lettura è, in fondo, un viaggio mai del tutto compiuto.
Calvino suggerisce che non esiste un “romanzo perfetto” né una verità definitiva da scoprire nel testo. La figura del Lettore, che insegue invano l’opera completa, simboleggia l’uomo moderno, alla costante ricerca di senso in un mondo frammentato, pieno di testi, segni, codici, ma privo di un centro rassicurante. Il Lettore è, quindi, anche un esploratore dell’infinito campo della narrativa, e al tempo stesso una vittima del sistema editoriale e culturale, che genera romanzi in serie, manipola testi, vende illusioni.
Attraverso il suo protagonista, Calvino mostra come la lettura sia un atto creativo, non meno dell’atto dello scrivere: il senso di un’opera nasce nell’incontro tra il testo e il lettore. Per questo, l’identità del Lettore resta indefinita: può essere chiunque, perché ognuno legge in modo diverso, ognuno proietta sé stesso nel libro che ha tra le mani.
L’unico modo per “concludere” la storia, alla fine, è accettare che la lettura sia un processo aperto, fatto di strade interrotte, ritorni e deviazioni. Il Lettore che alla fine si addormenta accanto alla Lettrice è, in fondo, un uomo che ha compreso che leggere non è dominare un contenuto, ma accogliere l’incontro con l’altro e con l’incertezza.
VITA E POETICA DI ITALO CALVINO
Italo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, a Cuba, da genitori italiani impegnati in campo scientifico. Pochi anni dopo, la famiglia si trasferisce a Sanremo, dove Calvino trascorre l’infanzia e l’adolescenza. Il legame con la Liguria e il paesaggio mediterraneo tornerà spesso nei suoi scritti, in forme più o meno esplicite. Durante la Seconda guerra mondiale, abbandona gli studi universitari in agraria per unirsi alla Resistenza partigiana. Questa esperienza segna profondamente la sua visione del mondo e la sua iniziale adesione a ideali politici progressisti. Dopo il conflitto, Calvino si iscrive alla facoltà di Lettere a Torino, dove inizia a frequentare ambienti culturali antifascisti e intellettuali legati al Partito Comunista Italiano, cui aderisce fino al 1957.
Nel 1947 pubblica il suo primo romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno”, in cui racconta la Resistenza dal punto di vista di un bambino, già mostrando un interesse per la dimensione simbolica e narrativa oltre la pura cronaca storica. Entra nella casa editrice Einaudi, dove lavora per molti anni come redattore, e qui stringe rapporti con grandi figure del Novecento italiano, tra cui Pavese, Vittorini, Moravia e Natalia Ginzburg.
La sua opera attraversa diverse fasi stilistiche e ideologiche: dal realismo neorealista del dopoguerra alla fascinazione per il fantastico e l’allegorico, passando per una profonda riflessione sul linguaggio, la scienza, la semiotica e la struttura della narrazione. Nel 1985, Calvino muore a Siena, lasciando incompiuta un’opera in cui rifletteva sul valore della leggerezza nella letteratura. La poetica di Italo Calvino è tra le più ricche, sfaccettate e innovative del Novecento italiano. Si sviluppa nel corso della sua carriera lungo tre assi fondamentali: l’impegno intellettuale, la tensione verso il fantastico e la riflessione metaletteraria. Calvino parte dal realismo neorealista, ma ben presto se ne distacca, convinto che la letteratura debba andare oltre la pura testimonianza del reale e offrire strumenti per interpretarlo, deformarlo e astrarlo, affinché il lettore possa coglierne i significati profondi. Nasce così la sua inclinazione per la fiaba, l’allegoria, il simbolo, il paradosso, elementi che si intrecciano alla razionalità e alla logica della scienza. Calvino concepisce la letteratura come una combinazione di leggerezza e rigore, fantasia e struttura.
Uno dei nuclei centrali della sua poetica è l’idea che la letteratura debba esplorare le possibilità del linguaggio e della narrazione, e non semplicemente raccontare storie.
Con l’opera “Le città invisibili”, Calvino si spinge ancora più in là, costruendo una narrazione in forma di dialogo filosofico tra Marco Polo e l’imperatore Kublai Khan, in cui ogni città descritta è una metafora dell’esistenza, del desiderio, del tempo, della memoria. Il suo stile, in questo periodo, si fa sempre più rarefatto, intellettuale e geometrico, come dimostrano anche i suoi testi più teorici, come le “Lezioni americane”, dove identifica i valori fondamentali della letteratura del futuro: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità (la sesta, la coerenza, è rimasta incompiuta a causa della morte).In tutta la sua opera, Calvino non smette mai di interrogarsi sul ruolo dello scrittore e della letteratura in una società dominata dal disordine, dalla complessità e dalla moltiplicazione dei segni. La sua risposta non è mai semplificatrice o retorica: è una fede razionale nella forma, nella precisione e nella capacità della mente umana di costruire senso. La sua è una letteratura ludica e seria al tempo stesso, che affascina per la sua capacità di accostare profondità e leggerezza, rigore e immaginazione, e che si rivolge a un lettore attivo, curioso, capace di orientarsi nei labirinti della modernità.