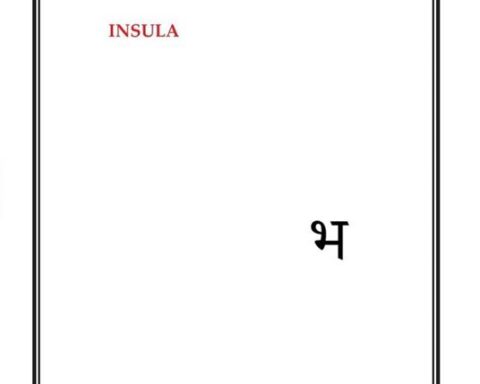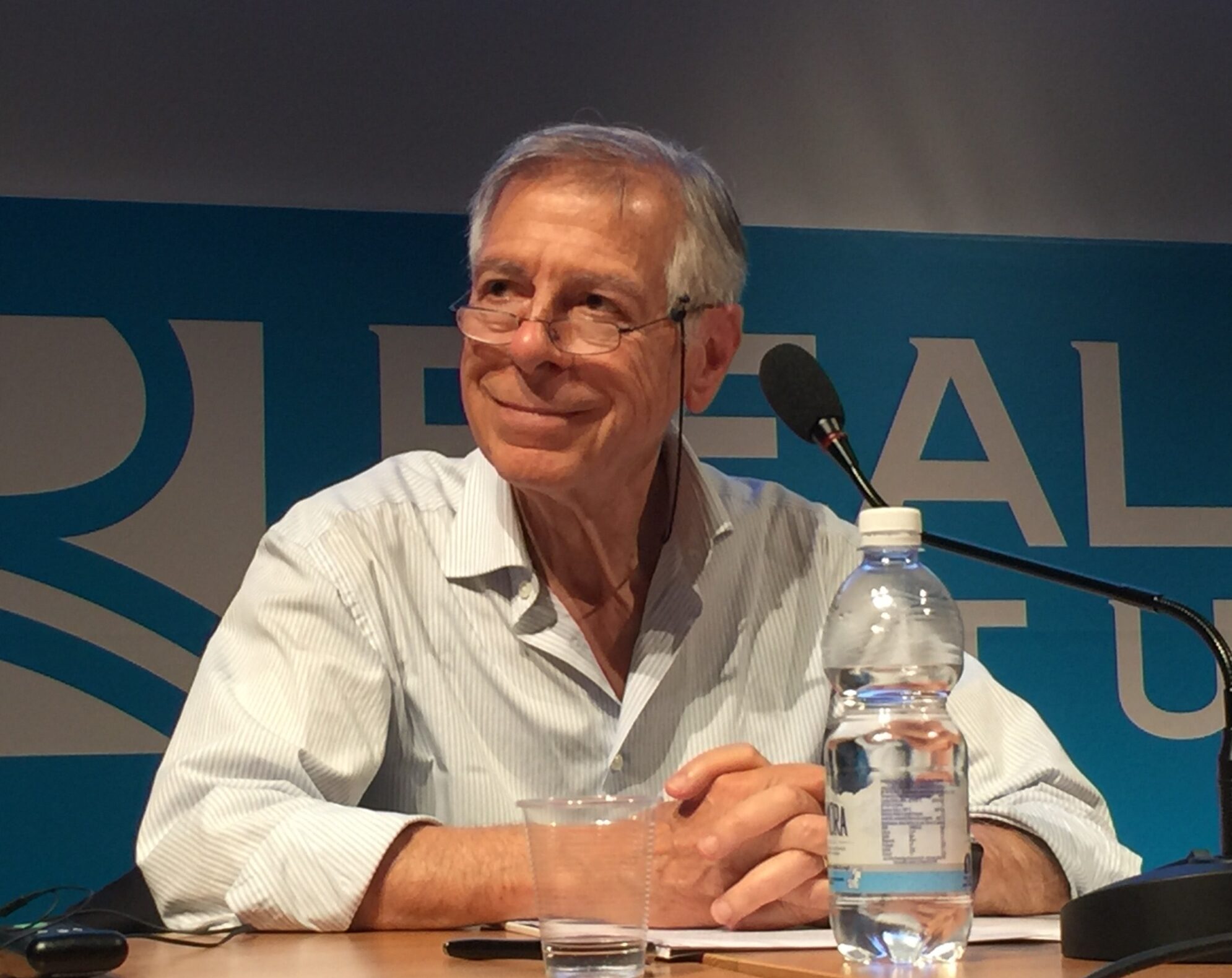A cento anni dalla nascita di Rocco Scotellaro, pubblichiamo questo saggio del professore Alberto Granese, già ordinario di Letteratura italiana presso l’Università di Salerno, che ricostruisce nei versi “moderni” del poeta-sindaco di Tricarico il paradigma poetico di un’ “antica civiltà”. Dallo studio di Granese, che pubblichiamo in tre puntate, emergono relazioni profonde tra Scotellaro e altri poeti della civiltà contadina, dall’Italia (Sinisgalli, Quasimodo, Gatto, Luzi e Zanzotto) all’Europa (sia gli spagnoli che i russi: Machado, Esenin, Kljuev); relazioni che si estendono ai poeti della civiltà contadina nel mondo. Tra questi ultimi, emergono interessanti nessi con i poeti negri del Terzo Mondo, dalla Martinica al Senegal: Césaire, Diouf, Hughes. E infine il saggio riscopre il “seme” di Scotellaro, che si ritrova nei poeti della nuova generazione. Un saggio su un tema inesplorato relativo alla poetica dell’autore lucano. Ringraziamo il professore Alberto Granese che ha fatto dono ai nostri lettori di questo studio così denso e innovativo, certamente destinato a lasciare il segno.
***
Un approccio corretto non può non partire dagli approdi recenti e innovativi su Rocco Scotellaro rappresentati dalla parte più strettamente critica della pubblicazione di Tutte le opere, affidata a Franco Vitelli, Giulia Dell’Aquila, Sebastiano Martelli e uscita da Mondadori nel 2019, che citerò con TO, inserendo, in parentesi tonda, la silloge di riferimento, È fatto giorno (EfG), Margherite e rosolacci (MeR), a cui segue il numero di pagina. Proprio Vitelli, nel saggio introduttivo e di presentazione del corposo volume, dal titolo significativo, Perché abbiamo bisogno di Scotellaro, chiosa le conclusioni di uno studio sulla comunità di Tricarico di George Peck sul modo di essere dei contadini, sulla bellezza anche di tipo estetico dell’armonia tra uomo e natura espressa nel loro lavoro, con questa riflessione: essere suo antico convincimento che «in ambito novecentesco la declinazione letteraria dell’ecologia trovi nella letteratura “contadina” un’attestazione di forte originalità». E, pertanto, richiamando il grande esperto di bonifiche, Manlio Rossi-Doria e il pensiero sul mondo contadino di Carlo Levi, giunge a definire l’opera di Scotellaro «ecologica», in quanto «vive sull’equilibrio che non tollera rotture traumatiche», tiene conto «per principio che “la terra è madre”» ed è, quindi, da considerarsi un «patrimonio esclusivo del Mezzogiorno», che riesce anche ad aprirsi «al Sud e al Nord, al mondo oltreconfine».
Paradigma poetico
di un’antica civiltà
Come definire e connotare, allora, in maniera concreta un discorso completamente nuovo e diverso per rileggere la poesia di Scotellaro, “poesia del mondo contadino”, partendo sempre dalla Lucania, ma andando oltre i confini regionali e possibilmente nazionali? Quale dovrebbe essere il campo semantico di tutte le “Lucanie nel mondo”? Intanto, consideriamo i primi due punti di avvio su Scotellaro: la definizione non di “poeta contadino”, troppo generica, tanto da ingenerare equivoci, sia perché avvolgerebbe la sua figura in un’aura leggendaria, sia per distinguerlo da un certo modo di produzione letteraria spontanea e naïf, ma di “poeta del mondo contadino”, in merito all’io lirico delle sue composizioni in versi che, distinto dal suo profilo autobiografico, dalla sua estrazione sociale e dal proprio codice culturale, assume le istanze di una voce corale, si oggettiva in un “noi” collettivo, si manifesta in un codice culturale “altro”, appartenente a una delle comunità rurali lucane; la definizione nuova, una volta svincolato da superficiali mitizzazioni, di essere tout court “poeta moderno”, il cui merito è sì di aver dato “voce” ai contadini, a coloro che voce non hanno, ma con la perfetta consapevolezza di possedere capacità e abilità nell’esprimersi in linguaggio poetico, di usare modalità dialettali e tipiche della cultura orale, niente affatto in maniera semplice e ingenua, ma sulla base di scelte stilistiche meditate, in cui elementi lessicali di area lucana, sintassi dell’oralità, voci degli altri e non soltanto di sé, combinati con immagini e ritmi della tradizione poetica colta, finiscono per rapportarsi tra loro non contraddittoriamente, ma per generare, dilatando spazi e orizzonti, una polifonia tale da attestarne proprio la modernità.
Vanno tuttavia aggiunte altre linee preliminari: il legame, comunque inscindibile, tra attività letteraria e impegno politico, inclusivo del dibattito meridionalista, della cultura socio-antropologica, dell’economia, della storia; il rapporto armonico / conflittuale tra mondo contadino e immaginario poetico, tra scoperta, nella mutata realtà delle cose, di un’antichissima civiltà e creazione letteraria per attualizzare e universalizzare gli elementi umani e ambientali da quel contesto forniti; la centralità del suo paese, Tricarico, che esclude il contrasto con la città, perché la città non è stata mai sentita da Rocco come parte del suo mondo umano e poetico, anzi, ricacciandolo sempre nel paese, gli ha reso impossibile salutarlo e lasciarlo definitivamente, perché il distacco avviene nel momento del suo maggiore attaccamento («Addio, come addio? Distese ginestre, / spalle larghe dei boschi / che rompete la faccia azzurra del cielo, / querce e cerri affratellati nel vento, / […] addio, come posso dirvi addio?», Passaggio alla città, TO (EfG) 90-91), anche se non si può completamente escludere in lui la dimensione urbana, da Potenza a Napoli, a Roma e soprattutto a Portici, luogo urbano e in un certo senso emblematico, necessario per riflettere sui punti irrisolti dei suoi progetti; il suo “distrarsi” al “bivio”, oscillando in maniera bipolare tra ricordi del passato e cambiamenti del presente, stando alla sua idea di fondo che le trasformazioni indotte dal progresso non avrebbero dovuto escludere, ma conservare i valori inalienabili dell’antica civiltà contadina, nella consapevolezza tuttavia che questa presenta dinamicamente nel corso della storia una natura composita con molteplici stratificazioni e, a seconda delle aree geografiche, si è pluralizzata in diverse comunità rurali ricche di elementi vivi innestati proprio in quella millenaria tradizione, soprattutto meridionale, a cui il poeta-sindaco di Tricarico fa riferimento: «Sud è la canzone dei primordi, / si muovono le dita / sulla rete dei ricordi» (Appunti per una litania, TO (MeR) 212-213).
La componente antropologica
non irretisce il canto libero
Queste ultime coordinate implicano due istanze ermeneutiche, su cui va fatta la dovuta attenzione. Anzitutto, per dare un’interpretazione complessiva dell’opera di Scotellaro la procedura analitica da seguire implica un percorso circolare tra componente antropologica storica, rappresentata dall’universo contadino, la sua stessa identità personale e sociale, in cui le polarità contrapposte, le contraddizioni irrisolte del suo mondo umano e poetico non sono affatto, secondo una lettura “in negativo”, delle prigioni che irretiscono il suo ‘canto’ libero, ma sono le condizioni aurorali, la matrici genetiche della sua ispirazione poetica donde quel canto trae origine e si espande in direzioni molteplici, a volte, identiche, altre, diverse e sorprendenti. Inoltre, dal punto di vita più strettamente artistico-letterario, va considerata la sua scelta di non usare le strutture fonetiche, ma solo lessicali e sintattiche, del dialetto, anche per non distanziarsi dal linguaggio dei contadini della sua terra, pur prefigurandosi l’ascolto da parte di un pubblico non strettamente legato alla cultura dialettale, ma, allo stesso tempo, non elitario, e rimanere coerente con il percorso della sua attività poetica, che – sulla base di una formazione ispirata alla produzione lirica italiana del tardo Ottocento e del primo Novecento, ma anche dei i livelli alti raggiunti dalla poesia francese, come dimostrano le traduzioni da Rimbaud, tra cui il manifesto stesso della Modernità europea, Il battello ebbro (TO (MeR) 260) – segue una linea di svolgimento, secondo una scelta strategica, a mio avviso, ben precisa e mirata, dal popolare (e non, come spesso si è confuso, dal folclorico o da un inerte primitivismo), dalla visione evangelica e dalla componente magica dell’immaginario contadino alla formalizzazione letteraria, fino a non farli considerare dei poli irrelati ma tra loro coincidenti, tenuto conto della formazione pluristratificata della lirica scotellariana, con influssi che vanno da Pascoli a d’Annunzio, da Saba a Ungaretti, da Campana a Rebora, da Sinisgalli a Quasimodo e su cui sono state prodotte diverse indagini, da Rosalma Salina Borello e Paolo Giovanetti a Maria Teresa Imbriani e Nicola De Blasi.
Si giunge, quindi, a una prima conclusione: per comprendere l’ideologia popolare e il mondo contadino, di cui ha inteso farsi voce poetica Scotellaro, formalizzato e superato dal livello espressivo e linguistico della parte più rappresentativa della sua produzione letteraria, indubbiamente la poetica, di forte slancio non tanto narrativo quanto essenzialmente lirico, reso in scelte metriche sospese, forme ellittiche e immagini scorciate, ma sempre dotate di un istintivo slancio comunicativo, si deve penetrare a fondo nelle componenti pluristratificate del suo immaginario, che ha contribuito a costituire il paradigma delle “Lucanie nel mondo”. Questa creazione è possibile in quanto si fonda sulla dimensione storica dell’universo popolare, soggetto a mutazioni spesso drammatiche attraverso il tempo ed estraneo alla visione mitica di una civiltà contadina immobile, tanto da fare di Scotellaro il poeta non solo del mondo contadino di Tricarico, ma di una pluralità di Tricarico, non solo della Lucania ma di tutte le Lucanie del nostro pianeta, ricostruibile proprio attraverso simboli e riti del mondo contadino lucano di un periodo ben preciso, ormai lontano dal biennio 1935-36 raccontato nel suo celebre libro da Carlo Levi e caratterizzato dagli anni 1943-1953, quando si dispiegò con passione e impegno la sua attività politica e letteraria.
Compare un’ibridazione
di taglio magico-cristiano
Questo paradigma presenta una sua ben precisa connotazione antropologica radicata non solo negli elementi magici («Cantate, che cantate? / Non molestate i padri della terra. / Le tredici streghe dai paesi / si sono qui riunite nella sera», I padri della terra se ci sentono cantare, TO (EfG), 35-36), ma anche in quelli religiosi ed evangelici, con un’ibridazione magico-cristiana, soprattutto nella visione della luce diurna fugatrice degli spiriti maligni («La luna piena riempie i nostri letti, / camminano i muli a dolci ferri», La luna piena, TO (EfG) 34). Scotellaro si era reso ben conto che la connotazione “sacra” si addiceva al paziente e duro lavoro nei campi del contadino per lenirne la sofferenza esistenziale («E ho saputo la rovina del pianto, / il canto del giovane Dio / e come la sera incalza anch’io: / Padre, Padre / perché tu m’hai abbandonato!», Eli Eli, TO (EfG) 57-58), che, nel poema dello “scalzacane”, È fatto giorno, fa assurgere per affinità a simbolo cristologico: «Sappiamo tutti la tua vera gloria / Signore della Croce / che non ha più bisogno d’incensi» (TO (MeR) 248-251: 248); «O Gesù, / ti piacque il giuoco del pane e del vino, / che piace anche a noi» (Olimpiadi, TO (EfG) 60-61).
La dimensione mitico-magica ha, com’è noto, una funzione centrale nell’universo contadino, che nella sua realtà di esistenza e di lavoro, fatta anche di oppressione, fame e malattia, si sente minacciato da potenze misteriose e occulte, come da un attacco notturno delle streghe («Le magiare attaccano di notte / la nostra cavalla saura. / Si è trovata la criniera / annodata e non si divide più», Le magiare attaccano la notte, TO (MeR) 193-194), ma che nel realismo poetico scotellariano, in sintonia con quel mondo, non rappresentano fenomeni irreali, in quanto il terreno e l’ultraterreno riescono a comunicare tra loro. Nelle culture popolari delle Lucanie, in contrasto con la luminosità del giorno è l’oscurità della notte, foriera di paure, che Scotellaro immagina sovrastargli («Mi prese la tua luce dai cespugli, / la notte mi avrebbe sommerso: / io sono un uccello, di bosco / che canta nell’aria persa», Io sono un uccello di bosco, TO (EfG) 85), ma che, insieme con il lupo e il vento, rappresenta anche un pericolo incombente per il contadino lucano:
Ma là, fuori dietro la masseria,
oltre il pontone
vicino alla pietra
è l’ululare del lupo inferocito,
è il grido selvaggio delle agnelle
che corrono oltre il placito Basento.
Il vento che mi ronza tutt’intorno
m’appaura: giaccio.
(Dietro il Basento, TO (MeR)188-189)
Morte e pianto rituale
evocano il mondo antico
Il vento è però elemento duplice, da un lato, inquietante per essere una manifestazione sensibile del regno dei defunti, dall’altro, donatore di pace, per cui alla sua potenza negativa («se le campagne scacceranno / il vento afoso che s’è levato», I padri della terra se ci sentono cantare) si oppone la sua forza conciliante («querce e cerri affratellati nel vento / che ci concilia con i morti», Passaggio alla città); alla sua immagine terribilmente nefasta, soprattutto quando la sua furia devastatrice sembra risvegliare i morti uccisi e gli spiriti erranti («Con questi venti nei nostri tuguri / svegliate la faccia dei morti violenti / e ci fate più lupi di prima», I santi contadini di Matera, TO (EfG) 41) fa da contrasto la sua concezione di energia animata e fraterna, tanto da riconoscerne la “voce”, le parole segrete («il vento è mio fratello», Notte di Roma, TO (MeR) 229). Il rapporto con il regno dei trapassati è in Lucania condizione indispensabile al contatto medianico con l’aldilà, per cui il lamento funebre è «frammento e rottame del modo di patire la morte e di oltrepassarla». Vale, pertanto, la pena di approfondirne soprattutto la dimensione antropologica con gli imprescindibili studi di Ernesto De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, saggio uscito nel 1958 da Einaudi, comprendente il fondamentale capitolo su «Il lamento funebre lucano», e di Giovanni Battista Bronzini, L’universo contadino e l’immaginario poetico di Rocco Scotellaro, pubblicato nel 1987 dalla Dedalo di Bari. La forza animata del vento è assimilata dal contadino lucano all’animazione della Natura, all’anima che il suo immaginario crede di percepire nelle piante e negli animali della campagna, come nel serpente, a cui sono attribuiti un ruolo mitico-ritualistico di custode domestico («Ora hanno trovato / le donne nello stipo / un serpente addormentato», Dormono sulle selci più grosse, TO (MeR) 203-204), una funzione generativa («[…] dovevano fare all’amore i serpenti / sulla rotabile distesa», Eli Eli), una sensazione sinestetica acustico-visiva trasformata in metafora («Come i vulcani che s’accendono / la grandine schiaffeggia la terra / il tuono sotterraneo serpeggia nelle case», Comizio volante, TO (MeR) 181; «A quest’ora è chiuso il vento / nel versante lungo il Basento […] un rumore di serpente / il treno nella valle?», Il cielo a bocca aperta, TO (EfG) 71-72).
Anche in Albino Pierro
troviamo i dolori del mondo
Nel linguaggio di un poeta corregionale di Scotellaro, Albino Pierro, di cui Tutte le poesie si possono leggere in edizione critica curata nel 2012 da Pasquale Stoppelli per la casa editrice Salerno, il paesaggio lucano con i suoi riconoscibili connotati fisici e antropologici sarà trasformato in selenico scenario protostorico e la storia stessa progressivamente ridotta in natura; una storia-natura, che si presenta al suo sguardo nella forma di rovine, di cui proprio il suo dialetto tursitano diviene inscindibile e muto luogo tombale. È storia dei dolori del mondo, delle sofferenze di creature soffocate dal peso di un lutto immane, espresso nelle forme laceranti della lamentazione funebre. In quanto tale, essa non procede secondo un idealistico sviluppo progressivo, dotato di una sua intrinseca logica, ma si presenta come un confuso viluppo intransitivo, bloccato in una chiusa fissità spettrale. Le consolidate e false convenzioni umane vengono irrise e destabilizzate da questa storia, che recupera la centralità della morte; è storia nascosta, sotterranea e notturna, che non esalta, come nella sintesi estetica della dimensione simbolica, la pienezza ottimistica dei valori umani in senso tradizionale e classico, ma li sottopone a una furiosa e sistematica demolizione, fino a distruggerli e a contemplarne sinistramente le spoglie, come relitti di un terribile naufragio.
Di notte, corre rischi anche chi cammina da solo nei sentieri di campagna e a Scotellaro non sfugge questo motivo di cui si rende interprete («Di notte un quarto d’ora è così lungo / al camminante», Giovane poesia, TO (MeR) 175), ma con una triplice valenza simbolica che investe il cammino esistenziale («Per chi vuol camminare / dalle tombe alle case / dalle case alle tombe», Le tombe le case, TO (EfG) 68-69), il cammino mattutino dei contadini di Tricarico diretti ogni giorno con le bisacce sulle spalle al lavoro nei campi («Si parte così / nel Sud per le campagne la mattina, / per la stazione rossa sull’arena / del fiume», Sera lontana, TO (MeR) 175-176) e quello dell’emigrante («Così Papà mio nell’America / stette degli anni a camminare / e poteva anche cadere / nessuno lo avrebbe chiamato», Così papà mio nell’America, TO (EfG) 101). Del resto, il dramma dell’emigrazione è motivo ricorrente nell’immaginario contadino e quindi poetico di Scotellaro, in quanto segno di sradicamento, ‘figura’ di un evento luttuoso di separazione, ma anche, come acutamente è stato osservato da Sebastiano Martelli, in un saggio pubblicato su «Oggi e Domani», nel numero di luglio-agosto 2004, Al bivio dell’emigrazione, «leva, sia pure lacerante, dei processi di cambiamento». Da una parte, è la figura del padre che, forse proprio per avere interrotto la corrispondenza ˗ dall’America scordarola («Ma Papà l’americano non scrive più», TO (EfG) 63-64) al C’era l’America, TO (EfG) 89-90: «America qua, America là, / dov’è più l’America / del padre mio?» e al Salmo alla casa e agli emigranti, TO (EfG) 111: «Il paese mio si va spopolando, imbarcano senza canzoni / con i nuovi corredi di camicie e mutande i miei paesani» ˗ assurge a metafora di rottura e discontinuità con il ritmo esistenziale dei contadini di Tricarico. Dall’altra, è l’immagine della madre, simbolo di immutabile legame e radicamento nella comunità paesana, trasfigurata in un’immobile vestale del focolare domestico:
Come hai potuto, mia madre,
durare gli anni alla cenere del focolare,
alla finestra non ti affacci più, mai.
E perdi le foglie, il marito, e i figli lontani,
e la fede in dio t’è caduta dalle mani,
la casa è tua ora che te ne vai.
(Casa, TO (EfG) 87)
Forza positiva del fuoco
e il focolare paterno
Ancora il “focolare” è evocato nei versi che riguardano il ruolo paterno, ma con un’accezione diversa, quando Rocco immagina suggestivamente che la forza positiva del fuoco, opponendosi alle immagini disforiche del vento e della notte, sembra suggerire al padre la sorte dei figli:
Padre mio che sei nel fuoco,
che brulica al focolare, come eri
una sera di dicembre a predire
le avventure dei figli
dai capricci che facevano.
(Padre mio, TO (EfG) 115)
Complesso, invece, il suo rapporto con la madre, espresso in un contrasto dai confini semantici problematici; in Il grano del sepolcro: «Verrà giugno, morirà anche mia madre, […] non morire, mamma mia, che ti vorrò più bene» (TO (EfG) 88); in Mamma: «Il sangue mi desti: / ecco la tua vita […] Muorimi, mamma mia, che ti vorrò più bene» (TO (MeR)128). Si noti però che Scotellaro, anche quando tratta temi intimi e personali, ma potenzialmente sociali, fa esprimere i contadini delle sue poesie, ciascuno con la propria identità, in maniera corale («Noi siamo rimasti la turba / la turba dei pezzenti, / quelli che strappano ai padroni / le maschere coi denti», Pozzanghera nera il diciotto aprile, TO (EfG) 44) e, con maggiore respiro poetico, in Noi non ci bagneremo:
Noi non ci bagneremo sulle spiagge
a mietere andremo noi
e il sole ci cuocerà come crosta di pane.
Abbiamo il collo duro, la faccia
di terra abbiamo e le braccia
di legna secca colore di mattoni
Abbiamo i tozzi da mangiare
insaccati nelle maniche
delle giubbe armacollo.
Dormiamo sulle aie
attaccati alle cavezze dei muli.
(TO (MeR) 211)
1 – continua