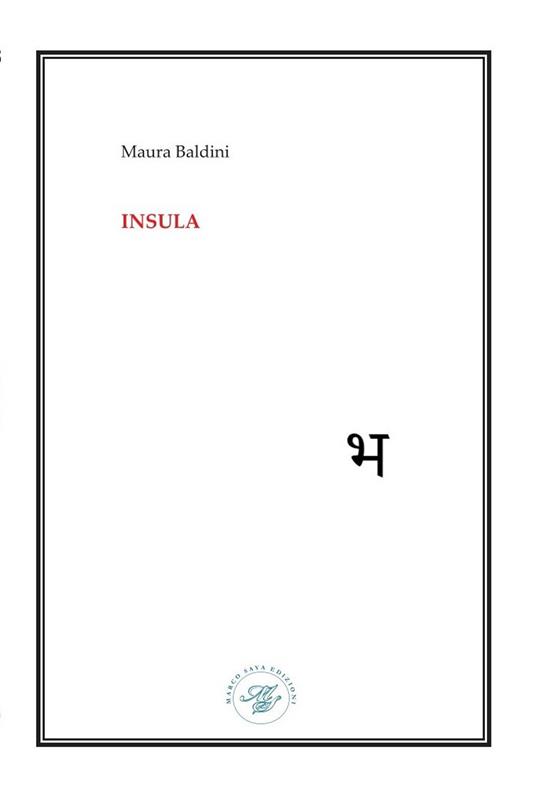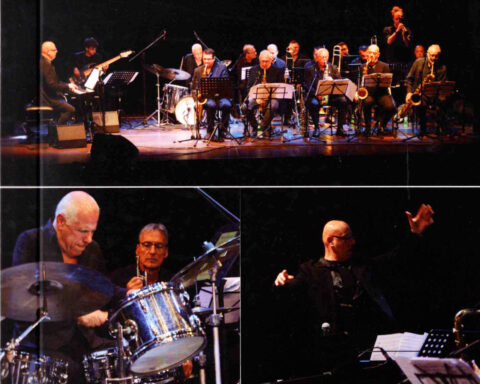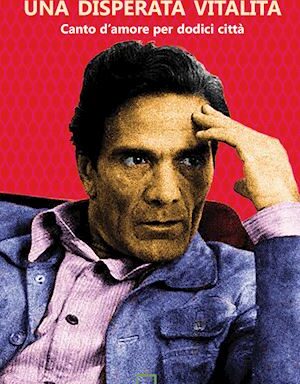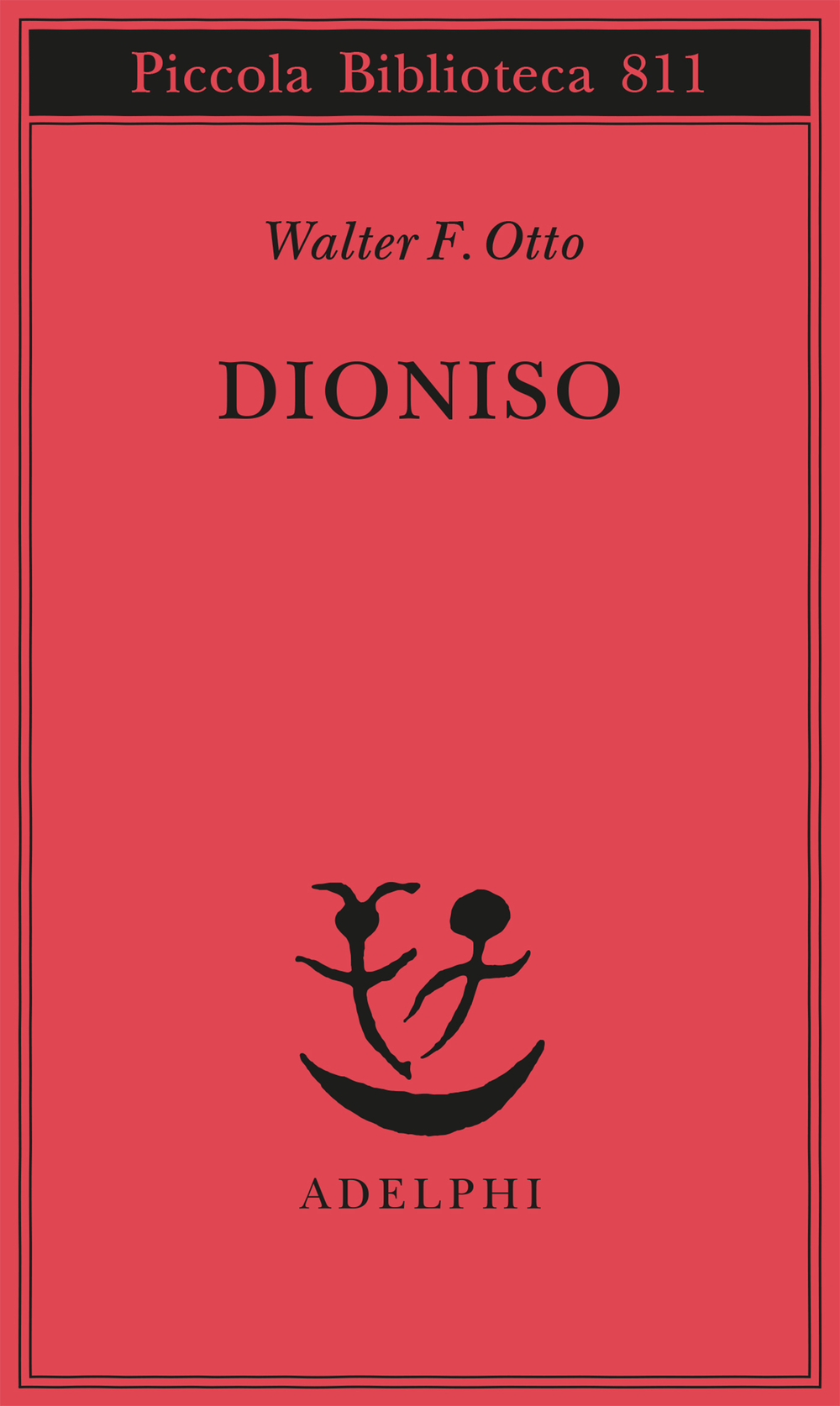Il passo ha la forza di gravita in basso,
la memoria di chi sceglie il contrappasso.
Ma una voce chiama da un forziere di foglie.
È un invito ad attraversare, un ponte breve
oltre il semplice morire. È la siccità dei cuori
che finalmente si dà pace. Il tesoro è qui
Nella schiena del figlio, arresa all’aspersione,
all’incanto dell’acqua, al giorno ultimo
che di ogni cosa sospende l’eterno annegare.
Maura Baldini con Insula, Marco Saya Edizioni, pag. 80, è alla sua seconda prova poetica. La prima, La slegatura, Il convivio Editore, pag. 81, sembra un preludio a questa, se non fosse altro che per la suddivisione dei testi in capitoli richiamo di un’origine: Ombra, Terra, Fuoco, Acqua. O, forse, di un luogo, dove gli elementi, un tempo osservati come riflesso di un archè, si addensano in un’asperità di volto e di nominazione. Se di primo acchito, i versi della Baldini, sembrano darsi come mere suggestioni di una terra desolata, larvata, quindi originaria, man mano che si va avanti nella lettura, invece, ci si rende conto che si ha a che fare con qualcosa di più smisurato. Non nel senso dell’enormità, o dell’infinito e nemmeno dello stupore o del timore, o di un’angoscia, ma nel senso di una ricomposizione di una frattura – La mia frattura è l’acqua, qual è la tua? […] Ripararla significa tornare,/cedere al paradosso/di una radice assente) – da ricercarsi in ciò che sia l’ontologia della luce e dell’ombra, quindi dell’Essere con tutte le sue possibili varianti d’im-possibilità e incarnazione (corpo e parola, realtà e verità, vita e morte, significato e significante e così via) sia la fenomenologia con la sua epochè, sospensione del giudizio, hanno messo in campo, precludendo quella messa in scena di un oltre che non sta, appunto, in un oltre della possibilità – gioco della possibilità e impossibilità – né tantomeno di un di là da venire, in un’escatologia, insomma, della fine stessa o della fine di un destino, ma sta o, almeno sembra potersi dare, in quella sembianza che è il volto. Io. Invece, ho abbandonato il nome/ma ho cominciato a innaffiare il volto. Che è l’Altro. L’Altro nella sua vera infinitezza finita d’irraggiungibilità. L’Altro che è. L’altro, tutti gli altri. In quella dimensione etica che è la sola possibilità di una metafisica. La morale non è un ramo della filosofia, ma la filosofia prima, scrive Lévinas in Totalità e Infinito. Insula, allora, è sì un viaggio in una terra (l’Islanda), per antonomasia primordiale e inospitale (il caffè, qui, è acidulo e ferroso), ma è anche la sponda, “la terra nei suoi semi alati” come la citazione di Saint-John Perse suggerisce.
La Baldini usa l’espediente della traccia o del rimando ad apertura di ogni testo come se da un senso se ne potesse trarre un magma compatto di segni che sono altresì attesa e nostalgia. Paesaggi. Anche dialogo. O, ancora, interrogazione. E, quindi, scrittura. Leggiamo, pertanto, a ogni inizio dei testi piccole gemme di autori come Borges, Rilke, Wordsworth, Shelley, Byron, Auden, Trakl, Amelia Rosselli, Antonia Pozzi e altri per quanti sono i versi o la durata del viaggio o di questo canto, forse salvifico, o forse immersivo di un domandare, di un incedere là dove i confini si restringono per accostamenti, per approssimazioni tra dimore di precipizi o di abissi di acqua e di fuoco. Tempo. Il tempo che si lascia smembrare da quest’isola baccante, scrive la Baldini. È tempo che la pietra accetti di fiorire,/che l’affanno abbia un cuore che batte./È tempo che sia tempo. Paul Celan. Il richiamo al poeta rumeno naturalizzato francese che si toglie la vita nella Senna da un’indicazione esatta di quale tempo: È tempo che il tarlo diventi la cura. Qui si aprirebbe una voragine di esemplari umani di calce e di silenzi. Non a caso la scrittura è soprattutto un non dire. Nel senso di un dire che deve essere proferito fino a un certo punto. Non perché non si abbia il coraggio di dire, ma perché ciò che andrebbe detto è irricevibile o indicibile. In entrambi i casi, il poeta lo sa, e lo ritraduce.
L’immagine, il simbolo, la figura dell’uroboro a inizio del libro è espressiva di una circolarità, un tutto che ricomincia daccapo quando si è soltanto all’inizio. Che ne è del prima? Nessuno sa/se siamo pronti a questa luce. Quale luce? Non la luce che lascia vedere, che separa l’apparire delle cose come da tradizione platonica e, quindi, un vedere dispotico già indirizzato al volere della luce, ma una luminosità che si lascia vedere. Una luce che non separa. Tra lo sguardo che vede e lo sguardo che si lascia vedere c’è tutto lo sforzo della Baldini e, forse, della poesia in generale di uno sguardo assoluto (completo), che non è metafisico nel senso di un’ontologia dell’oltre o di una visione mistica, e nemmeno di una fenomenologia dell’invisibile, ma è lo sguardo della scrittura. Non è la scrittura, la ricerca di un volto? Non è la scrittura, il volto? Il volto infinito della Parola? Questo seducente libro della Baldini ha un proemio e un epilogo. E non è un caso che sono scritti in corsivo. Il proemio esorta il lettore ad avvicinarsi ai testi. Vieni, avvicinati./Insula è un simulacro,/l’ora sulla quale immolare il tempo,/specchio di fughe e incandescenze./Idolatra è chi ne scava i volti/per scovare in essi il proprio,/raccogliendo, infine, cenere di chimera./Ma tu vieni. Avvicinati. Insula è un inganno? Il volto è figura del proprio volto? O dell’altro? O entrambe le cose? O, è una scrittura di cenere e il volto è tutt’altro? Per rispondere basta proseguire nel viaggio che si risolve nel Nóstos dell’ultima poesia, ma soprattutto nelle parole dell’epilogo: Non è fra questi abissi di luna/il volto che cercavi, non è qui,/nelle brughiere dell’origine,/non nel cristallo nero della fine,/non è nell’esilio,/e nemmeno nel ritorno./Sei tu la parabola dell’alba eterna/l’onda immensa che s’avvicina,/la speranza mai sopita/di un volto che abbraccia l’infinito. Chi è quel tu? Quale volto incarna? Forse, il volto della scrittura, ma di una scrittura che non fonda l’oggetto, che se ne distacca per e nel volto dell’altro e di tutti gli altri. E osserva. Ed è osservata. Credere d’incivilire un mondo/mentre l’ammorbate/con qualche nera piaga. Victor Hugo. Ecco, scrivere di libri così belli mette a disagio. Si ha la sensazione di aver scritto poco e nulla.
Maura Baldini, Insula, Marco Saya Edizioni, pag. 80
Maura Baldini è cresciuta sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, dove ha esercitato per molti anni la professione di avvocato. Oggi vive a Ginevra e si dedica, fra l’altro, alla traduzione e alla poesia. Di recente, ha tradotto André Malraux e Malcom de Chazal. Scrive, inoltre, articoli e saggi per Poesia (Crocetti-Feltrinelli), per Pangea e altre riviste e blog letterari.