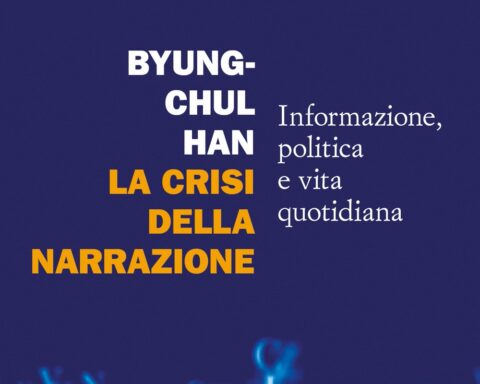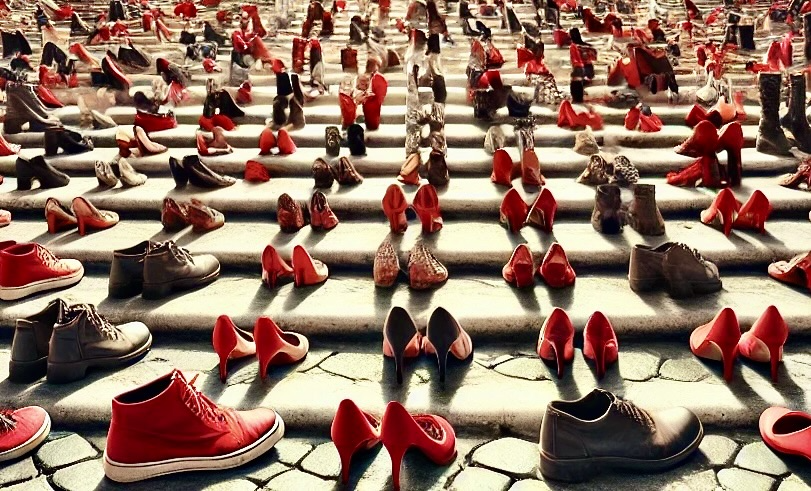I promessi sposi a scuola sono una lettura obbligata. E, in quanto obbligata, spesso è mal sopportata dai ragazzi. Probabile, quindi, che del celeberrimo primo romanzo della letteratura italiana, da adulti, si conservi l’idea di un libro lungo e soporifero. Come del suo autore, muso lungo e carattere noioso. Lui e la sua morale!
E se vi dicessimo, invece, che Manzoni non solo è colui che si è inventato la vicenda del manoscritto dell’Anonimo, quello della Provvidenza che prima o poi arriva e pareggia i conti, quello che, appassionato studioso di storia, si documenta e si documenta, per poi riempire, appunto, di documenti pagine e pagine del suo libro, ma – aggiungessimo – che Alessandro Manzoni è anche un geografo, ebbene il caro vecchio scrittore potrebbe forse acquisire, ai vostri occhi, il fascino di un moderno divulgatore scientifico – che so – alla maniera di Piero e Alberto Angela?
Immaginate allora che sia proprio Alberto Angela l’autore de’ I promessi sposi e che ce li racconti in una puntata di “Ulisse – Il piacere della (ri)scoperta (di Manzoni)”. Conclusa la sigla, vedremmo il nostro dinamico autore a bordo di un elicottero che sorvola il lago di Como. Cuffie in testa, voce alta a sopraffare il vento e poi la telecamera che regala una bella inquadratura aerea della zona di Lecco e dei suoi dintorni.
È così che inizia il romanzo, infatti, con un’inquadratura dall’alto, per definire elementi naturali e confini geografici di quel borgo dove tutto comincia. E poi, restringendo la visuale, lo sguardo cala più dettagliatamente su “quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”.
Angela a questo punto farebbe notare al telespettatore la particolare forma di un particolare rilievo, caratterizzato da un susseguirsi di “cocuzzoli”, come se fosse una sega, e spiegherebbe che quel monte è chiamato, non a caso, “Resegone”. Perché, se con la geografia descriviamo i luoghi, con la toponomastica diamo loro un nome: il che rappresenta il primo atto della interazione uomo-ambiente. Dare un nome alle cose vuole dire anche considerarle, accoglierle, amarle; non a caso il Resegone torna anche più avanti nel romanzo, quando Renzo è a Milano, lontano dal suo borgo: alza lo sguardo al cielo, scorge la cima ed è come se rivedesse un familiare lontano.
Ma, tornando alla prima parte delle riprese, con attenzione da geologo, il nostro Angela ci farebbe osservare anche il lavoro delle acque, che modificano l’aspetto dei monti, ci parlerebbe, ancora, del lago e del suo emissario, il fiume Adda. Tutta roba da documentarista, insomma. Quindi passerebbe in rassegna gli elementi che sul paesaggio naturale tratteggiano quello culturale: il ponte, le ville, i vigneti, i muri, le strade.
E per una di queste strade, il nostro Angela procederebbe a piedi, nella seconda parte del documentario, incamminandosi proprio per quella stradina per la quale torna “bel bello dalla passeggiata” don Abbondio, un attimo prima dell’incontro con i bravi di don Rodrigo, con un’impostazione, anche qui, tutta geografica. Don Abbondio è un fifone, non avrebbe alcuna intenzione di affrontare chi porta un enorme ciuffo e una reticella verde sul viso. Si sa che è gente di malaffare. Tipi di tal fatta incutono paura già solo a guardarli da lontano o solo a sentirli nominare o anche solo a pensarci. Perciò il povero curato fuggirebbe, se potesse. Ma non può, perché i bravi lo aspettano in un punto in cui la strada si divide “in due viottole, a foggia d’un ipsilon”. Arrivato a questo punto, dunque, don Abbondio non può tornare indietro né darsela a gambe. È il luogo che determina l’incontro. Incontro che mette in moto tutta la vicenda. Non vi sarebbero “I promessi sposi”, infatti, senza la fatidica frase “Questo matrimonio non s’ha da fare” ovvero senza quelle “viottole a foggia d’un ipsilon”. Ecco perché Manzoni, ops Angela, si sofferma così dettagliatamente sul percorso del curato.
Quando poi è il momento di presentare quel prepotente di don Rodrigo, non si inquadrano o non si descrivono volto, occhi, naso, gambe, braccia. Ma impera il palazzotto dove abita: vediamo il luogo e intendiamo il personaggio. Magia del rapporto intimo tra uomo e genius loci. L’Anonimo non dice esplicitamente dove si trovi questo palazzo, ma il buon Angela ce lo mostra in relazione al “paesello degli sposi”, dicendo che si trovava più in alto. È un esempio, questo, di uno dei concetti fondamentali della geografia: l’ubicazione. Per la precisione, l’ubicazione relativa; oltre a essere un evidente traslato della superiorità di don Rodrigo, in quanto a forza e potere, rispetto ai due giovani promessi.
La componente geografica, naturalmente, è molto intensa anche nell’Addio ai monti, altro passo celebre del romanzo; laddove, oltre alla descrizione dei luoghi dal punto di vista di Lucia – una sorta di mappa percettiva – si notano due fattori che sono alla base di quello che, su larga scala, è il fenomeno della migrazione: Lucia abbandona, con molto dolore, il suo borgo, perché lì non è più al sicuro. E questo è il fattore di spinta: la mancanza di sicurezza. E si dirige presso il convento di Monza, poiché è lì che spera di trovare protezione. E questo è il fattore di attrazione. Entrambi i fattori sono le costanti dei flussi migratori che da sempre hanno riguardato l’umanità, ogniqualvolta si è lasciato un luogo per raggiungerne un altro.
Ma, tornando alla nostra puntata speciale, ci sarebbe ora da avvicinarsi con la telecamera, e soprattutto con il microfono, al fiume Adda, per farne ascoltare ai telespettatori la voce, la stessa che sente Renzo, quando è in fuga, impaurito, prima di raggiungere suo cugino Bartolo. Cominciò a sentire un rumore, un mormorìo, un mormorìo d’acqua corrente. Sta in orecchi; n’è certo; esclama: – è l’Adda! – Fu il ritrovamento d’un amico, d’un fratello, d’un salvatore… L’Adda non è un elemento della natura che fa da cornice statica alla sequenza narrativa, un disegnino infantile per abbellire la scena; insomma non è un piatto elemento geografico, ma un personaggio vero e concreto, con la sua voce, la sua storia. Non è protagonista, certo, ma comunque ha il suo rilievo nella vicenda ed è di grande sollievo, a questo punto della storia, se si ha un minimo di empatia per il povero Renzo.
Altri passi di Manzoni geografo ce ne sono eccome: di Lucia a Monza, della peste, del Lazzaretto o nell’ultimo capitolo, quando ci si ritrova nel bergamasco et cetera et cetera. Ma non possiamo rivelare in un articolo tutte le sorprese.
Certo è che “il sugo di tutta la storia” è condito, in buona parte, anche di geografia a volontà.