⁸Le cinque classiche domande della geografia (e, ancor prima, del giornalismo anglosassone) aiutano a fissare le coordinate del quadro in cui si inserisce questa nuova, articolata pubblicazione di Gigi Di Fiore (“Le Borboniche”, Utet, 2025). Il volume, al ritmo di una cronaca giornalistica, ripercorre, con una puntualità e meticolosità che sfiorano l’acribia, tutti gli eventi che segnano l’ascesa, l’apoteosi e il declino del regno borbonico di Napoli (divenuto, dopo il 1815, delle Due Sicilie). Lo fa, però, “sub specie feminae”, muovendosi, cioè, nel solco di 127 anni di storia (1734-1861) assumendo come fil rouge il punto di vista delle donne, in particolare delle mogli dei re Borbone, di cui ricostruisce vicende istituzionali ed esistenziali.

Con ciò il volume non si inserisce nel filone letterario del gender, oggi molto di moda, ispirato cioè ai dettami del politicamente corretto e della cultura WOKE. Gli otto capitoli in cui si suddivide, dedicati ad altrettanti personaggi femminili, seguono piuttosto una pista prettamente storico-analitica molto ben documentata, ricostruendo le loro vite, tra tempi e spazi d’azione, a partire dalle ramificate ascendenze familiari e dal contesto geografico-culturale di provenienza. I matrimoni, come è noto, erano per i Borbone, così come per tutti i regnanti del tempo, un mezzo per consolidare alleanze politiche, strategiche e militari, stringendo o rafforzando i legami con le più illustri e potenti casate d’Europa, in una sorta di Unione ante-litteram. A tal fine la condizione prioritaria era che il matrimonio producesse frutto, con la messa al mondo di una prole numerosa e, innanzitutto, di almeno un erede di sesso maschile. Da questa circostanza dipendeva la riuscita dell’unione e il valore specifico della donna che, una volta diventata madre di un figlio maschio, aveva diritto a far parte del consiglio di stato, assumendo così un ruolo anche politico.
Basandosi su una grande molteplicità di fonti, dirette e indirette, Di Fiore cerca quindi di ricomporre il puzzle dei diversi aspetti della personalità di queste otto protagoniste, di cui oggi restano solo frammenti e qualche traccia scritta. Fatta eccezione per il vasto archivio di lettere che documentano la vita e le attività politiche di Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, regina di Napoli dal 1768 al 1814, le altre mogli dei Borbone hanno lasciato di sé pochissime testimonianze autografe. Si tratta di figure spesso rimaste dietro le quinte della storia, costrette a vivere in un mondo a misura d’uomo, tra lutti dolorosi, intrighi di corte, fermenti rivoluzionari ed eventi catastrofici di una natura feroce, nella costante preoccupazione di gestire il potere in modo direttamente proporzionale alla loro capacità di influire sui loro mariti e re.
Il che implica che la descrizione del loro aspetto, dei loro caratteri, della loro intelligenza, delle loro amicizie, tra pregi, difetti e inclinazioni, sia affidata quasi interamente alle testimonianze lasciate dagli uomini che, a vario titolo, le hanno incontrate e conosciute, vale a dire ai punti di vista maturati da sguardi prettamente maschili. Sono così oggetto di unanime apprezzamento la loro formazione culturale, il rigore, l’equilibrio, la continenza dei loro costumi; sono invece, per converso, criticati e guardati con sospetto i loro orizzonti intellettuali, soprattutto quelli troppo liberi e “progressisti” (di cui lo statuto della real colonia di S. Leucio rappresenta una manifestazione tangibile), tanto più se accompagnati dalle ingerenze negli affari dello Stato, considerati pericolosi per la sotterranea rivalità tra la matrice spagnola dei Borbone di Napoli e quella austriaca di quasi tutte le loro consorti. È questo il caso di Maria Amalia di Sassonia (moglie di Carlo di Borbone) e di Maria Carolina d’Austria (moglie di Ferdinando IV, divenuto I dopo la Restaurazione), due “tedesche” accomunate dall’intelligenza, dall’ambizione politica e dalla grande influenza sui propri coniugi. Non a caso quest’ultima, come già avvenuto in Francia alla sorella Maria Antonietta, è colpita dall’arma della diffamazione, con la diffusione, dopo la rivoluzione partenopea del 1799, di quelle che oggi chiameremmo “fake news”.
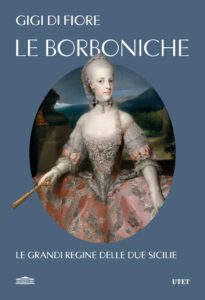
Un’attenzione più serena e benevola ispira invece il personaggio di Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, sposata da Ferdinando I (rimasto vedovo) con un matrimonio morganatico, ma detestata e umiliata per tutta la vita dall’erede al trono, Francesco I. Spinto dalle strategie materne, quest’ultimo sposa a sua volta l’arciduchessa d’Austria Maria Clementina d’Asburgo-Lorena, sua cugina di I grado, figura tanto amabile quanto fragile (muore giovanissima, senza essere diventata regina); per ascendenza paterna, gli è cugina anche la seconda moglie, Maria Isabella di Spagna, caratterizzata da una fragilità non fisica ma culturale. A mitigare le sue intemperanze, una volta rimasta vedova, pensa il figlio Ferdinando II, il “re bomba”, salito al trono nel 1830, costretto a misurarsi con i moti del 1848 e con quelli successivi, in una congiuntura internazionale sfavorevole, di cui non coglie il pericolo reale. I suoi ripetuti viaggi tra le province del Regno, volti a dare un segno tangibile della sua azione di governo, così come i suoi predecessori avevano fatto soggiornando nei casini di caccia (presidi reali, oltre che luoghi di delizie), gli mostrano gravi criticità territoriali e l’estrema povertà delle popolazioni residenti, sulla scia delle descrizioni geografiche di Giuseppe Maria Galanti, Teodoro Monticelli e, soprattutto, di Carlo Afan de Rivera, direttore generale di Ponti e Strade. Quest’ultimo, in particolare, come ricorda Di Fiore, a proposito dei progetti per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari, esprime al re una serie di osservazioni, tuttora attuali, sulla maggiore utilità di quelli marittimi e portuali per un un Regno di natura peninsulare, quale quello delle Due Sicilie. Simili riflessioni sono però distanti dagli interessi di Maria Cristina di Savoia, prima moglie di Ferdinando II, passata alla storia come la “regina santa”, che spicca per la sua profonda religiosità e sensibilità d’animo nonché per la brevità della sua esistenza: muore infatti alcuni giorni dopo avere dato alla luce Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie. Contro di lui si concentra l’ostilità segreta della seconda moglie di Ferdinando, la matrigna “tedesca”, Maria Teresa Isabella d’Austria, altrettanto lontana dai problemi strutturali del Regno, ma concentrata nell’odio crescente verso i rivoluzionari liberali. La sua docilità apparente cela un cieco e ostinato attaccamento al potere, degenerato, una volta vedova, in atteggiamenti paranoici fino all’autolesionismo, con un astio costante verso il figliastro, diventato re all’improvviso, senza un’adeguata preparazione, e convolato a nozze con Maria Sofia di Wittelsbach (sorella di “Sissi”, imperatrice d’Austria). A quest’ultima e alla sua grande bellezza e personalità è dedicato l’ultimo lungo capitolo del volume di Di Fiore, che ne rievoca il soprannome dannunziano di “Aquiletta bavara” e ne ripercorre la straordinaria esistenza, tra il crollo del Regno delle Due Sicilie e l’avvento del Fascismo.
Le complesse vicende ricostruite dal volume si svolgono nei luoghi emblematici del regno borbonico, a cominciare dalla città di Napoli, sede del palazzo reale, della reggia di Capodimonte e di prestigiosi edifici, talvolta destinati a scopi sociali (basti pensare al Real Albergo dei Poveri). La capitale, con la sua natura bifronte, è allo stesso tempo emblema del pericolo rivoluzionario nei momenti più critici delle vicende storiche del Regno, inducendo i reali a trasferirsi altrove. Emergono così le descrizioni della più sicura e decentrata reggia di Caserta, costruita sul modello del palazzo reale di Versailles, della fortezza di Gaeta, estremo baluardo per la difesa del Regno e della stessa dinastia, mentre la Sicilia diventa sinonimo di esilio, ma anche di pericolosi fermenti rivoluzionari. L’isola, dopo la Restaurazione, rivendica la perduta autonomia amministrativa, ma è anche luogo di uno scontro economico-commerciale tra il Regno delle Due Sicilie e l’Impero britannico, interessato alla sua funzione di avamposto europeo sul Mediterraneo e di passaggio verso le colonie inglesi dell’Africa e dell’Asia. Parte quindi proprio da qui uno degli snodi geopolitici che, sullo sfondo della guerra di Crimea e della seconda guerra d’indipendenza italiana, conducono alla fine il Regno delle Due Sicilie.
La parabola esistenziale delle otto “Borboniche” del volume di Di Fiore si presenta quindi strettamente legata a una più ampia vicenda storica, di cui queste protagoniste sono state parti integranti. Le loro vicende biografiche non sono dunque fini a sé stesse, ma contribuiscono a osservare da una prospettiva diversa e multiscalare la sequenza incrociata degli eventi e micro-eventi storici che portarono alla dissoluzione del Regno delle Due Sicilie, sancendo la fine di un modello politico istituzionale fatalmente destinato a soccombere di fronte alle più avanzate istanze del processo unitario italiano.
Professore ordinario di Geografia presso il Dipsum dell’Università di Salerno
e responsabile scientifico del GenderLab (Laboratorio didattico interdisciplinare di studi di genere)




