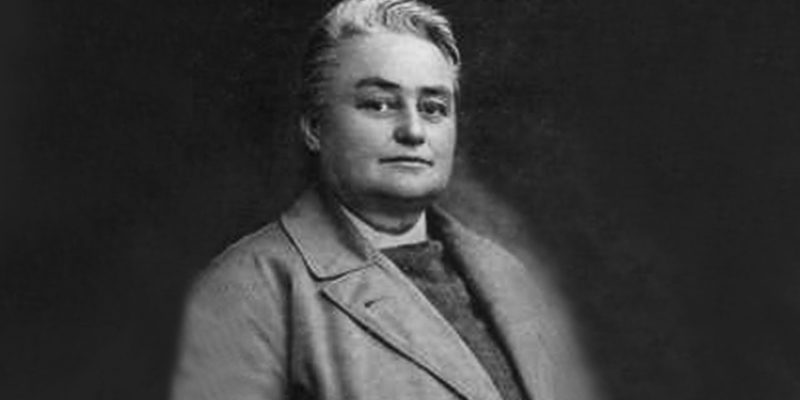Mi chiedo come ho fatto a non conoscere prima d’ora lo scrittore Michael Bulgakov, e non perché si debba conoscerli tutti, cosa impossibile, ma perché la lettura di questo autore mi calza egregiamente e mi regala un tale godimento come poche volte mi è capitato. Si tratta di uno degli scrittori russi più significativi del novecento. Un medico nato a Kiev nel 1981, ma trasferitosi all’età di 30 anni a Mosca, dove visse tutta la sua vita. La sua passione per la scrittura era talmente forte da indurlo ad abbandonare presto la professione medica per dedicarsi al giornalismo, alla letteratura, al teatro. Purtroppo non visse a lungo. Morì a soli 49 anni per sclerosi renale. Aveva pubblicato varie opere, ma il suo romanzo capolavoro (che è stato anche caso letterario), è ‘Il Maestro e Margherita’. Si tratta di un’opera postuma pubblicata nel 1966 prima, in versione censurata, e nel 1969 poi, in versione integrale. È questo il libro che gli ha conferito la fama.
Ma quello a cui desidero fare riferimento, e che consiglio a chiunque voglia leggere anche per divertirsi, è ‘Cuore di cane’, scritto tra il 1923 e il 1925 ma pubblicato solo 40 anni dopo, per via di un lungo travaglio editoriale, e grazie proprio a un editore italiano: De Donato. Un romanzo satirico sui nuovi ricchi che imperarono dopo la rivoluzione bolscevica, e dove l’autore dà prova di quanto lontano possa arrivare l’umana fantasia. Protagonista è un cane di strada, che in un pomeriggio più nero della notte viene adescato da uno scienziato di fama internazionale, Filipp Filippovic. Il cane, di cui l’autore Bulgakov dà voce ai pensieri, è sofferente per avere ricevuto una pentolata d’acqua bollente addosso. Non andava a genio a un cuoco taccagno, che col suo crudele gesto gli ha provocato una grave ustione al fianco. Quando il cane e il chirurgo scienziato si incontrano, l’uomo sembra interessato solo ad aiutare il cane, che attira a sé chiamandolo Pallino, e offrendogli una generosa quantità di salame. In realtà ha altro per la mente. Arrivati alla suo lussuoso appartamento riceve, oltre ad alcune visite di pazienti, quella di un certo Schwonder, rappresentante dei membri del Nuovo comitato del caseggiato. La questione sollevata è che il chirurgo Filipp Filippovic abita da solo in una casa di ben sette stanze e il comitato non approva, auspicando invece un utilizzo più equo degli alloggi.
‘Cuore di cane’ è una storia fantastica, ma pure un’aspra critica alla società dell’epoca, che anche dopo la rivoluzione consentiva ancora alla leadershep sociale la salvaguardia dei propri privilegi. Tante persone stipate in piccoli appartamenti di poche stanze, e di contro uomini in vista come il suddetto scienziato cui continuano ad essere garantiti enormi vantaggi. Dopo essersi liberato in malo modo delle tre persone del comitato venute a protestare, lo scienziato si siede a tavola e disquisisce col suo assistente su quanto sia importante per i russi saper stare a tavola (ancora oggi è così), saper mangiare bene e persino saper conversare durante il pranzo! Pallino, cui Filippovic elargisce gustosi bocconcini, non crede ai suoi occhi. Possibile che dalla strada sia finito in questa casa delle meraviglie?
Andiamo avanti. Di lì a non molto, un giorno in cui Pallino avverte un brutto presentimento, viene portato a forza in sala operatoria, grazie soprattutto all’assistente Bormental, che il cane chiama il Morsicato, perché la prima volta che lo ha visto gli si è attaccato agli stinchi. Pallino scalpita, ma un pezzo di ovatta imbevuto di cloroformio e premuto sul suo muso, fa quel che deve. Queste sono le sue ultime gesta canine. Il cane cade anestetizzato. Scopo di tutto ciò è un esperimento. Nel cervello di Pallino viene innestata una ipofisi umana e nel suo scroto testicoli di uguale provenienza, nella fattispecie appartenenti a un suonatore di balalaika morto alcoolizzato.
Addio Pallino. Addio cane girovago e spensierato. Stavolta rischia la morte, ma dopo averla rischiata così tanto, infine si risveglia. Il Morsicato tiene un diario clinico. Nei giorni seguenti l’animale, che già non è più propriamente un cane, manifesta un riso sgradevole. Si gratta, si guarda intorno, e pronuncia la sua prima parola da umano: borghesi! La parole successive sono bestemmie. I due medici sono esterrefatti. Nei giorni a venire, spara una parola nuova ogni cinque minuti. La supposizione del Maestro Filippovic è che l’ipofisi innestata, una volta attecchita, abbia attivato nel cervello canino la valvola del linguaggio, e vocaboli nuovi scorrono senza tregua. Non solo, ma il suo corpo di cane si trasforma in corpo d’uomo. È stato operato il 23 dicembre.
Dal diario clinico del 17 gennaio:
Struttura umana al 100%.
Peso Kg 48.
Testa piccola.
Ha cominciato a fumare.
Alimentazione umana.
Si veste da solo.
Sa sostenere una conversazione.
Cosa accade nel prosieguo, è segreto del libro. Di sicuro Pallino, ora denominato Pallinov, ma all’anagrafe registrato come Poligraf Poligrafovic, non è uno stinco di santo, ma una persona abietta, spregiudicata, avida e calcolatrice, che darà filo da torcere ai due medici e che loro faranno di tutto per eliminare. Dialoghi irresistibili, esilaranti duelli verbali tra rappresentanti delle agiatezze e del proletariato (lo sciagurato Pallinov, capace di imbrogliare e rubare, vagheggia comunque di prendere tutto quanto esiste e spartirlo tra la gente).
Per i russi (e non solo), ‘Cuore di cane’, insieme a ‘Il Maestro e Margherita’, occupa un posto privilegiato nella prosa di Bulgakov, e questo anche grazie alla fortunata trasposizione teatrale che ne fece il regista Vladimir Borko nel 1988. Nel clima del disgelo e della perestroika, la sua diffusione poté espandersi ed attecchire come il romanzo meritava.
Pregio dell’opera sta anche nella maestria dell’autore nel saper scrutare tutto ciò che accade intorno, soprattutto in termini di cambiamento.
E che dire del coraggio di Bulgakov nel parodiare con sagace ironia sulla classe dirigente russa? La sua vena satirica mai tenuta a freno gli costò non pochi osteggiamenti da parte del regime sovietico. Ma Bulgakov andò sempre per la sua strada, prova ne è tra l’altro il fatto che si sposò tre volte, fatto quantomeno singolare a quell’epoca. L’oppressione della censura sugli intellettuali contrari al regime cooperò al suicidio, nell’aprile del 1930, del poeta Vladimir Majakovskij, che si uccise sparandosi un colpo di pistola. Dopo questo episodio, Stalin si occupò personalmente di rivedere la posizione di alcuni scrittori. A Bulgakov, che aveva sempre chiesto di espatriare (senza alcun risultato), concesse, telefonandogli di persona, l’utilizzo del teatro d’Arte di Mosca. Qui poté lavorare come autore sceneggiatore e regista, ma pur sempre contrastato dalla critica di regime.
Da stralci della missiva dello scrittore inviata a Stalin il 28 marzo 1939: “Considero la lotta contro la censura, di ogni genere e quale che sia il potere che la sostiene, come un mio dovere di scrittore, non meno degli appelli alla libertà di stampa. Sono un fervido sostenitore di questa libertà e dichiaro che uno scrittore che la ritenesse superflua sarebbe come un pesce che affermasse pubblicamente di non aver bisogno dell’acqua. Ecco dunque una delle caratteristiche della mia arte, che da sola è già più che sufficiente a vietare alle mie opere diritto di cittadinanza nell’URSS.”