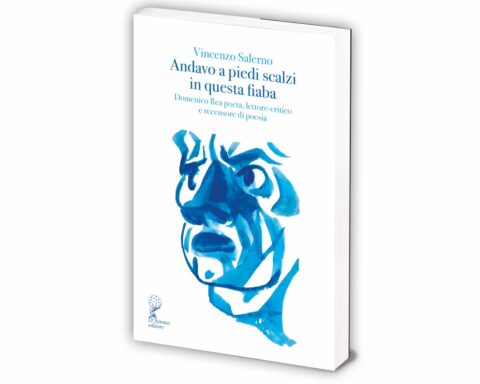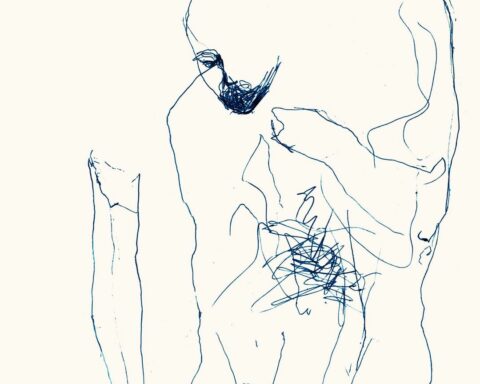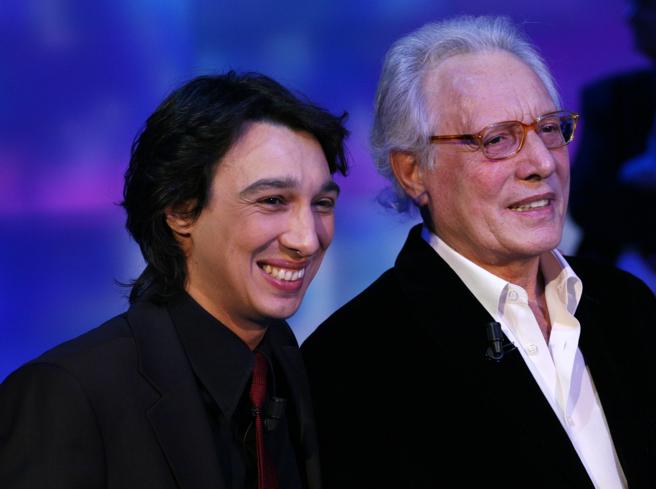È ancora possibile la poesia? È il titolo del discorso che Eugenio Montale tenne a Stoccolma nel 1977 in occasione del conferimento del Premio Nobel per la letteratura. Ecco, la domanda se sia ancora possibile la poesia, mi fa rimbalzare questa strana considerazione. Riflessione. Perché non ci si chiede mai, o non ci si è mai chiesto se sia ancora possibile la scienza? Se la scienza sia finita o, al più, se essa sia in declino, se essa si sia depauperata nell’odierna civiltà ad alta tecnologia e digitalizzazione? Se essa, in breve, sia morta? Perché a finire, è sempre Dio, l’arte, la letteratura, la poesia e mai la scienza? Credo sia una domanda legittima e non per niente faziosa. E con tanto rispetto di Hegel o di chi, prima di lui, ha iniziato un’interrogazione che sembra offrirsi senza fine, oltre ad essere un’idea concetto di tutto il Novecento.
Una domanda alla quale si cercherà di dare una risposta (magari indiretta) nei limiti di una breve meditazione o di uno spiccio raccoglimento, ma non prima di aver presentato questo intrigante volume fresco di stampa: È ancora possibile la poesia – Poetry Nobel Lectures, Vallecchi, pag. 315. Introduzione di Roberto Galaverni. Disegni di Simone Cortello. Qui, in questa eterogenea raccolta d’intelligenze, di spiriti, di ombre pensanti, s’intende immediatamente la sparizione del punto interrogativo. Sì, la poesia è possibile. È ancora possibile. In ogni caso, c’è qualche dubbio? Forse sì, ma non da parte dei poeti che qui rappresentano non tanto un’idea univoca di poesia quanto un’eterogeneità di prudenti saggi atti a rilevare l’esigenza di uno scrivere che si accenna o si rimarca come necessità fondativa dell’essere. Un’urgenza della scrittura, quanto di un’etica e di un’estetica, di un lirismo, che s’intessono con le diverse esperienze personali di uomini e donne sempre alle prese con una realtà che si cerca di comprendere nella sua autenticità e nei suoi contraccolpi crudeli ed enigmatici.
Prima di inoltrarci ulteriormente, però, è indispensabile riportare i nomi dei poeti presenti in questo volume, che ha di suo l’originalità di raccogliere i testi pronunciati nella circostanza del conferimento del premio più importante che sia mai stato istituito, il Premio Nobel. Eugenio Montale (1975). Vicente Aleixandre (1977). Odisseus Elytis (1979). Czeslaw Milosz (1980). Jaroslav Seifert (1984). Wole Soyinka (1986). Joseph Brodsky (1987). Octavio Paz (1990). Derek Walcott (1992). Seamus Heaney (1995). Wislawa Szymborska (1996). Gao Xingjian 2000). Louise Glück (2020). Forse, la domanda sul senso della poesia e sulla sua possibilità di esistere e di resistere, a questo punto, andrebbe riformulata in maniera più chiara, ma qui si tratta di sensibilità poetiche non filosofiche. A latere, verrebbe da chiedersi se il domandare ha ancora una sua specifica disciplina. Oppure: quanto è distante la filosofia dalla poesia? O, ancora, quanto entrambe sono lontane dalla scienza? Ma veniamo alla domanda cardine, forse utile a istituire un luogo nel quale abbia senso un comune legame, un vincolo che unifica il pensare con la sua trascrizione, con il suo linguaggio. Perché va da sé che l’arte resti una necessità dell’uomo. E va da sé che l’arte resti un enigma, come va da sé che l’arte non è morta. Così come non è morto Dio. Così come non si è ancora usciti da qualsiasi forma di assolutezza o di metafisica. Allora, facciamo nostra la domanda di Heidegger: “L’arte è ancor oggi una maniera essenziale e necessaria in cui si storicizza la verità decisiva per il nostro Esserci storico, o non lo è più”? La risposta di Heidegger è di comprendere se nell’uso dell’arte si può andare oltre l’apprensione sensibile (aísthēsis) o dell’esperienza vissuta (Erlebnis). Pertanto, se si dà possibilità di pensare l’arte in base all’essenza della verità. Ecco, la parola “chiave”, Verità. Qui, è intesa nella maniera più essenziale possibile sia da Heidegger, che gli dà il significato originario che essa ha, cioè dello Svelato, quindi di ciò che è l’essenza dell’Essere, sia da parte dei poeti qui ospitati che sembrano, ognuno alla propria maniera, – poiché non esiste nessun modo univoco di intendere la verità, sebbene se ne avverta una necessità incommensurabile – di aver accolto questa tensione verso l’essere e, quindi, verso il suo grado più essenziale che è appunto la verità.
L’umano. In ogni modo, dice Montale, sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia, una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile. Legggiamo, invece, Vicente Aleixandre: La poesia è una serie di domande che il poeta va formulando. Ogni componimento, ogni libro è una richiesta, una sollecitazione, un’interrogazione, e la risposta è tacita, ma anche progressiva, e il lettore se la dà con la lettura, attraverso il tempo. Meraviglioso dialogo in cui il poeta interroga e il lettore dà silenziosamente la sua piena risposta. O seguiamo Seamus Heaney: Do credito alla poesia per aver reso possibile questa passeggiata nello spazio. Le do subito credito per via di un verso che ho scritto di recente, in cui invitavo me stesso (e chiunque altro in ascolto) a «camminare» in aria contro ogni buon senso. Ma le do credito, in definitiva, perché la poesia sa creare un ordine tanto fedele all’impatto con la realtà esterna quanto sensibile alle leggi interiori del poeta. E, infine, leggiamo cosa scrive la Szymborska: Nei Paesi più felici, dove la dignità umana non viene lesa tanto facilmente, i poeti desiderano essere pubblicati, letti, capiti; ma ormai non fanno nulla (oppure molto poco) per distinguersi dagli altri nella vita di tutti i giorni. E pensare che fino a così poco tempo fa, nei primi decenni del nostro secolo, i poeti amavano stupire presentandosi in abiti bizzarri e modi eccentrici. Ma si trattava sempre di una sorta di esibizione pensata apposta per il pubblico: arrivava poi il momento in cui il poeta si chiudeva la porta alle spalle, si toglieva di dosso i mantelli, ninnoli e altri accessori da poeta per starsene fermo in silenzio, in attesa di se stesso, di fronte a un foglio di carta ancora tutto da scrivere. Perché alla fine è solo questo che conta davvero. Da questo minimo ascolto se ne ricava che la natura poetica è vasta e indissolubile. Che la poesia è molte cose e niente. E affronta la sua realtà con poco. La sua lingua è la vita e anche un metodo. Soprattutto è la verità, ma che se ne dilatino gli spazi, i tempi, le scritture.
È ancora possibile la poesia – Poetry Nobel Lectures, Vallecchi, pag. 315.