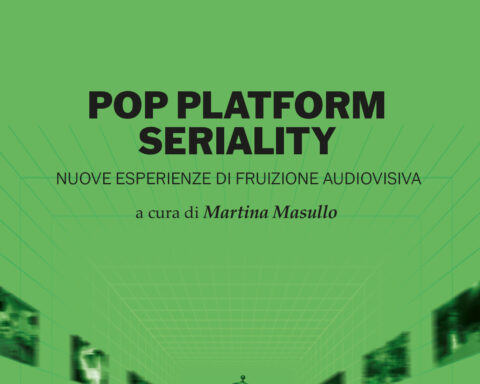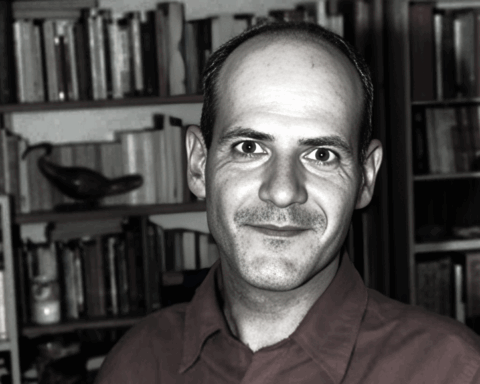Parlare oggi di cultura popolare significa avventurarsi in un territorio in continua trasformazione, dove linguaggi, pratiche e forme espressive si intrecciano con le dinamiche sociali e con l’innovazione tecnologica. “Popular Cultures: pratiche, media e tecnologie” non è soltanto un titolo, ma un invito ad aprire uno spazio di riflessione e confronto transdisciplinare sulle molteplici traiettorie del pop contemporaneo.
Riflettori puntati
su più traiettorie
Questa prospettiva prende forma in un contesto preciso. La Sezione Processi Culturali (PIC) dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) promuove un convegno di metà mandato, che si terrà a Noto (SR), il 23 e 24 ottobre prossimi, presso la sede distaccata dell’Università degli Studi di Messina gestita dal Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (C.U.M.O.). La cornice accademica sottolinea come la cultura popolare non sia solo un fenomeno diffuso e quotidiano, ma anche un oggetto di indagine scientifica di grande rilevanza per la comprensione della contemporaneità. “Questa intensa due giorni – ci ricorda Roberta Paltrinieri (Ordinaria di Sociologia dei processi culturali al DAMS di Bologna e Presidente della sezione PIC/AIS) – si propone di riflettere sulle molteplici traiettorie, forme e narrative della cultura popolare, sulle sue componenti e sugli attori che ne definiscono le configurazioni, sulle pratiche culturali, sociali e mediali che ne sono alimentate e la alimentano, sul ruolo rivestito dalle tecnologie e dal digitale, ponendosi come uno spazio di discussione e confronto transdisciplinare. In particolare, partendo dalla volontà di riflettere sui modi in cui la cultura popolare diventa un ambiente di rielaborazione e creatività (anche utopica?), l’obiettivo è quello di riunire studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori, professioniste e professionisti per discutere come la cultura popolare stia plasmando, e venga plasmata, da rappresentazioni sociali, pratiche mediali e tecnologie in continua evoluzione”.
Luoghi di egemonia
e spazi di resistenza
Come ha sottolineato Raymond Williams (1976) la cultura deve essere intesa non come un’entità statica o un insieme di prodotti finiti, ma come un “processo” vivo, in costante evoluzione, che si rinnova attraverso le continue negoziazioni sociali tra individui, gruppi e istituzioni. In questa prospettiva, la cultura non è mai data una volta per tutte, bensì costituisce un campo dinamico di forze, un terreno di tensioni e mediazioni in cui si ridefiniscono incessantemente i significati condivisi e le pratiche collettive. Muovendosi in questa direzione, Stuart Hall (1981) ha messo in evidenza con particolare lucidità la dialettica interna alla cultura popolare, evidenziando come essa rappresenti simultaneamente un luogo di egemonia (in cui si riproducono le logiche del potere e del consenso) e uno spazio di resistenza e di creatività dal basso, in cui emergono forme alternative di espressione e di identità.

Tale duplicità rende la cultura popolare un laboratorio privilegiato per comprendere le dinamiche socio-culturali contemporanee, poiché essa si configura come un crocevia di conflitti simbolici, appropriazioni e ri-significazioni. Nell’attuale scenario della digitalizzazione globale, le tensioni descritte da Hall si amplificano e si trasformano. Le piattaforme social, le industrie culturali e le comunità online generano infatti nuove economie simboliche, basate sulla circolazione di contenuti, immagini e narrazioni che ridefiniscono i confini dell’appartenenza collettiva e della partecipazione pubblica. L’interconnessione tra utenti, produttori e consumatori si traduce in un ecosistema mediale ibrido, in cui la distinzione tradizionale tra autore e pubblico tende progressivamente a dissolversi. In questo contesto, Henry Jenkins (2006), introducendo il concetto di cultura partecipativa, ha evidenziato come i pubblici non possano più essere considerati meri destinatari passivi dei prodotti culturali, ma co-creatori di contenuti e di significati, attori attivi nella costruzione dell’immaginario collettivo. Tale prospettiva apre la strada a una riflessione ampia sul ruolo delle tecnologie digitali nella ridefinizione delle relazioni tra potere, sapere e creatività, ponendo interrogativi cruciali sulle forme di produzione e di circolazione del senso nella società contemporanea.
Democratizzazione
e tecnologia pervasiva
Proprio in questa direzione si collocano le finalità del convegno, che mira a riunire studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori, professioniste e professionisti per indagare le implicazioni sociali, culturali, economiche e politiche delle nuove pratiche culturali nell’era digitale. L’intento è quello di esplorare i processi che attraversano i settori delle industrie culturali e creative, di analizzare le forme tradizionali e innovative di narrazione e produzione, nonché di discutere i nodi critici legati ai legacy media, ai media digitali e ai social media. Il dibattito, articolato in sessioni tematiche, tavole rotonde e workshop interattivi, si propone pertanto di stimolare un confronto critico e interdisciplinare sulle direzioni future delle popular cultures, ponendo attenzione tanto alle trasformazioni tecnologiche quanto alle mutazioni sociali che ne derivano In gioco vi sono, come spesso accade nei momenti di transizione culturale, opportunità e sfide. Da un lato, la possibilità di valorizzare nuove forme di creatività, partecipazione e democratizzazione culturale; dall’altro, i rischi connessi alla mercificazione dei contenuti, alla concentrazione del potere nelle piattaforme digitali e alle questioni etiche che la pervasività della tecnologia inevitabilmente solleva. Come ricordava già Edgar Morin (1962) la cultura popolare è sempre stata molto più di un semplice intrattenimento: essa rappresenta un dispositivo complesso di produzione di senso, capace di veicolare miti, archetipi e immaginari collettivi che contribuiscono a definire l’orizzonte simbolico di una società. Tale funzione appare oggi quanto mai evidente, poiché le narrazioni digitali e transmediali modellano in profondità le modalità con cui gli individui costruiscono le proprie identità, i propri valori e le proprie forme di convivenza. Nell’epoca della connessione globale e della produzione dal basso, la sfida teorica e politica consiste dunque nel comprendere come le culture partecipative e le pratiche di condivisione online stiano trasformando le logiche del potere simbolico, ridefinendo le relazioni tra cultura, tecnologia e società.6
Insomma, il convegno di metà mandato della sezione PIC dell’AIS si configura non solo come un importante momento accademico, ma ci piace pensarlo anche come un decisivo laboratorio di pensiero critico e collettivo, uno spazio in cui analizzare il pop nelle sue stratificazioni culturali e nei suoi paradossi, senza ridurlo a semplice spettacolo. Analizzare la cultura popolare significa, in fondo, guardare dentro di noi: nei nostri desideri, nelle nostre paure e nelle possibilità (talvolta ancora inesplorate) di reinventare il mondo che abitiamo.