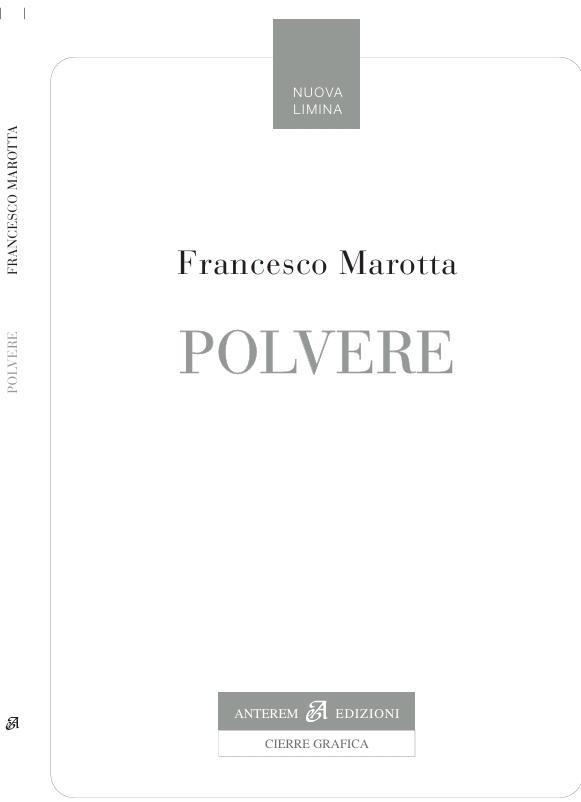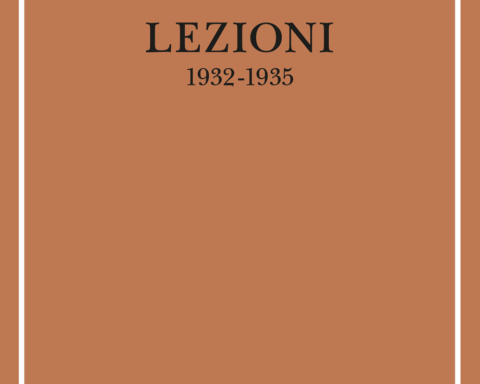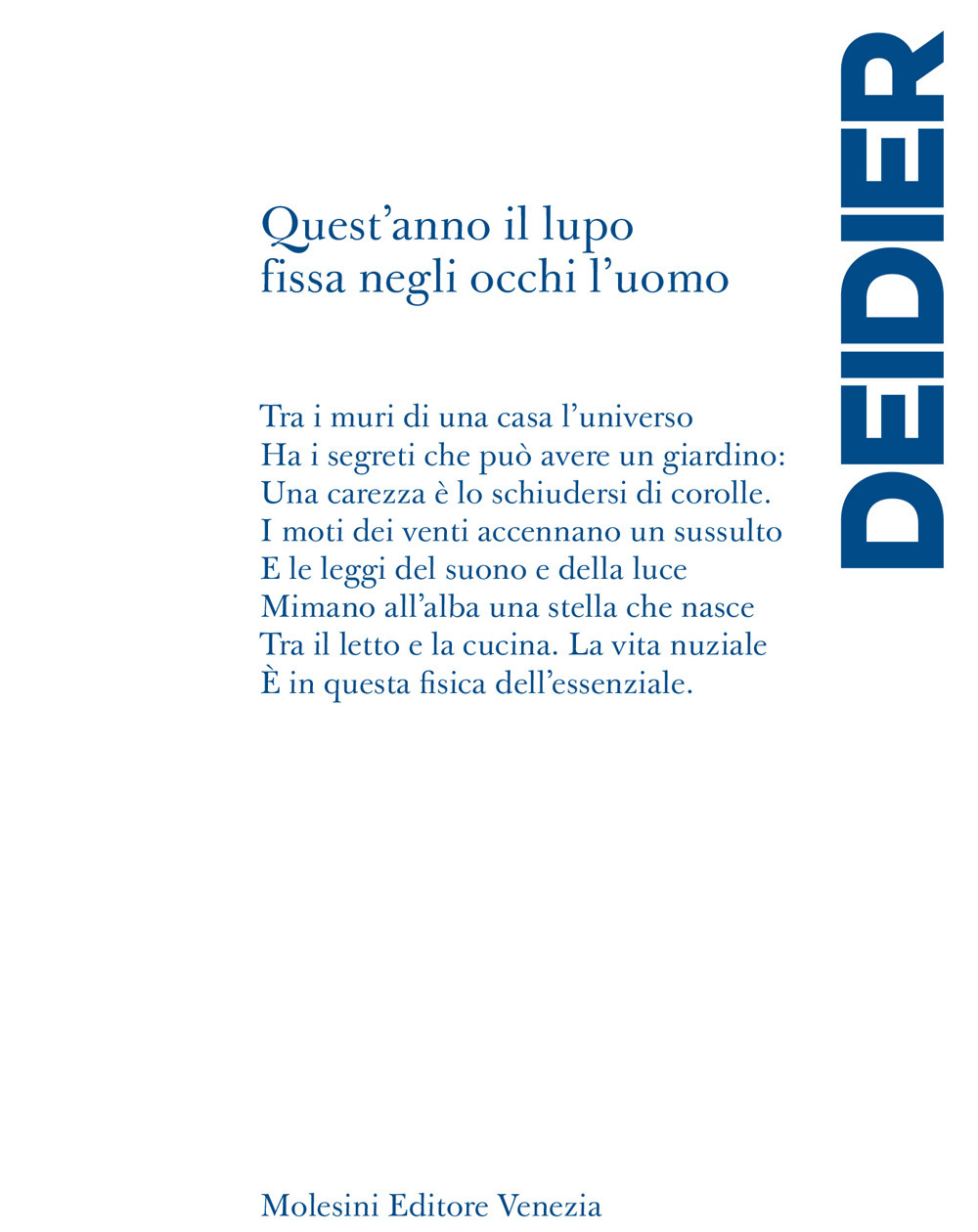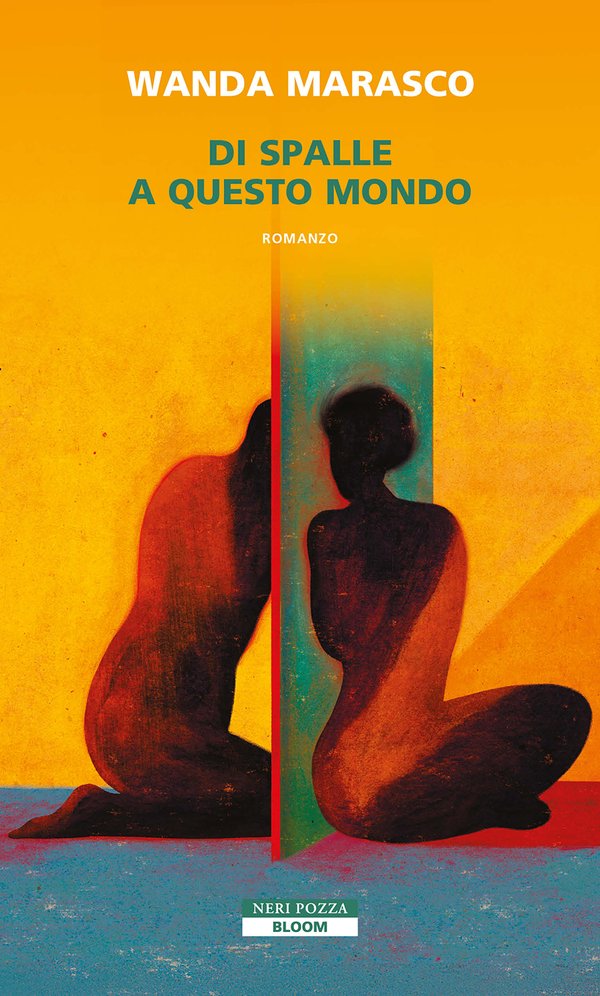non aspetta nessuno
(non di-meno)
schiude le labbra, mostra la lingua (si-
dimena), si
arresta alla porta, cioè, si
cerca, si aspetta, aspetta (volto
d’attesa): fiuta
il fiato
rifiata in un volo
ricade
(la casa crolla)
Si tratta un frammento di Francesco Marotta, tratto da Polvere, Anterem, pag. 49. Il libro è diviso in cinque parti da effimere, transitorie, fragili ma possenti spaziature che legano il libro con un nodo invisibile fatto di torsioni e strapiombi. Ne elenco i titoli per dare all’espressione una minima compattezza. Miniera (mini -era). Controluce (contro -luce). Altroquando (altro -quando) a Evgen Bavčar. Obliquamente (obliqua –mente) a Mario Giacomelli. Nottetempo (notte –tempo). – È da rilevare la presenza di due fotografi ma, magari, si tornerà a loro più avanti. – Intanto, si vaga, si trasmigra, si procede nell’essenza e nell’assenza di parole che hanno un piede in terra e l’altro in una lingua irrefrenabile e corrosa. Laura Caccia che cura l’ala finale della raccolta scrive di una lalangue lacaniana e di una decostruzione derridiana, ma ha soprattutto ragione quando parla di una lingua rizomatica. La capacità, infatti, di attraversamento, d’infiltrazione e di espansione, e perché no, di allontanamento (capacità di distanziarsi e di elevarsi) del linguaggio di Marotta è pregevole di una natura che fa dell’artificio retorico, paronomasie, enjambement vertiginosi, una tecnica di lenta agonia della parola. Una parola che danza nel vuoto o in equilibrio d’instabilità. Imprevedibile e senza rotta. Una polvere sbattuta di qua e di là. O una cenere sedimentata nella memoria del fuoco. O della luce.
La parola di Marotta si concede al dicibile come al suo opposto indecidibile e ineffabile. Visibile e invisibile. Dentro e fuori. Fino alla fine della parola. Heinrich Heine, un grande poeta tedesco d’inizio Ottocento scriveva che quando le parole finiscono, inizia la musica. La poesia, allora! La deriva di un segno cruciale quanto abissale. “(non/coglie l’occhio/che scruta – discute/la scena/l’enigma) / un segno che a tratti/piove sguardi/in colonna – fiaccole/incendi/in stasi, e –stasi. Ontologia e misticismo s’incontrano come residuo di senso di una melodia impalpabile quanto rumorosa. Polvere è anche divinità che si annuncia come una sequenza distorta di luce e ombra. Di silenzio e fragore. E nella densità di una parola che arretra per avanzare. Nessuna tensione memorabile. Solo ciò che si manifesta nell’evidenza di un’immediata presenza: luce ontica che distilla un oltre che non è al di là, ma di fronte e in attesa di essere nominato. “quale altra luce – Evgen/nel senza tempo del/le pupille spente, quale/l’origine, il suono, la voce/l’alfabeto – quale il nome/segreto delle rondini/che liberi dal sogno/per scardinare il portale/delle ombre – quale/altra luce, quale altro nome sai/che il giorno non conosce?” Un incedere interrogante, quello di Marotta, che persegue nel suo istinto poetico di una poesia indifferente a una comunicazione, a una seduzione di senso, ma libera nel proporre una partitura di densità, un’esperienza osmotica di ascolto. Pochi movimenti quelli Marotta. I testi sono rappresi o impagliati, tuttavia ben calibrati in accordi di parole semplici ma efficaci di un domandare o di un asserire senza scampo. “(la pagina in-forme/non si dovrebbe dire/chi parla del vuoto/rinuncia/a ogni morte”. Senza dubbio, ci troviamo dinanzi scritti di altissima tensione. Più che la stratificazione della storia che nella polvere fa decantare l’essenza per intravederne l’origine, o la luce incustodita, il testo del poeta come parole di “corpi socchiusi, dis-schiusi” si fa evento. Qui il passaggio del linguaggio sembra rimandare a un percorrere essenzialmente in uscita da una possibilità metafisica. Nessuna più possibilità, nemmeno la luce. Soltanto evento. Tempo intimo e presente. Dispiegamento di una condizione abissale: “nascere/incontro alla luce/e fiorendo/fiorire/sfiorire”. La complessità filosofica di questo lavoro di Marotta azzera la distanza ed esita nel varco di un gioco immobile di sapienza e fattualità. L’evento è approdo di natura semplice. È il rimando heideggeriano al vicino e all’unico, qui nel senso del semplice e del personale, non dell’eccezionalità. Ciò, almeno, nella mia traslazione sia del filosofo tedesco sia di Marotta. Sta di fatto, che l’uso della parola “evento” ricorre più volte in Polvere, sia come orizzonte o immagine di vertigine sia come accenno di chiarificazione e di esperienza. Una filosofia dell’evento si fa poesia dell’evento, in un corto circuito che ha un ordito di tremore e di regole di attesa. Una lingua altra. Una luce altra. Un nome altro. Siamo alla rifondazione di una lingua, di un linguaggio che vorrebbe eludersi ad altezza di un dire che vuole rinnegarsi quanto procedere per una dimora semplice, ma senza luogo né tempo. È la poesia? È il fineluce? È finalmente una sapienza per clamorosi segnali di voce? Tutto vacilla. La poesia non lascia impronte, si sedimenta. Questo bellissimo libro di parole è un’immagine fuori fuoco che trova nel resto (nel disastro assoluto) dei residui di voce e dei fermagli di cura. Tuttavia la poesia non è soltanto tempo e voce, attenzione o premura ma misura di un inizio, di un’origine a venire, di un “evento in trascorso, senza scia”.
Letta in termini fotografici si risalirebbe alla luce, ma non per darne un’immagine ma un ritorno, una distanza, una lacerazione. Di ciò che resta inudibile e impercettibile, è solo il gioco della domanda, della parola, o dell’ombra. L’oscuro resta oscuro, anche se in apparenza si stempera. E il visibile lascia una traccia. Il linguaggio di Marotta è ostico, ma è il solo possibile per chi voglia provare a sentire e avvertirsi sul punto di svanire. Disciplina e arcano. La poesia ha molte velature. Non basta l’altezza della luce né una scala a strapiombo. L’inizio resta sempre immobile.
Francesco Marotta, Polvere, Anterem, pag. 59
Francesco Marotta è nato a Nocera Inferiore (SA) l’11 marzo 1954. Ha compiuto studi classici e si è laureato in Filosofia e in Lettere Moderne. Ha tradotto Bachmann, Bonnefoy, Char, Celan, Jabès, Sachs. Ha pubblicato: Le guide del tramonto (1986), Memoria delle meridiane (1988), Giorni come pietre (1989), Alfabeti d’esilio (1990), Impronte sull’acqua (2008), Esilio di voci (2011), Hairesis (2016), Il poema ininterrotto (antologia a cura di Marco Ercolani).