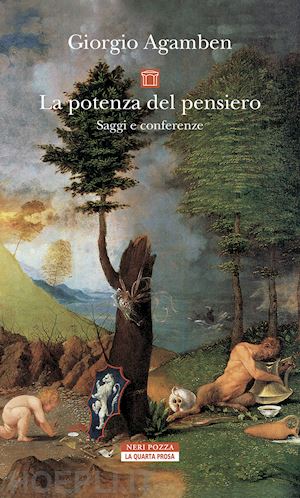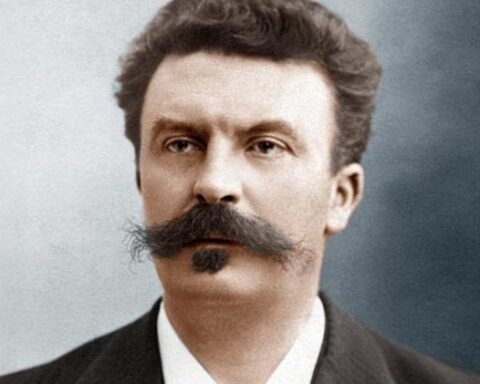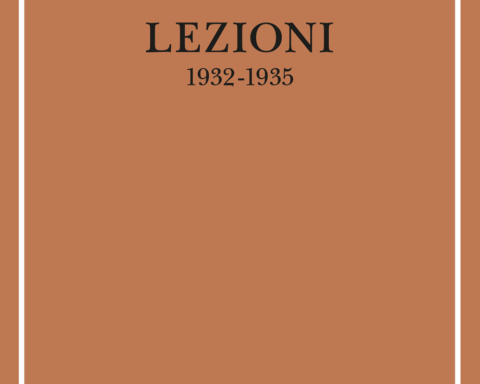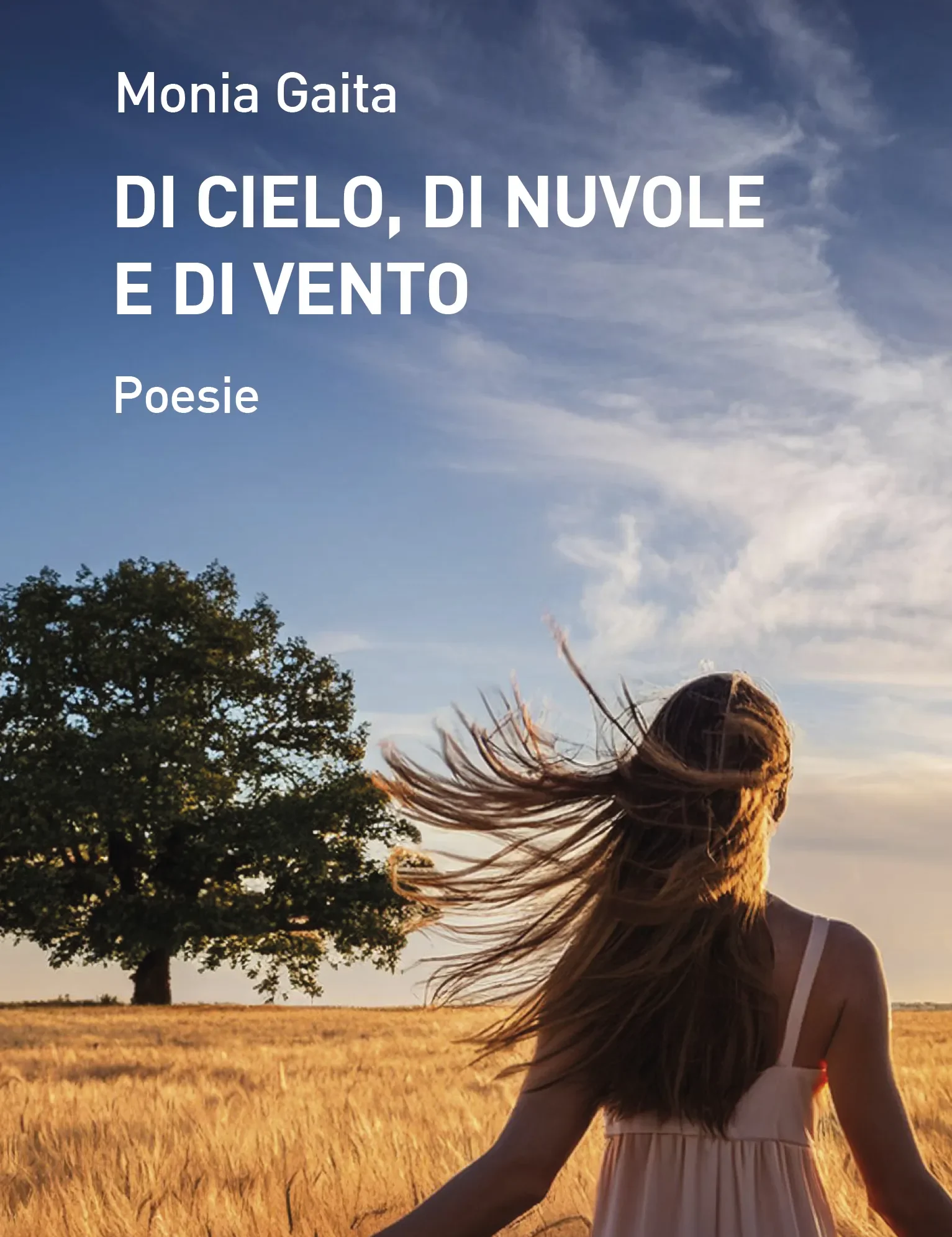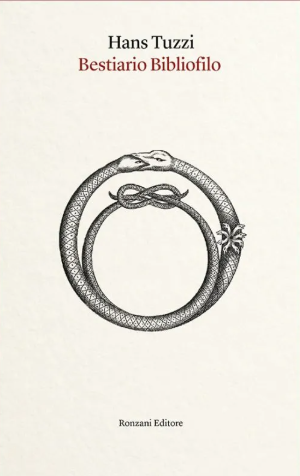Il concetto di potenza ha nella filosofia occidentale, una lunga storia e, almeno a partire da Aristotele, occupa in essa un posto centrale. Aristotele oppone – e, insieme, lega – la potenza (dynamis) all’atto (energeia) e questa opposizione, che traversa tanto la sua metafisica che la sua fisica, è stata da lui trasmessa in eredità prima alla filosofia e poi alla scienza medioevale e moderna. Se ho scelto di parlarvi qui e oggi del concetto di potenza, ciò è perché il mio scopo non è semplicemente storiografico. Non si tratta, per me, di ridare attualità a categorie filosofiche da tempo cadute in oblio; […]. Piuttosto seguendo il consiglio di Wittgenstein, secondo il quale i problemi filosofici diventano più chiari se li formuliamo come domande sul significato delle parole, potrei enunciare il tema della mia ricerca come un tentativo di comprendere il significato del sintagma “io posso”. Che cosa intendiamo quanto diciamo: “Io posso, io non posso”? Giorgio Agamben, La potenza del pensiero, Saggi e conferenze, Neri Pozza, pag. 387.
Il passo è tratto da una conferenza (inedita) che Agamben tenne a Lisbona nel 1987 ora riportata in questa raccolta di saggi, per lo più sparsi e introvabili, che lo stesso autore mette insieme coprendo un periodo che va dal 1980 fino ad oggi. Ordinati in tre sezioni distinte (Linguaggio, Storia, Potenza), i diversi motivi del suo pensiero ruotano ostinatamente intorno a un unico centro, che il titolo compendia nella formula: la potenza del pensiero. Testi che testimoniano una riflessione ininterrotta sull’uomo e su ciò che è, sempre in maniera irrevocabile, il suo compito di dover decidere e scegliere. Il suo assegnarsi, quindi, alla felicità e alla politica in quella dimensione in cui sono in gioco il suo essere e il suo esser-ci, per usare una scrittura heideggeriana che pur tanto ha agito sulla formazione di Agamben, pensatore quanto mai unico e rilevante sennonché sempre incautamente presente e tonificante. Ovviamente, i temi trattati seppur ridotti a tre nodali capitoli sono ampi e ne sarebbe larga anche una descrizione sommaria, tuttavia mi pare che la riflessione o la domanda su che cosa sia o possa essere quella facoltà che decide del potere di fare o di non fare, mi pare di un interesse notevole, anche per l’abilità del linguaggio di adattarsi ai tempi. E quelli non facili di ogni contemporaneità ci inducono, forse, a una riflessione più urgente o più immediata circa il senso di un agire che, di là di tutto, è sempre controverso e divisivo. Tornando a una dimensione teoretica ontologica, ma che tuttavia ha nella contingenza un forte attacco, l’assunto cui giunge il filosofo sembra di rilevante portata. La potenza, scrive Agamben, dopo un’analisi accurata che parte dalla coppia aristotelica di dynamis-energeia, potenza e atto, è la hexis di una sterèsis, la facoltà di una privazione. Nella Metafisica di Aristotele si legge che il “potente è tale perché ha qualcosa, a volte perché ne manca.”
La potenza allora, aggiunge Agamben, è cioè definita essenzialmente dalla possibilità del suo non-esercizio. In questione, quindi, appare essere il modo di essere della potenza. La potenza può decidere di se stessa se essere esercitata o non esserlo. Potenza e impotenza. Ciò che può essere può tanto essere che non essere. Cioè il vero potente può decidere se esercitare la sua facoltà di privazione, in altre parole di non essere potente. La potenza del pensiero, se ne deduce, sta nella sua facoltà di dover decidere la sua impotenza. È potente, scrive Aristotele, ciò per il quale, se avviene l’atto di cui è detto avere la potenza, nulla sarà d’impotente. In un tempo dove il potere è ostentato nella sua forma più becera di potenza, Agamben sembra riattualizzare una riflessione più mediata e meditata di ciò che potrebbe essere veramente il potere. Certo, la consapevolezza di avere la facoltà di non esercitare una forza può assumere un aspetto ambiguo e paradossale, e anche una determinazione a non decidere, che sarebbe uguale a una forma d’impotenza, quindi di potere. Potenza, allora, è anche esercitare il proprio diritto di non pensare il pensiero? Il diritto di non essere? La facoltà di una negazione? Eppure, se ciò è possibile, non è forse la più alta espressione di potenza? Figura compiuta della potenza. Dono che la potenza fa a se stessa e all’uomo. Il saggio La cosa stessa, ad apertura di questa voluminosa raccolta – che invito a leggere sia per la rilevanza dei contenuti sia per le originali tesi speculative – verte sul linguaggio. Qui entra in gioco Platone. La sua svolta finale in senso mistico, come pare sostenga anche Giorgio Colli nel suo Physis Krypthestai Philei prendendo spunto come fa anche Agamben dalla Settima lettera di Platone. Epistola che pare abbia perso del tutto la considerazione di essere giudicata spuria. Lo scenario della lettera è noto: Platone, ormai vecchio, si racconta in prima persona e rievoca per gli amici i suoi incontri con Dionigi e l’avventuroso fallimento dei suoi tentativi politici siciliani. Dionigi è il tiranno di Siracusa, la più potente delle città siciliote. Ma veniamo al punto d’interesse che tratta della natura del linguaggio e dei suoi sviluppi in termini filosofici. L’espressione “la cosa stessa”, to pragma auto, compare per la prima volta in questa famosa e controversa lettera; e pare che Platone voglia dire che proprio questa “cosa”, la conoscenza di questa “cosa” fa la differenza tra chi pensa di essere filosofo e chi in realtà lo è. D’altra parte è il suo metodo per capire le vere intenzioni del tiranno Dionigi. Per ciascuno degli enti, scrive Platone, vi sono tre, attraverso i quali è necessario che si generi la scienza, quarta è la scienza stessa, quinto si deve porre quello stesso che è conoscibile e che è veramente. Il primo è il nome, secondo il discorso definitorio (logos, terza è l’immagine (eidòlon), quarta è la scienza. Se vuoi intendere quel che dico, prendi un esempio, e pensa così intorno a ogni cosa. Come si comprende il problema è il quinto che come suggerisce Agamben non è l’idea che sta fuori o oltre le cose, come per troppo tempo è stato interpretato ma l’oltre che sta in ogni linguaggio e dentro il linguaggio, quasi una peculiarità del linguaggio stesso di essere manchevole. “Il monito che Platone affida all’idea è allora che la dicibilità stessa resta non detta in ciò che si dice di ciò su cui si dice, che la conoscibilità stessa va perduta in ciò che si conosce di ciò che è da conoscere.” La cosa stessa, a questo punto, non è una cosa, scrive Agamben, ma la stessa dicibilità, la stessa apertura, che è in questione nel linguaggio, che è il linguaggio, e che nel linguaggio costantemente supponiamo e dimentichiamo, forse perché essa stessa è, nel suo intimo, oblio e abbandono di sé. Rendere alla cosa stessa il suo luogo nel linguaggio, scrive il filosofo, e, insieme, restituire la scrittura alla sua difficoltà, al suo compito poetico nella stesura – questo è il compito della filosofia che viene. Mi piace ricordare a conclusione di questa mia estrema sintesi, ho preso in considerazione, e a sommi capi, soltanto un saggio e una conferenza, – vi assicuro che il libro tutto è di pregevole interesse – un testo di Agamben di qualche anno fa dal titolo Quando la casa brucia. E dove in quarta di copertina è riportata questa frase. “Tutto quello che faccio non ha senso se la casa brucia.” Per dire, forse, che la filosofia, il pensiero è tale soltanto se fa esperienza della sua voce divina o naturale che sia o dei limiti del suo e di ogni linguaggio.
Giorgio Agamben, La potenza del pensiero, Saggi e conferenze, Neri Pozza, pag. 387