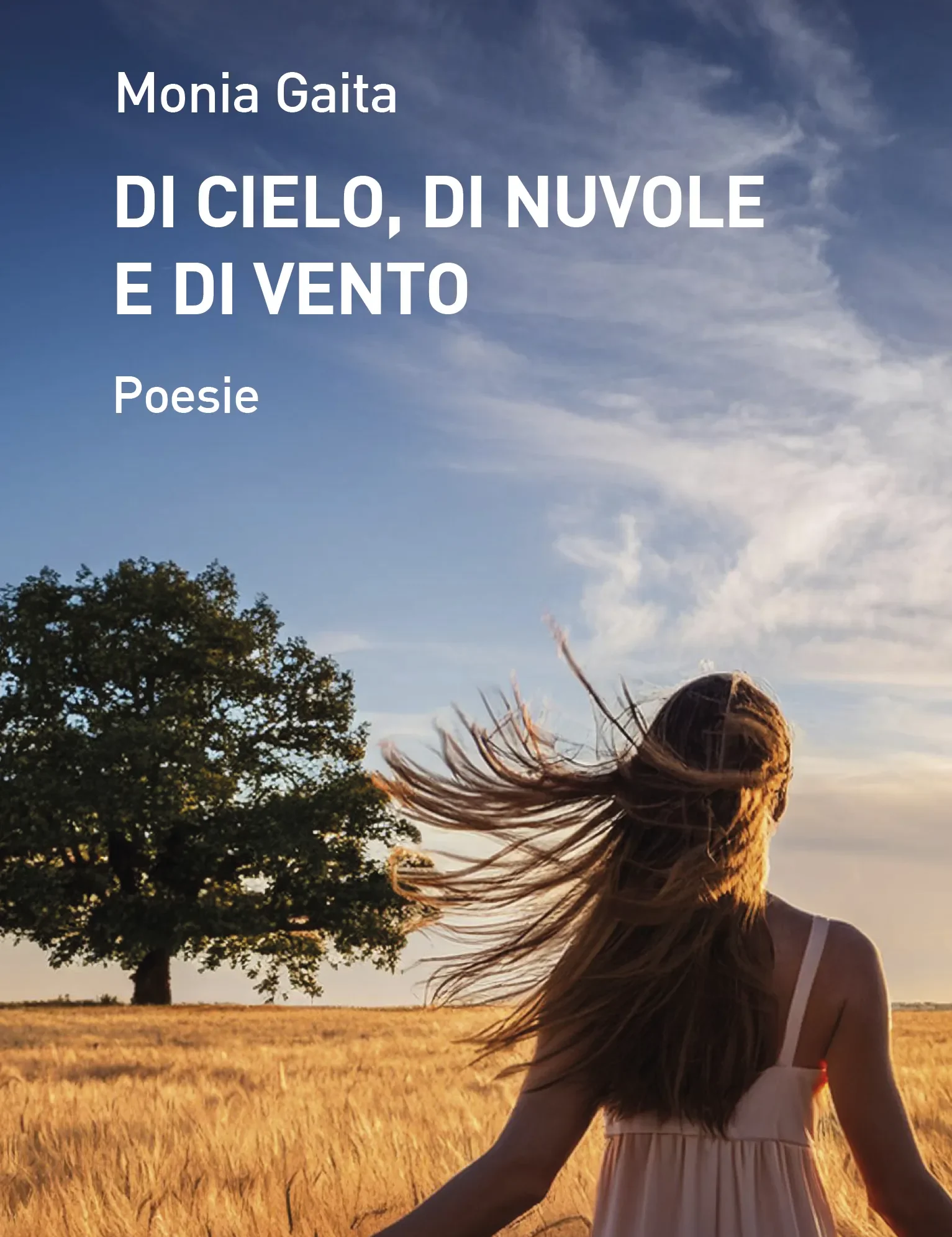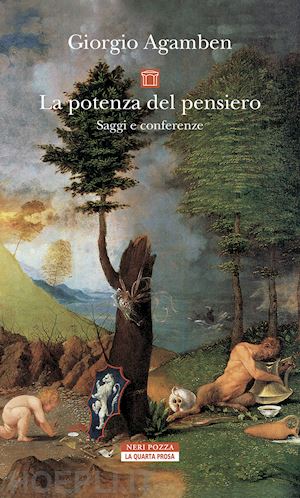È scuro e rovinoso, irredimibile e cupamente insaziato il teatro della parola di Monia Gaita. Da Rimandi (2006) a Ferroluna (2002) a Chiave di volta (2003), da Falsomagro (2008) a Moniaspina (2010) a Madre terra (2015) a Non ho mai finto (2021), la sua poesia si è sempre mossa, con rovente premura, tra contenzione e agitazione, sempre giungendo a risultati di lacuale ed enigmatica profondità meditativa.

Il suo ultimo libro, Di cielo, di nuvole e di vento (Iride, 2024) è un esteso fiume poematico attraversato da fantasime, lampi, combustioni di densissima e acuminata tensione drammatica che mostra, al lettore, una inquieta e squarciante visione della stessa sostanza della lingua poetica: non già, per fortuna, consolante e carezzevole strumento diaristico, o compiaciuta o vanesia deposizione egolatrica, ma autentica significazione di una pura risonanza, di una estrema devozione, di un’aspra e assoluta dimostrazione testimoniale tanto viva (e tanto poco rettorica e letteraria) quanto violentemente limpida e diretta. Di rado, oggi, si può leggere, in poesia, una scrittura così febbrile e fervorosa, per non dire furiosa nella sua forte e compiuta decisione; e lucidamente spietata nel suo mortale e inclemente disinganno; e tutta, senza requie, dolorosa nel suo infinito precipitare, nel suo vertiginoso e infrenabile cadere entro la rete della morte dei sogni che sempre appaiono, alla poetessa irpina, fatali e abrasi (e anche, infine, del tutto privi di una finale buonamano, di una possibile azzurra ricucitura). È l’oscuro registro di un collasso, questo libro; è la rilevazione di un sisma immedicabile che preme e assilla il dilabente e devastato sguardo del poeta: ché tutto brucia e non si placa nel suo affannoso dire, nel suo franare dissipante: «È nostra la traccia di sangue / sopra il ramo. / Ci sono segni di lotta ai piedi dei nocciòli, / insetti e vermi di cui i genitori biologici / trascurano il cammino. / Si resta soli / nel meccanismo implacabile del divenire / che non conosce remissione. / A benedire la vittima e il carnefice / lo stesso Dio, la stessa mano cieca».
Lacerato da una perpetua fenditura, il tenue splendore dell’utopia si affida, così, alla dolcezza di una resa che ha il respiro di un’oggettiva risoluzione, finalmente dirigendosi nel solco di un imprevisto rinnovamento, ora capace di trasformare il proprio individualismo nell’eco assorta di una preghiera laica, pronta all’accettazione dell’ineluttabile e del non ricomponibile: «Cosa il destino ci ha dato in sorte? / La concomitanza della vita con la morte».