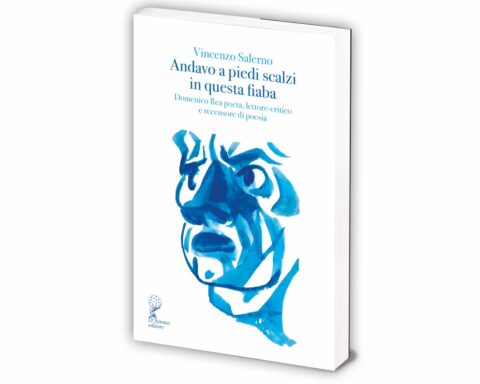La presenza di numerose figure istituzionali e culturali — dal Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Carmine Pinto; dalla dirigente del liceo “T. L. Caro”, Emma Tortora, all’editore Francesco D’Amato, fino a Lucia Rea, presidente del Centro di Ricerca “Domenico Rea” — ha conferito all’evento una dimensione corale, segnalando come l’eredità dello scrittore continui a esercitare una viva capacità di interrogazione sul presente. Lucia Rea ha ricordato il lungo lavoro del centenario e la donazione delle carte paterne alla Biblioteca “E. R. Caianiello”, ribadendo il valore dell’archivio come luogo di memoria dinamica. Su questo sfondo, il volume di Salerno si impone come un contributo filologico che rende intellegibile un segmento significativo, finora mai esplorato, della produzione poetica reaiana.
A impreziosire il confronto, le letture curate dalle studentesse della prof.ssa Medugno (Liceo “T.L. Caro”) hanno proposto un attraversamento vivo e partecipe dei testi, restituendo la dimensione più immediata e incarnata della voce poetica di Rea. Gli interventi dei professori Rosa Giulio e Alberto Granese (DipSum) hanno delineato coordinate fondamentali per penetrare la complessità della poesia di Rea, evidenziando come gli inediti e i materiali recuperati non si limitino ad ampliare il corpus, ma inducano una riconsiderazione critica della funzione stessa della poesia nella sua opera.
In questo contesto, il lavoro dell’autore sarnese si trasforma in occasione ermeneutica: la scrittura poetica non è più semplice veicolo di senso, ma spazio di tensione interpretativa, in cui la realtà viene modellata attraverso un linguaggio attentamente calibrato, consapevole della sua intrinseca problematicità e della necessità di interrogare il lettore.

Il Professore Granese ha situato questa produzione all’interno di una genealogia intellettuale che comprende Iovino, Di Giacomo e Giancarlo Grosso. Da Iovino, Rea eredita una concezione del sacro come apertura all’alterità del poetico; da Di Giacomo, il dialetto assume non più il ruolo di mera coloritura locale, ma diventa dispositivo attraverso cui sondare la sostanza carnale e sociale dell’esperienza; da Grosso, infine, emerge una capacità di dialogo con le altre arti, che trasforma la poesia in un vero evento, accadimento formale e concettuale in grado di trascendere i confini della rappresentazione convenzionale.
Si intravede così una tensione sottile tra l’eredità culturale e la capacità di Rea di rinnovarla, come se la poesia fosse costantemente chiamata a misurarsi con le condizioni etiche e percettive del presente.

Particolarmente significativa è la riflessione sulla poesia civile, ricollegata ai modelli novecenteschi e culminante nel testo dedicato alla strage di Bologna del 1980. L’epicedio non è semplice commemorazione, ma dispositivo critico che permette all’autore di confrontarsi con il trauma storico mediante una forma tradizionale rielaborata alla luce delle contraddizioni contemporanee.
La figura di Helen, straniera che giunge in Italia attratta da un immaginario di luce e trova, invece, la zona d’ombra del Paese, diventa simbolo della frattura tra utopia e realtà. In questa tensione, l’atto poetico si carica di responsabilità etica: l’epicedio non tace, non consolida, ma interroga, costringendo il lettore a confrontarsi con il presente. In tal senso, la poesia di Rea, pur radicata nel contesto storico e geografico del Mezzogiorno, si apre a una dimensione universale, capace di dialogare con i grandi problemi del nostro tempo e di rivelarne l’attualità inattesa. Iniziative come questa, che si irradiano sul territorio, contribuiscono a costruire quel senso civico fondamentale che le istituzioni sono tenute a completare, dimostrando come cultura e comunità possano generare spazi condivisi di responsabilità e consapevolezza.
In un tempo in cui la letteratura rischia spesso di essere relegata a superficie, il lavoro di Salerno e la rinnovata attenzione verso l’opera poetica di Domenico Rea mostrano come la parola, quando assunta con consapevolezza critica, possa ancora farsi luogo di verità. La poesia di Rea — emersa dal silenzio degli archivi e ricollocata nella sua trama di relazioni, ferite e responsabilità — non ci consegna soltanto un autore da studiare, ma un metodo per abitare il reale: guardarlo senza infingimenti, restituirlo senza compiacimenti, assumerlo nella sua irriducibile complessità. La presentazione del volume ha evidenziato che questa voce, lungi dall’appartenere al passato, continua a interrogare il presente con una forza inattesa.
Nel gesto di riportare alla luce i suoi versi, la comunità accademica e civile ha compiuto qualcosa di più di un omaggio: ha riaffermato il ruolo della poesia come spazio in cui la storia diventa esperienza condivisa, e la memoria materia viva del futuro. In questo senso, la poesia di Rea non torna semplicemente ad essere letta: torna ad accadere.