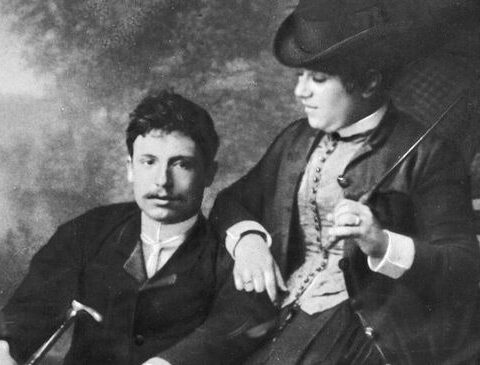La recente scomparsa di Goffredo Fofi ha incentivato sulla stampa un’ingente quanto doverosa mole di necrologi, analisi critiche e memorie, a cominciare dai fervidi e puntuali articoli scritti dai colleghi di “Il Mattino”. La straordinaria biografia dell’educatore, scrittore, animatore culturale, saggista e critico eugubino è stato altresì già rievocata dai tanti che, a torto o a ragione, si sono espressi in qualità di ex discepoli e dunque il sottoscritto non ha la minima tentazione di attribuirsi un ruolo esclusivo o privilegiato. Soltanto, però, per portare un contributo alla ricostruzione di una personalità così rilevante e complessa, desidero aggiungere qualche nota a margine motivata dal breve, ma intenso periodo in cui l’ho conosciuto e frequentato in veste di maestro, amico e sponsor dei primi approcci professionali. Infatti, com’è stato ricordato, Goffredo arrivò a Napoli all’inizio degli anni Settanta per partecipare alla rivoluzionaria esperienza della Mensa dei bambini proletari e su di noi giovani fluttuanti nei frastagliati gorghi della sinistra extraparlamentare s’impose subito come figura carismatica, suadente e onnisciente, volentieri in controtendenza alla catechesi gauchiste e provocatorio intellettuale demolitore di intellettuali. Nei miei confronti, in particolare, esercitava un’irresistibile attrazione a causa di una delle sue identità, quella di appassionato cinefilo che si stava trasformando rapidamente nello storico e critico del cinema affermato su cui ritornerò perché mi sembra minimizzata dalle prime commemorazioni.
Siccome la trasferta napoletana seguiva il soggiorno a Parigi, nel corso del quale aveva partecipato da protagonista all’avvento dei ‘giovani turchi’ della nuova critica e alle loro disinibite agguerrite campagne per il cinema-cinema svincolato dalle decrepite pastoie “d’arte e d’essai”, volle che lo raggiungessi qualche pomeriggio nell’appartamento affittato a via Tarsia per aiutarlo ad aprire gli scatoloni pieni di libri e metterli a posto negli scaffali di una spartana libreria. Potevo, così, non solo maneggiare mitiche monografie e riviste da noi ancora ignote o inaccessibili, ma addirittura ricevere a mo’ di compenso preziosi doppioni contrassegnati dalla sua sigla che ancora posseggo. Aggiungo che mentre è stato ampiamente descritto il contrasto tra l’abitudine di sommergere di vituperi coloro che dissentivano dalle sue idee e i suoi giudizi e la sconfinata gentilezza riservata nel privato a tutti noi adepti, è meno noto il vezzo del bastian contrario sperimentato con sorniona malizia anche a carico degli stessi. Per fare solo un esempio ricordo benissimo che una volta, mentre guardavamo il capodopera muto di Dreyer “La passione di Giovanna d’Arco” al “NO” di Franco Santaniello, uno dei caposaldi della cultura cinefila cittadina, un minuto dopo avere rampognato per l’indifferenza e l’insofferenza l’amico seduto al suo fianco, faceva lo stesso col sottoscritto seduto dall’altra parte per l’eccessivo entusiasmo e compiacimento. Quando lasciò Napoli, non prima d’avermi suggerito alla Feltrinelli come curatore insieme a un altro giovane emergente, Paolo Mereghetti, di un volume antologico sulla commedia all’italiana che poi non andò in porto, ci perdemmo un po’ di vista e, anzi, litigammo per la frase, ahimè insolente (“gli imperativi categorici di un contenutismo da incubo”), che mi era sfuggita a proposito delle sue recensioni nella bibliografia del mio primo libro. Ma chi non ha litigato con Goffredo tra quelli che gli hanno o a cui ha voluto bene? La sua natura indocile e libertaria, perseguita con inalterata rettitudine nel percorso politico che dalla militanza in Lotta Continua l’ha condotto a definirsi recentemente “anarchico-socialdemocratico”, gli ha in fondo permesso di praticare alla luce del sole l’insolita qualità di offendere dolcemente, erudire aspramente, ma anche di cambiare idea e fare autocritica passando in un attimo dai terribili cazziatoni all’abbraccio più caldo.
Come premesso, la peculiarità del carattere e l’estrema difficoltà d’incasellarne gli orientamenti ha fatto sì che finora si lasciasse alquanto in ombra lo storico e critico cinematografico. Una rilevante mancanza anche perché, in relazione a queste noterelle, la storica apparizione napoletana non avveniva nel segno delle adunate e le occupazioni, bensì in quello delle virulente recensioni pubblicate sui “Quaderni piacentini” (una per tutte: la stroncatura del venerato e autoriale “Zabriskie Point” di Antonioni abbinata all’elogio del piccolo, indipendente e americano “Easy Rider”) e sulla prima serie di “Ombre rosse” (1966-1970), del cui comitato di redazione era stato l’ideologo e il promotore. Il mitico trimestrale, il cui primo numero esibiva in copertina il profilo di Burt Lancaster nel ruolo di uno dei “Professionisti” dell’omonimo western di Brooks, aveva, in effetti, demolito le categorie e i metodi dell’intellighenzia cinematografica tradizionale e inaugurato una linea, non priva di giudizi settari e inevitabili cantonate, che apriva non solo alle avanguardie italiane, americane, francesi e terzomondiste, ma anche agli esponenti del cinema cosiddetto “negativo-borghese” come Bunuel, Losey e Welles e i vecchi e solidi artigiani hollywoodiani come Ford, Hawks e Walsh. La riscoperta di Totò, giustamente citata da tutti, nasce esattamente da quello spavaldo tentativo di riconoscere al cinema il ruolo specifico occupato nell’immaginario popolare – purtroppo destinato in futuro a essere sempre più oscurato dai mass-media al servizio di sé stessi – e i libri di cinema di Goffredo – esclusi quelli oggi irricevibili a causa della scomposta overdose d’invettive come Il cinema italiano. Servi e padroni ma inclusi quelli come Più stelle che in cielo. Il libro degli attori e delle attrici sui divi dell’epoca d’oro raccontati con qualche distinguo dissacrante, ma anche tanta affettuosa adesione- si sono mossi in questa direzione sino alla summa costituita dai tre volumi zeppi di dati reali, testimonianze cruciali e riscontri cronistici L’avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti scritti in collaborazione con Franca Faldini. Una delle ultime volte che ci siamo rivisti, abbiamo dato vita a un buffo siparietto che è entrato nella storia parallela della Mostra di Venezia, quella tramandata dagli habitué festivalieri al di fuori della fredda statistica dei programmi. Al termine della proiezione di “Così ridevano” di Amelio siccome il sottoscritto e il caliente collega toscano Carabba esternavamo ad alta voce un’aspra e animosa insoddisfazione, il vecchio saggio dalla barba bianca ci inseguì tra lo sconcerto generale brandendo in aria il famoso bastone. Mai minaccia può apparirmi più lieve e gradita nel raccoglimento di queste ore di vivo dolore.
(dal blog ufficiale di Valerio Caprara, per gentile concessione dell’autore)