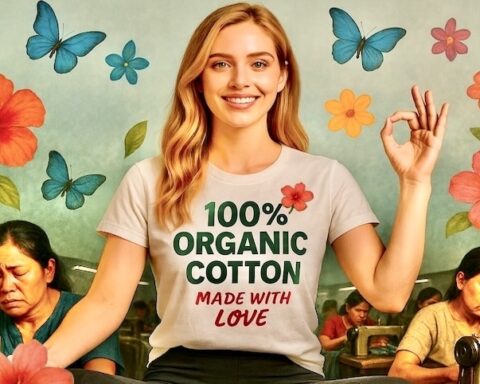Come mai quei politici che si concedono falsità, reati, collusioni con il potere economico o criminale e bugie così manifeste da essere un’offesa alle nostre intelligenze non fanno più scandalo? Domanda vecchia, ma ciclicamente ritorna come un lamento sommesso in fondo all’animo di quelle persone che hanno ancora la decenza e il pudore di turbarsi.
È la sociologia – più della cronaca e dell’opinionismo da salotto – che ci offre gli strumenti per comprendere l’origine sistemica di questa apatia: non è semplice stanchezza uditiva o cognitiva ma un vero e proprio riassetto della relazione dei cittadini tra verità e potere.
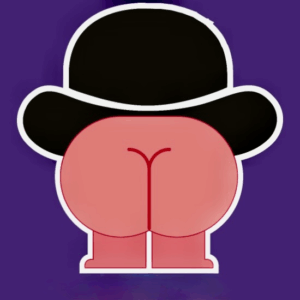 Un politico colto in fallo: evidenze di atti, amici che arricchiscono con appalti pubblici, parenti in CdA di enti, audio e video imbarazzanti, tasse e imposte non versate e addirittura un rinvio a giudizio causa solo una collaudata prassi di replica: “faccia da culo, negare ogni, far decantare tutto”; il politico resta dov’è e alle successive elezioni magari viene rieletto con più voti di prima.
Un politico colto in fallo: evidenze di atti, amici che arricchiscono con appalti pubblici, parenti in CdA di enti, audio e video imbarazzanti, tasse e imposte non versate e addirittura un rinvio a giudizio causa solo una collaudata prassi di replica: “faccia da culo, negare ogni, far decantare tutto”; il politico resta dov’è e alle successive elezioni magari viene rieletto con più voti di prima.
Quel che colpisce non è la faccia suddetta del tipo, ma l’assenza di reazione collettiva, è un’anestesia morale che pone l’Italia in pieno folclore sudamericano. Non si tratta solo di disillusione politica, è proprio una mutazione sociale profonda, che la sociologia ci aiuta a comprendere. Senza scomodare politici stranieri – ci vorrebbe un’enciclopedia a fascicoli per star dietro a Trump, Milei, Maduro, Putin, etc… – i casi di mancata indignazione italiana sono centinaia:
Marcello Dell’Utri, condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ha continuato a essere considerato figura influente della politica italiana, emblema di un sistema di potere imperiale – legibus solutus – che ha reso normali e accettati illegalità e scandali delle alte sfere tra leggi ad personam, prescrizioni pilotate ed elezioni di personali escort alla Camera o Governi Regionali.
Ignazio La Russa, presidente del Senato, con familiari coinvolti in indagini penali, continua a rappresentare le istituzioni… in Gran Bretagna sarebbe bastato molto meno per dare le dimissioni.
Luca Morisi, il “guru social” della Lega, coinvolto in un’inchiesta su droga e festini omosessuali con scandalo deflagrato sui giornali… è rientrato senza conseguenze al suo posto, lo stesso Salvini l’ha riaccolto: qui è evidente l’ipocrisia sistemica: nessuno crede davvero a ciò che si dice in politica e quindi anche lo scandalo diventa marketing politico.
Daniela Santachè coinvolta in una vicenda giudiziaria per reati di bancarotta e falso in bilancio, senza contare la vergogna di stipendi non pagati e irregolarità fiscali, è ancora lì a capo di un ministero e sempre col tacco 12, indubbiamente vitale per fare il ministro alla faccia nostra.
Nel 2022 D’Alema, tirato in ballo in un’inchiesta giornalistica su una trattativa per la vendita di armi italiane alla Colombia, dove l’ex premier aveva un ruolo di intermediario con ritorni economici milionari per sé e i suoi contatti: la sinistra ha mantenuto il silenzio assoluto e l’opinione pubblica ha dimenticato il caso: la sinistra intellettuale garantisce anche una immunità reputazionale.
Mafia Capitale ha coinvolto esponenti del centrosinistra romano, in particolare legati al sistema delle cooperative sociali. Salvatore Buzzi, uno dei protagonisti dell’inchiesta, era vicino a figure del PD romano. Il PD, pur non coinvolto direttamente come partito, non ha mai aperto un vero dibattito sul tema del sistema delle clientele: E qui intervenne il sistema della rimozione collettiva.
Lo scandalo diventa solo “normalità disturbante”
Ma com’è possibile che passi tutto in cavalleria? Non è il caso di parlare di difetto di etica, faremmo ridere, una buona spiegazione sociologica potrebbe essere che tutto ciò deriva dalla tribalizzazione politica: la fedeltà al partito o al leader conta più della valutazione morale. L’individuo diventa invulnerabile se le accuse vengono trattate come complotto contro il gruppo dominante…
Viviamo immersi in uno scandalo strisciante e permanente, come una malattia acuta che diventa cronica. Già negli anni ’90, si parlava di una società in cui una notizia greve era solo un’interruzione dello spettacolo politico, e si era agli albori. L’attuale sovraesposizione produce assuefazione, saturazione: non ci si scandalizza più perché nulla sorprende e quel che non sorprende, non mobilita; quindi lo scandalo perde la sua funzione regolatrice e diventa nient’altro che normalità disturbante.
E c’è di peggio, le società democratiche si fondano sulla fiducia sistemica. Non potendo verificare tutto, ci affidiamo alle istituzioni affinché garantiscano trasparenza e regole. Quando la fiducia crolla, e la Seconda Repubblica ne ha causato di crolli!, non resta più alcun presidio e si entra nel loop del “tutti rubano, allora meglio uno che ruba ma fa cose”, che poi le faccia è tutto da vedere.
Il paradosso sociologico è che più aumenta la sfiducia, più si rafforza l’adesione intorno a figuri che – anche se compromessi – sembrano carismatici perché parlano alla pancia. Perché la vera novità è che non si vota più per convinzioni ideali ma per tifo politico o per rassegnazione.
Dall’indignazione all’invidia
Il potere riesce a farsi accettare anche quando è visibilmente iniquo, perché impone i suoi criteri di legittimità. In questo schema, il politico corrotto o bugiardo non viene più percepito come colpevole ma come sagace, astuto. L’elettore medio, bombardato da messaggi di successo, efficienza, cinismo, finisce per identificarsi con il trasgressore, non col moralista. La figura del ladro di Stato smette di fare scandalo e diventa modello. Insomma la colpa, l’illecito, si trasforma in aspirazione e invidia.
È la morte della vergogna pubblica. Oggi la strategia prevalente è negare, negare l’innegabile per poi destabilizzare e delegittimare con dossier chi denuncia e puntare alla decantazione. Ed è una strategia che funziona, perché la vergogna pubblica – come regolatore sociale – non esiste più.
La società si dovrebbe tenere insieme grazie alla capacità di sanzionare chi devia da norme condivise. Ma queste norme per tutti gli anni ’90 e gli inizi del 2000 sono state smantellate, non c’è deterrenza morale e neanche culturale, basta essere fedeli e allineati per far parte del gruppo di potere.
I nuovi cicli di dimenticanza: l’oblio funzionale
Zygmunt Bauman, sociologo polacco, parlava della modernità liquida, in cui tutto scorre troppo rapidamente per essere ricordato. In questa logica anche la memoria si liquefa, gli scandali passano e con essi le responsabilità. Ciò che resta è un presente solubile, fatto di eventi senza conseguenze e memoria… e in assenza di memoria, la ripetizione di un comportamento improprio non si accumula a quelli del passato ma crea solo nuovi cicli di dimenticanza nella coscienza civica.
La buona notizia è che la Storia ci insegna che nulla è eterno e che le problematiche di assuefazione non sono una condizione irreversibile. La società tornerà a scandalizzarsi, la domanda è “tra quanto tempo?”. E’ necessario ricostruire uno spazio pubblico razionale. Uno spazio in cui la verità, la responsabilità e il confronto civile non siano schiacciati dal tifo o dalla rassegnazione.
Occorre una pedagogia della memoria e della responsabilità, a partire dalla scuola, dai media, dal linguaggio che usiamo. Occorre smettere di legittimare il “così fan tutti” e iniziare a rispondere con nomi, fatti e conseguenze. Occorre ripristinare un senso condiviso della vergogna, non come umiliazione personale, ma come rispetto per il bene comune.
Se oggi lo scandalo non ci scandalizza più, non è perché siamo peggiori di ieri, ma perché col tempo il sistema politico ci ha rieducati ad una tolleranza passiva, ad accettare che nessuno si vergogni, si dimetta, esibendo imperterrito quella faccia da culo per rimanere lì dove è.
Ma possiamo e dobbiamo reimparare a indignarci, perché finché continueremo a premiare chi mente, chi ruba e chi nega l’evidenza, la responsabilità non sarà solo “loro”.
Sarà anche nostra.