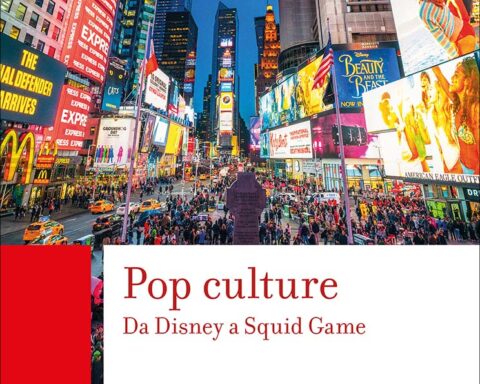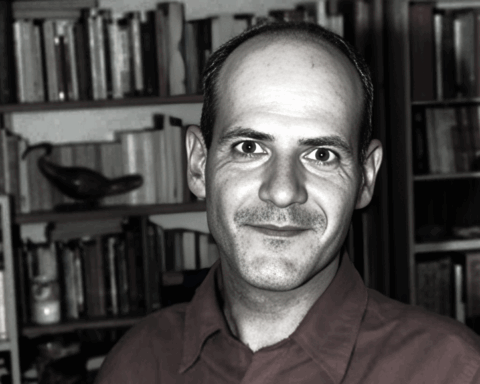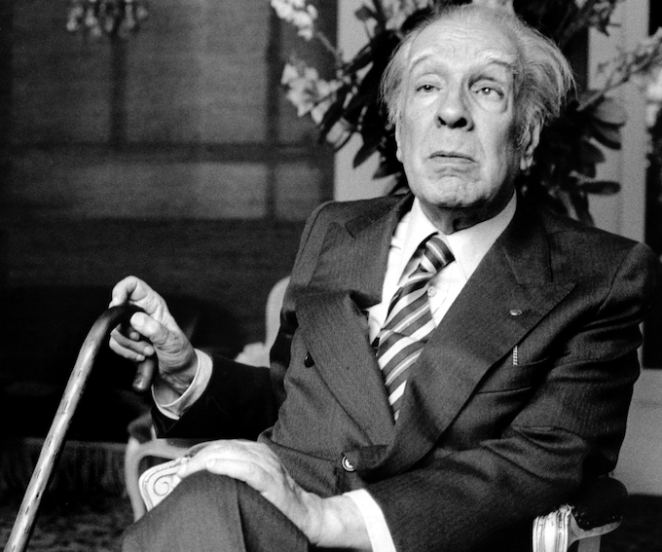Partendo dalle riflessioni sulla serialità legata al modello di produzione-consumo e di riproducibilità, questo interessante libro corale, a cura di Martina Masullo, intende raccontare le nuove prospettive culturali e sociali offerte dal processo di produzione e fruizione seriale contemporaneo nell’era delle piattaforme. Un testo che tenta, con successo, di dare una risposta alla seguente domanda: è possibile tracciare e definire un concreto e sistemico passaggio da post-serialità a pop platform seriality, che ripensa ulteriormente gli spazi della fruizione e adatta i modelli del passato alle estetiche ultra-pop della contemporaneità? Pubblichiamo qui di seguito, per gentile concessione dell’editore (Martin Eden) e degli autori la prefazione di Alfonso Amendola e l’introduzione della curatrice Martina Masullo.
Prefazione
di Alfonso Amendola
L’orizzonte e la matrice teorica
Fin dalle sue origini, la sociologia ha rivolto lo sguardo al nuovo, interrogando i processi di trasformazione che segnano la vita collettiva. Nella riflessione di autori fondativi come Auguste Comte, Émile Durkheim, Georg Simmel, Walter Benjamin, Max Weber, l’innovazione era già un concetto operativo — anche se non sempre esplicitato — utile a leggere le tensioni tra tradizione e modernità, continuità e rottura, forma e mutamento. Con l’avvento della modernità avanzata, della tarda modernità o della modernità liquida — a seconda delle etichette con cui la si voglia denominare (Beck, Giddens, Baudrillard, Bauman) — la sociologia ha dovuto dotarsi di nuovi strumenti per comprendere non solo le strutture del cambiamento, ma anche i linguaggi, gli stili e le narrazioni che accompagnano e modellano l’innovazione culturale. In una fase successiva la sociologia che indaga i temi dell’innovazione culturale nell’avanzare del Novecento ha raggiunto importanti risultati nei lavori di Edgar Morin sul cinema e la cultura di massa, di Pierre Bourdieu sulla produzione simbolica, di Raymond Williams sul concetto di “structure of feeling”, sull’immersione mediale di Marshall McLuhan e più recentemente nelle riflessioni di Scott Lash, Fredric Jameson e Angela McRobbie sulle estetiche contemporanee, le economie creative e la produzione di senso nelle società tardo-capitaliste. In questo quadro ampio e giustamente disomogeneo si inseriscono con forza e coerenza una serie di studi d’area sociologica legati all’innovazione e in particolare al capitolo della mediologia (nello specifico italiano: Abruzzese, Ragone, Colombo, Boccia Artieri, Ilardi, Ceccherelli, Fiorentino, Cristante, Brancato…).
Il volume
E proprio lungo questa lineare della mediologia si orizzonta Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva a cura di Martina Masullo. Volume corale che offre un contributo originale alla comprensione della serialità contemporanea come fenomeno sociale e culturale complesso, stratificato e in continua ridefinizione. Il libro non si limita a descrivere un “oggetto di moda” — le serie televisive, le narrazioni seriali digitali, i contenuti crossmediali — ma ne indaga con rigore le radici epistemologiche, le logiche produttive e le forme di fruizione sociale, collocandosi in una prospettiva interpretativa che unisce la sociologia della cultura, i media studies, la teoria dell’immaginario e l’analisi dei processi comunicativi. La serialità, qui, non è solo un genere narrativo, ma un dispositivo culturale che assume forme sempre più fluide e reticolari, immerse in un ecosistema che potremmo definire post-mediale (Casetti) o transmediale (Jenkins, Scolari), in cui i confini tra produttore e consumatore, tra testo e contesto, tra fiction e realtà si fanno porosi, instabili, continuamente negoziati. Recuperando l’intuizione di Allen sul racconto seriale come “procedimento narrativo aperto”, il libro rilegge le trasformazioni in atto nella produzione e nella fruizione culturale attraverso una lente che è insieme teorica e situata, in grado di cogliere i processi emergenti senza perdere di vista le strutture sociali sottostanti.
 Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva racconta pienamente il contesto attuale, segnato dalla piattaformizzazione della cultura (Poell, Nieborg, van Dijck) dove la serialità si presenta come uno degli ambiti più dinamici e fertili per comprendere come si ridefiniscono i rapporti tra pubblico e contenuto, tra potere e partecipazione, tra memoria e desiderio. Le piattaforme digitali -sembrano dirci in maniera armonica gli autori e le autrici del libro- non sono soltanto infrastrutture tecnologiche: sono ambienti sociali complessi, attraversati da logiche algoritmiche, da economie affettive (Paasonen), da forme di attenzione intermittente e da nuove modalità di storytelling iper-connesso. In questo contesto, la “pop platform seriality”— ed è incisiva e potente la definizione culturale e metodologica della Masullo— rappresenta un paradigma narrativo e culturale emergente, in grado di coniugare l’estetica ultra-pop (Reynolds) con le pratiche partecipative dell’utente-produttore (Bruns), dando vita a forme ibride di espressione e identificazione. Il volume è frutto di un progetto corale, animato dalla guida scientifica e curatoriale di Martina Masullo, che ha saputo intrecciare voci diverse, prospettive multiple, approcci teorici e metodologici eterogenei in un impianto coeso e denso. Gli autori e le autrici coinvolti (Pietro Ammaturo, Stefania Antonioni, Sergio Brancato, Alessio Ceccherelli, Antonia Cava, Marco Colacino, Vanni Codeluppi, Paola De Rosa, Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi, Fabio La Rocca, Antonio Rafele, Tito Vagni) contribuiscono ciascuno con un tassello alla costruzione di una mappa teorica e critica della serialità contemporanea (anche con preziosi “case history” di serie indagate). Le loro riflessioni si muovono tra mediologia e sociologia, tra etnografia digitale e teoria della narrazione, tra consumo culturale e costruzione di immaginari. La ricchezza del volume non sta solo nella pluralità delle voci, ma nella capacità di tenere insieme complessità teorica e attenzione empirica, radicamento nei paradigmi sociologici classici e apertura alle trasformazioni più recenti. La serialità piattaformica che emerge da queste pagine è infatti uno spazio in cui si sedimentano — e si rimettono costantemente in discussione — le tensioni tra industria culturale e pratiche partecipative, tra estetica e ideologia, tra algoritmo e desiderio, tra consumi di massa e identità generazionali.
Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva racconta pienamente il contesto attuale, segnato dalla piattaformizzazione della cultura (Poell, Nieborg, van Dijck) dove la serialità si presenta come uno degli ambiti più dinamici e fertili per comprendere come si ridefiniscono i rapporti tra pubblico e contenuto, tra potere e partecipazione, tra memoria e desiderio. Le piattaforme digitali -sembrano dirci in maniera armonica gli autori e le autrici del libro- non sono soltanto infrastrutture tecnologiche: sono ambienti sociali complessi, attraversati da logiche algoritmiche, da economie affettive (Paasonen), da forme di attenzione intermittente e da nuove modalità di storytelling iper-connesso. In questo contesto, la “pop platform seriality”— ed è incisiva e potente la definizione culturale e metodologica della Masullo— rappresenta un paradigma narrativo e culturale emergente, in grado di coniugare l’estetica ultra-pop (Reynolds) con le pratiche partecipative dell’utente-produttore (Bruns), dando vita a forme ibride di espressione e identificazione. Il volume è frutto di un progetto corale, animato dalla guida scientifica e curatoriale di Martina Masullo, che ha saputo intrecciare voci diverse, prospettive multiple, approcci teorici e metodologici eterogenei in un impianto coeso e denso. Gli autori e le autrici coinvolti (Pietro Ammaturo, Stefania Antonioni, Sergio Brancato, Alessio Ceccherelli, Antonia Cava, Marco Colacino, Vanni Codeluppi, Paola De Rosa, Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi, Fabio La Rocca, Antonio Rafele, Tito Vagni) contribuiscono ciascuno con un tassello alla costruzione di una mappa teorica e critica della serialità contemporanea (anche con preziosi “case history” di serie indagate). Le loro riflessioni si muovono tra mediologia e sociologia, tra etnografia digitale e teoria della narrazione, tra consumo culturale e costruzione di immaginari. La ricchezza del volume non sta solo nella pluralità delle voci, ma nella capacità di tenere insieme complessità teorica e attenzione empirica, radicamento nei paradigmi sociologici classici e apertura alle trasformazioni più recenti. La serialità piattaformica che emerge da queste pagine è infatti uno spazio in cui si sedimentano — e si rimettono costantemente in discussione — le tensioni tra industria culturale e pratiche partecipative, tra estetica e ideologia, tra algoritmo e desiderio, tra consumi di massa e identità generazionali.
La serialità, ci conferma questo volume curato dalla Masullo, è un luogo strategico per comprendere la contemporaneità: è archivio e laboratorio, rituale e rottura, forma del racconto e forma del sociale. Non è un caso che le nuove generazioni trovino proprio nelle narrazioni seriali — siano esse trasmesse in streaming, condivise sui social o frammentate in contenuti brevi — una chiave per costruire la propria identità, per rielaborare il passato, per immaginare futuri possibili. Il volume che il lettore ha tra le mani offre una riflessione corale e sfaccettata sulla trasformazione della serialità nell’ecosistema digitale contemporaneo, esplorando come le piattaforme abbiano ridefinito immaginari, linguaggi e modalità di fruizione propri della cultura di massa. Attraverso un mosaico di contributi, il libro affronta le traiettorie che la serialità assume oggi, intrecciando media diversi – dalla televisione al podcast, dal cinema alla pubblicità, fino alla divulgazione scientifica – e mettendo in luce le dinamiche estetiche, culturali e sociali che ne scaturiscono. I saggi qui raccolti analizzano, da prospettive complementari, fenomeni chiave della contemporaneità: la banalizzazione e spettacolarizzazione del racconto seriale, la comicità frammentata e transmediale, il riuso politico della narrazione pop, la costruzione delle identità di genere e generazionali, nonché il ruolo dei paratesti e degli ecosistemi promozionali nell’amplificare il senso delle storie. In questo contesto, la serialità emerge come spazio di sperimentazione e specchio critico del presente, capace tanto di estetizzare quanto di semplificare, tanto di innovare quanto di confermare codici già sedimentati. Il volume si interroga anche su come i contenuti scientifici e informativi vengano tradotti e resi “pop” attraverso le logiche dei social media, sull’estetica della cronaca nera nelle serie televisive e sulle pratiche di fruizione parcellizzata che caratterizzano il consumo culturale odierno. Infine, uno sguardo al rapporto tra cinema e serialità arricchisce il discorso, mostrando come queste forme continuino a contaminarsi e rigenerarsi nel tempo. Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva rappresenta così un’indagine critica e aggiornata su come la cultura seriale non solo sopravviva nel contesto delle piattaforme digitali, ma si compia e si riscriva in nuove forme ibride, transmediali e profondamente interconnesse con i mutamenti della società contemporanea. Il presente volume, dunque, non è solo una raccolta di saggi: è un esercizio collettivo di sguardo sociologico, uno strumento di indagine e interpretazione del nostro tempo. Coniugando la solidità teorica con la leggerezza del racconto, l’analisi strutturale con la cura del dettaglio, Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva ci offre un affresco lucido e coinvolgente della cultura mediale contemporanea.
Lo stile
 Ma ciò che rende questo lavoro davvero prezioso è lo sguardo dell’autrice che lo ha curato, guidato, animato: uno sguardo paziente, appassionato e “atletico”, capace di attraversare i linguaggi della complessità con la varietà della ricerca qualitativa, con la profondità dell’ascolto, con il rigore di chi sa che ogni narrazione è anche un dire politico e una forma di conoscenza. È lì, in quel momento sospeso, che ci accorgiamo che ogni sguardo lanciato sul reale è anche un gesto di racconto, un modo per cercare senso, per ascoltare il mondo parlare. E questo lavoro saggistico collettivo non si accontenta della superficie: scivola oltre, si insinua tra le pieghe delle cose, e ci lascia intravedere — con la grazia necessaria delle verità parziali — il battito sommerso delle vite che attraversano il nostro tempo. Tra le pagine di questo libro, Martina Masullo compie proprio questo gesto: ricompone frammenti, accoglie visioni e ci invita a leggere il presente non come qualcosa da spiegare, ma come qualcosa da abitare — con attenzione, con immaginazione. E non è forse questo il dono più grande della conoscenza? Non la certezza, ma la capacità di restare in ascolto. Non la presa di posizione acritica ma la volontà di leggere il presente come un testo aperto, in continua evoluzione. Non un’idea di cultura “astratta”, ma uno spazio vitale in cui ciascuno di noi è lettore, autore, complice silenzioso di una narrazione che continua a scriversi, anche ora, anche qui. E Martina (con la sua tenacia gentile e il suo elegante procedere) ben riesce a compattare la densa complessità di questa massa critica.
Ma ciò che rende questo lavoro davvero prezioso è lo sguardo dell’autrice che lo ha curato, guidato, animato: uno sguardo paziente, appassionato e “atletico”, capace di attraversare i linguaggi della complessità con la varietà della ricerca qualitativa, con la profondità dell’ascolto, con il rigore di chi sa che ogni narrazione è anche un dire politico e una forma di conoscenza. È lì, in quel momento sospeso, che ci accorgiamo che ogni sguardo lanciato sul reale è anche un gesto di racconto, un modo per cercare senso, per ascoltare il mondo parlare. E questo lavoro saggistico collettivo non si accontenta della superficie: scivola oltre, si insinua tra le pieghe delle cose, e ci lascia intravedere — con la grazia necessaria delle verità parziali — il battito sommerso delle vite che attraversano il nostro tempo. Tra le pagine di questo libro, Martina Masullo compie proprio questo gesto: ricompone frammenti, accoglie visioni e ci invita a leggere il presente non come qualcosa da spiegare, ma come qualcosa da abitare — con attenzione, con immaginazione. E non è forse questo il dono più grande della conoscenza? Non la certezza, ma la capacità di restare in ascolto. Non la presa di posizione acritica ma la volontà di leggere il presente come un testo aperto, in continua evoluzione. Non un’idea di cultura “astratta”, ma uno spazio vitale in cui ciascuno di noi è lettore, autore, complice silenzioso di una narrazione che continua a scriversi, anche ora, anche qui. E Martina (con la sua tenacia gentile e il suo elegante procedere) ben riesce a compattare la densa complessità di questa massa critica.
Introduzione
di Martina Masullo
Una definizione di pop platform seriality
Quando nel 2011 Sergio Brancato – con una precisa riflessione verso i punti di rottura degli schemi di matrice novecentesca – inizia a parlare per la prima volta in modo sistematico di post-serialità come di un oggetto che ha subito una trasformazione tanto radicale da andare oltre se stesso e da non poter essere più chiamato con il suo nome abituale, fanno il loro ingresso nel panorama seriale contemporaneo alcuni prodotti che sarebbero diventati ben presto punti di riferimento fondamentali per le successive riflessioni sulla post-serialità. Il contro-immaginario distopico da cui attinge Black Mirror, la guerra ancestrale raccontata da Games of Thrones, il caos sociale e la matrice disfunzionale “sbattutti” sullo schermo da Shameless, lo stile gotico pop proposto da American Horror Story sono solo alcuni dei prodotti che hanno dato il via ad una vera e propria trasformazione della serialità che attraversa sia la forma che il contenuto. In bilico tra la trasparenza dell’immediatezza e l’opacità dell’ipermediazione, in un continuo ed incessante processo di rimediazione (Bolter e Grusin, 1999), a partire dalla seconda metà degli anni Novanta inizia a delinearsi la dimensione della post televisione. La TV è sottoposta ad una forza dirompente attraverso il digitale, dando vita ad un cambiamento epocale, uno spostamento della lente d’ingrandimento dai media di massa ai media digitali che spinge al massimo le dinamiche tradizionali e le inquadra in un nuovo tipo di fruizione, intima e privata anche se qualsiasi cosa diviene contenuto. È sulla scia di questo cambiamento che s’innesta la centralità delle piattaforme come elemento imprescindibile per tracciare il cambiamento attualmente in atto: un concreto e sistemico passaggio dalla post-serialità alla pop platform seriality che ripensa ulteriormente gli spazi della fruizione e adatta i modelli del passato alle estetiche ultra-pop (Bowman 2007, 2008; Reynolds 2011) della contemporaneità. La serialità oggi rappresenta una dimensione culturale, dinamica e ibrida, dove si sperimentano forme narrative nuove e dove si costruiscono visioni collettive del mondo. Non esiste più una forma univoca della narrazione seriale: oggi le serie sono dispositivi di senso, capaci di dialogare con la realtà sociale e di offrire forme identitarie praticabili. Nel panorama mediale contemporaneo, la serialità è diventata uno dei dispositivi narrativi e culturali più significativi per comprendere le dinamiche sociali, cognitive e produttive dell’età delle piattaforme. Lontana dal semplice intrattenimento frammentato della televisione lineare, la serialità oggi si configura come una realtà espansa (Prattichizzo e Gentile 2016), reticolare e stratificata, in cui forme narrative, pratiche di consumo e tecnologie convergenti danno vita a un ecosistema in continua evoluzione. È a partire da questo scenario complesso che si colloca la riflessione proposta in Pop Platform Seriality. Nuove esperienze di fruizione audiovisiva, un’opera corale che intende indagare le trasformazioni profonde e sistemiche della serialità nell’epoca post-mediale, mettendo in dialogo i contributi di alcuni tra i più autorevoli studiosi italiani del settore.
 Ma perchè parliamo di pop platform seriality? Perché le piattaforme (Netflix, Prime Video, Disney+ e le altre) sono ambienti di consumo e creazione culturale dove la cultura pop è diventata un vero e proprio strumento analitico, una fondamentale chiave interpretativa e non solo un contenuto. Questo processo impatta profondamente sulle nuove generazioni: le serie diventano dimensioni in cui cercare riconoscimento, linguaggi, emozioni condivise, ma anche legittimazione della propria identità. In particolare la Generazione Z non guarda solo una storia: la abita, la trasforma, la integra nel proprio vissuto e lo fa attraverso le piattaforme che diventano spazi di sperimentazione non solo nei contenuti, ma anche nella forma.
Ma perchè parliamo di pop platform seriality? Perché le piattaforme (Netflix, Prime Video, Disney+ e le altre) sono ambienti di consumo e creazione culturale dove la cultura pop è diventata un vero e proprio strumento analitico, una fondamentale chiave interpretativa e non solo un contenuto. Questo processo impatta profondamente sulle nuove generazioni: le serie diventano dimensioni in cui cercare riconoscimento, linguaggi, emozioni condivise, ma anche legittimazione della propria identità. In particolare la Generazione Z non guarda solo una storia: la abita, la trasforma, la integra nel proprio vissuto e lo fa attraverso le piattaforme che diventano spazi di sperimentazione non solo nei contenuti, ma anche nella forma.
Pop Platform Seriality nasce, dunque, come proposta teorica e analitica per leggere questo passaggio ulteriore dalla post-serialità alla sua declinazione contemporanea, marcata dalla logica delle piattaforme e dall’ibridazione tra culture pop, estetiche digitali e forme narrative modulari. Il concetto stesso di “platform seriality”, al centro del volume, vuole indicare non solo una nuova forma di narrazione, ma anche un nuovo regime di senso, in cui la serialità si sviluppa lungo traiettorie multiple: transmediali, algoritmiche, partecipative. In questo senso, le piattaforme si fanno archivi viventi, dove convivono e si contaminano format del passato, narrazioni ibride e micro-racconti frammentari, in un continuum mediale che riorganizza anche le nostre modalità percettive e cognitive (Ceccherelli e Ilardi, 2021). Non a caso, la serialità contemporanea viene vissuta e condivisa, oltre che fruita, trasformandosi in uno spazio in cui si costruisce — e si mette in scena — il sé digitale (Amendola, Barone, Troianiello 2019). I contributi raccolti in questo volume affrontano queste dinamiche da prospettive diverse ma complementari, offrendo una mappatura aggiornata e critica della serialità nell’era delle piattaforme.
Il sistema Netflix e le traiettorie future della pop platform seriality
Fondata il 29 agosto 1997, da Reed Hastings e Marc Randolph, inizialmente Netflix era un servizio di noleggio DVD online, solo successivamente entrerà a gamba tesa nel settore dello streaming on-demand. Arrivata poi in Italia nel 2015, Netflix ha completamente trasformato le logiche dello streaming, distrutto e ricostruito le tradizionali strutture della fruizione audiovisiva e modificato anche le pratiche e le abitudini dei pubblici contemporanei. Netflix si è configurata sin da subito come un polo attrattivo ambivalente, catalizzando al contempo timori e speranze: da un lato, ha suscitato le perplessità di coloro che l’hanno identificata come uno dei principali fattori della crisi dell’industria televisiva tradizionale e dell’intrattenimento nazionale; dall’altro, ha alimentato l’entusiasmo di chi ha intravisto nella piattaforma l’occasione per affrancare finalmente lo spettacolo dai vincoli della televisione generalista.
Dal punto di vista tecnico e commerciale, la forza di Netflix risiede in una combinazione sinergica di fattori: prezzi accessibili, un uso sofisticato dei big data, una spiccata attenzione alle esigenze dell’utente, una filosofia produttiva che privilegia la creazione autonoma di contenuti rispetto all’acquisto e una particolare sensibilità nell’interazione con la propria community. Questi elementi hanno reso la piattaforma un potente apparato culturale e sociale, capace di mantenere la propria centralità nonostante l’emergere di numerosi altri servizi di streaming.
Strumenti come il mese di prova gratuito (oggi non più disponibile), un sistema di profilazione algoritmica capace di proporre contenuti su misura in base ai gusti e ai comportamenti degli utenti, un’elevata qualità audiovisiva e la possibilità di fruizione continua hanno consolidato ulteriormente il dominio di Netflix nel panorama dell’intrattenimento digitale. (Marrazzo, 2016). Questo nuovo paradigma di fruizione ha contribuito a rafforzare fenomeni già esistenti e a farne emergere degli altri. Si pensi, ad esempio, al binge watching o al second screen. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la trasformazione della dimensione spazio-temporale dell’esperienza audiovisiva. Il tempo non è più imposto da una programmazione esterna, ma diventa una variabile soggettiva: la visione è ritagliata su misura, individualizzata, svincolata dalla rigidità dei palinsesti televisivi (time-shifted viewing). Accanto alla dimensione temporale, anche lo spazio si relativizza (place-shifted viewing): la visione non è più un’esperienza unitaria e continuativa, ma frammentata, spezzettata tra momenti e dispositivi diversi. Questa continua segmentazione riflette un cambiamento più ampio e profondo nel consumo mediale contemporaneo, che coinvolge non solo le produzioni Netflix ma anche i video veicolati attraverso i social network. Proprio i social media, infine, si configurano oggi come gli spazi privilegiati del dibattito e della rielaborazione collettiva dell’esperienza audiovisiva: non più semplici strumenti di socializzazione, ma luoghi di partecipazione attiva, in cui il pubblico interpreta, commenta e ridefinisce continuamente i significati dei contenuti fruiti.

Netflix rappresenta il punto di origine da cui si diramano le principali traiettorie dello sviluppo post seriale contemporaneo: dai processi di consumo al superamento del canone seriale, dal ripensamento delle audience al ripiegamento sui dispositivi come spazi di costruzione identitaria, dall’estetica delle piattaforme alla narrazione in frammenti offerta dai social network fino alla definizione di un nuovo possibile attraversamento della contemporaneità post-mediale e post network (Lotz, 2017). La serialità contemporanea si impone oggi come uno dei laboratori più vitali e polimorfi della cultura audiovisiva, un dispositivo narrativo capace di farsi catalizzatore di sperimentazioni trasversali nei più disparati ambiti del sapere e dell’esperienza. Uno spazio in cui si intrecciano processi educativi e immaginazione (Bluey), rielaborazione di sentimenti e memoria affettiva (si pensi a come Friends ha rimediato la nostalgia), rilettura letteraria e transmedialità (Bridgerton), riflessione etica e distopica sulla tecnologia (Black Mirror), esperienze multipiattaforma e contaminazioni crossmediali (si pensi ai casi italiani Mare Fuori e Un Professore), ibridazioni tra racconto e sound design (Mr. Robot e Stranger Things), rinegoziazioni politiche e simboliche tra passato e presente (M. Il figlio del secolo), riflessioni profonde su genere, sessualità e corpo (Sex Education) e auto-rappresentazioni di personaggi pubblici tra realtà e finzione (The Ferragnez)[1].
In questo scenario fluido e interconnesso, la serialità si trasforma in una vera e propria grammatica culturale del nostro tempo: un linguaggio in continua evoluzione che incorpora frammentazione, estetica del meme, pratiche transmediali e forme di narrazione identitaria. È attraverso le serie che oggi si riflette, si sperimenta, si racconta e si re-immagina il mondo. Non ci resta che continuare ad abitarlo.
[1] Il presente approfondimento sintetizza e rielabora i risultati di numerose ricerche condotte in collaborazione con il prof. Alfonso Amendola, le quali hanno esplorato in modo articolato le dinamiche e le trasformazioni della serialità contemporanea nei suoi molteplici ambiti culturali e mediatici: 1. Nuove modalità di fruizione della generazione Z: il cinema tra piattaforme e frammenti (2025), 2. Nuove generazioni e post-serialità. Un focus su Netflix e Twitch (2025), 3. The Bluey version. A cartoon between mediology, educational processes and imagination (2025), 4. L’immaginario nostalgico nelle serie TV: Friends e la rimediazione della nostalgia (2025), 5. Ai margini del canone seriale: post serialità e realtà espanse come nuovi spazi di fruizione (in pubblicazione), 6. Meta-mondi narrativi tra letteratura e post-serialità: i casi Penny Dreadful e Bridgerton (in pubblicazione).