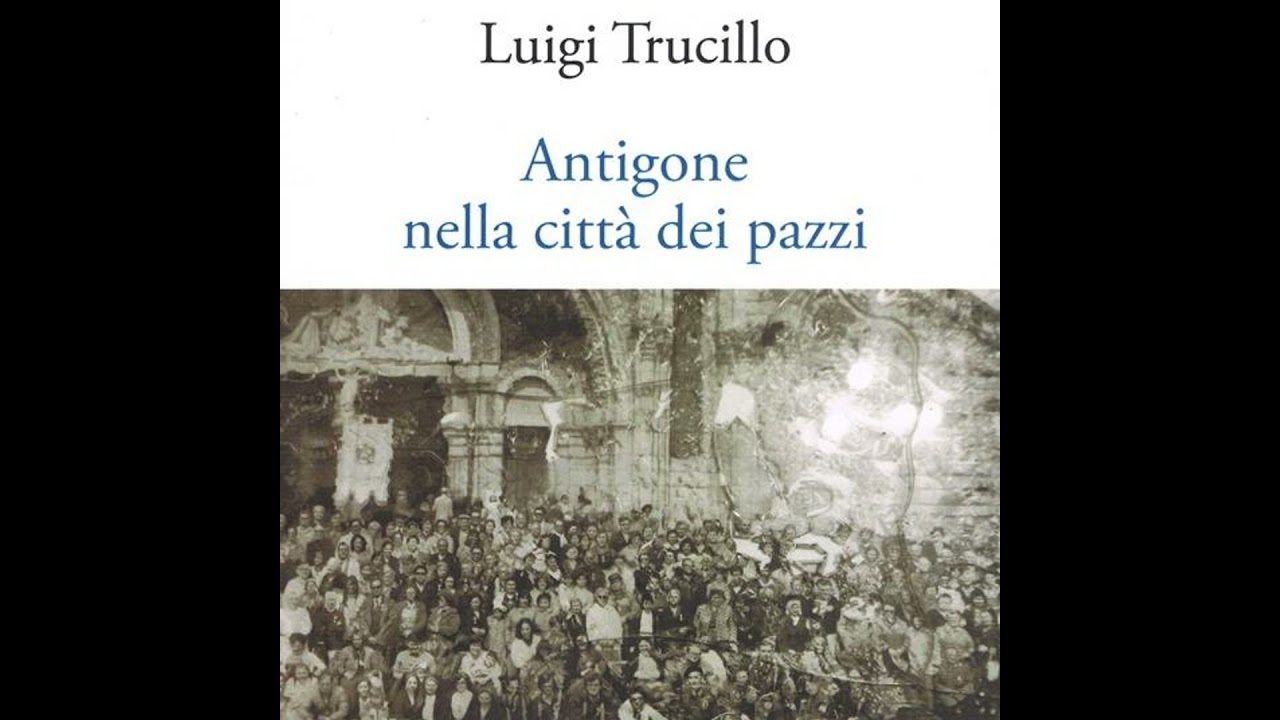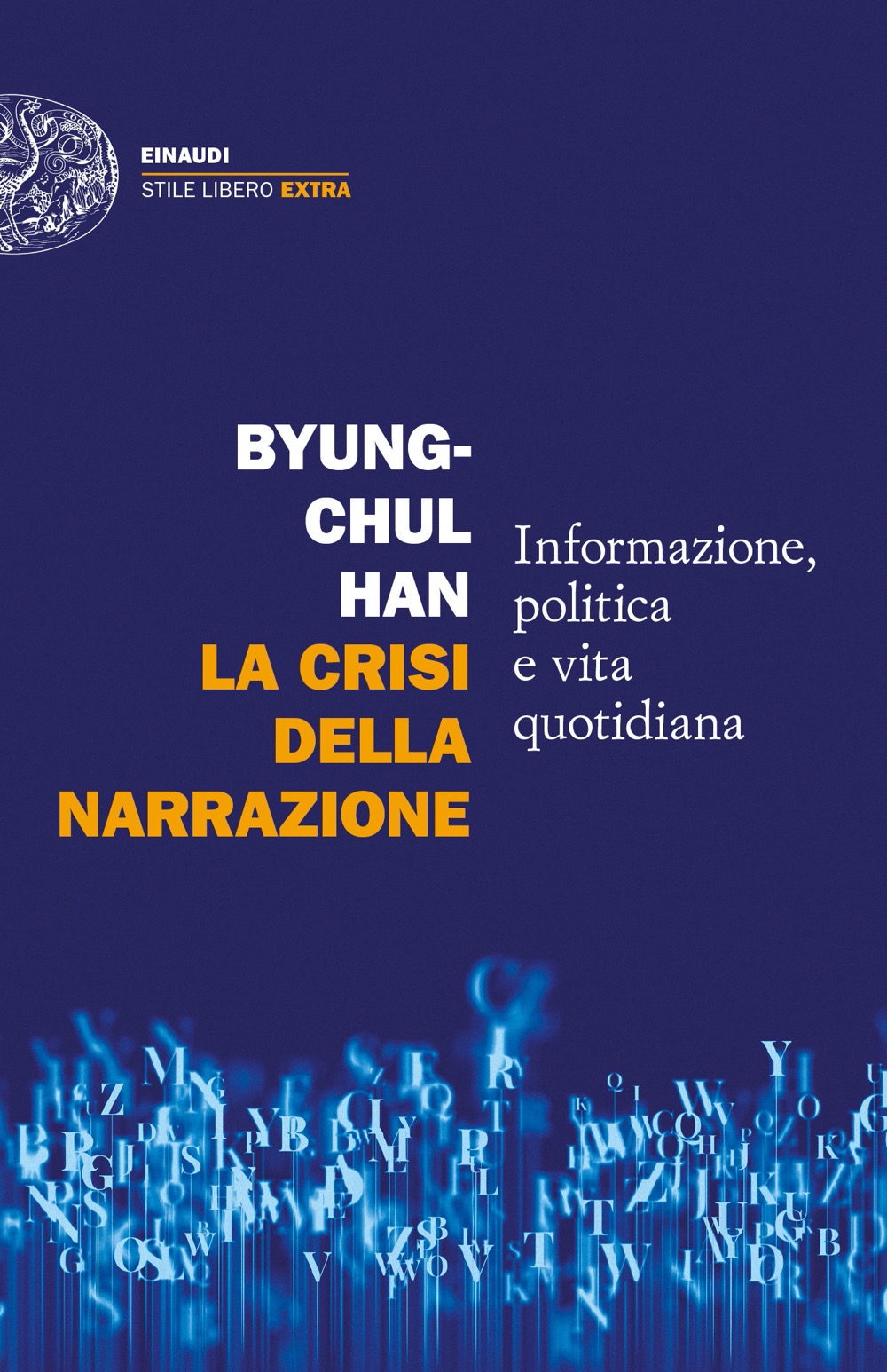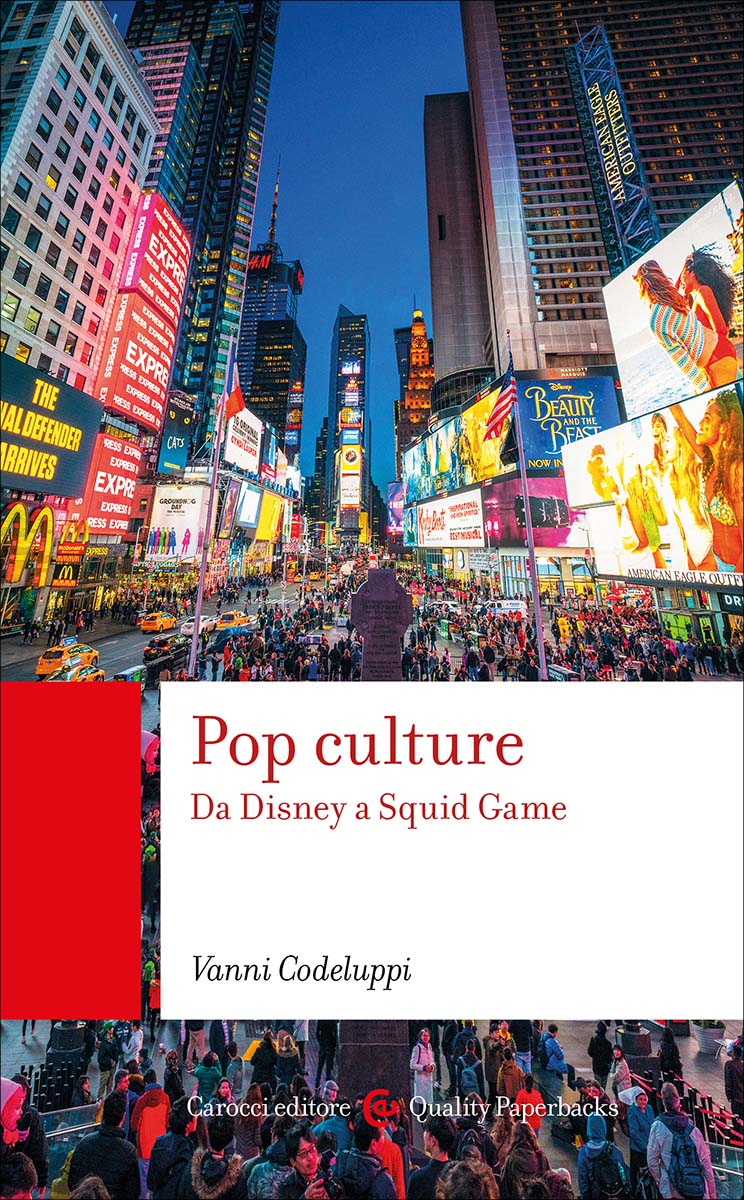Per George Steiner un ‘classico’ può dirsi tale solo quando è portatore di una “vera presenza”; rigeneratore di un “senso” che – oltre la lingua e al di là di rigide categorie letterarie – sappia offrire nuove interpretazioni. I classici e le figure della tradizione che li rappresentano, come Antigone – “Antigoni” è il titolo di uno dei saggi più belli di Steiner – diventano, perciò, nostri ‘contemporanei’, per forma e per contenuto, proprio perché ‘éternelles’, eterni. In questo solco di rigenerazione, tematica e formale, s’inserisce il poemetto “Antigone nella città dei pazzi” di Luigi Trucillo, stampato da Cronopio con una postfazione di Antonello D’Elia. Nel segno della ciclicità del mito, Trucillo lo rende ‘contemporaneo’ riscrivendo, in versi liberi, la tragedia antica sofoclea; adesso ambientandola in una nuova scena: a Napoli, tra gli spazi abbandonati del vecchio manicomio Leonardo Bianchi. “In questi calcinacci senza nome/ rullano i tamburi di una guerra/ scatenata dal terrore,/ ma ai confini dell’anima/ assedianti e assediati sono la stessa cosa”. Persistono le figure-funzioni classiche (il coro e Antigone) a cui s’affiancano nuovi personaggi e altre ‘voci’ narranti (le cartelle cliniche, il guardiano, i poeti): “Cartella n. 57.700. Mario. Sacca granulosa color arancio./ Uova di pesce femmina./ Sotto i parati o nelle federe/ i brusii sono ovunque,/ con il tuo timbro, timbro, timbro/ troppo acuto/ che pago ancora/ mentre si spacca in mille pezzi./ L’orecchio è una conchiglia/ che non ascolto./ Il riso nel piatto è una fatica./ Mi laverò ancora il tuo dopobarba/ dai capelli,/ mentre ci spiano”. Trucillo lavora molto sulla ‘sua’ lingua poetica, dosando il tono autorevole del dettato greco con una narrazione lirica contemporanea che è marcatamente dialogica e descrittiva. Da un lato si conserva, ad esempio, la funzione tradizionale del coro, tendenziosamente a commento delle vicende narrate: “Il male può sembrare un bene/ se gli Dei dell’epoca/ ti accecano la mente,/ e la struttura generale/ risolve tutto/ nella sua accelerazione stabilita./ Davanti a lei/ colo che tramano nell’ombra dei dubbi/ si tradiscono/ prima ancora di essere scoperti”. In direzione opposta, la voce, straniante e attualizzante, di Antigone che – protagonista-narratrice tra le rovine della “città dei pazzi” – dà un nuovo significato al testo originale; lasciando sempre, in chiaroscuro, la riconoscibile ombra della forma classica tragica. “E allora pietà per me, Antigone,/ che sento le voci smarrite/ dagli errori della legge/ come fossero spoglie/ a cui nessuno offre il riparo della polvere/. Io ho forgiato con le mie visioni/ un’indole troppo decisa e pura/ che m’imbriglia in una sola storia/ Con un grido animale/ inevitabilmente/ le belve ci aspettano nel buio/ per definire le nostre cicatrici,/ e perfino nelle ore quiete/ di una vita anonima/ ogni gesto aspetta/ che gli appaiano due vite./ Però nessuno può davvero fare sua/ un’azione che avverte straniera”.